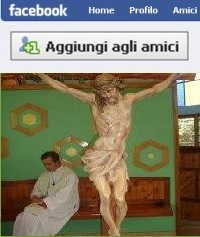Una Vita per la Missione
Tecniche avanzate di animazione (Don Alessandro Manenti - 05/04/2009)
31.03.2014 16:06
(I paragrafi in corsivo riportano gli interventi)
Iniziamo facendo una brevissima carrellata per ricordare dove eravamo rimasti l’altra volta.
Eravamo partiti chiedendoci “Qual è la fisionomia di un gruppo cristiano formativo ?”. Avevamo detto che la sua fisionomia non è quella di essere un gruppo terapeutico o sociale d’incontro, ma un gruppo nel quale delle persone vogliono aiutarsi per vivere meglio i valori cristiani, per vivere meglio il rapporto con Gesù Cristo o la legge fondamentale del cristianesimo: amare come Gesù Cristo ama. Questo è l’aspetto di trascendenza del gruppo cristiano.
Poi avevamo detto che di conseguenza il gruppo cristiano alle persone chiede di accettare questa mentalità di vita paradossale, secondo cui più una persona accetta di uscire da se stessa, di donarsi e di perdersi, più quella persona ritrova se stessa, la sua identità umana e cristiana. Il gruppo per quest’obiettivo offre degli strumenti per educare la coscienza intesa non tanto come l’applicare principi e precetti, quanto invece il riflettere su quali sono i punti d’osservazione dai quali noi partiamo per giudicare e per prendere delle decisioni. L’obiettivo è quindi formare delle persone dalla coscienza cristiana, che esercitano poi questa coscienza non solo all’interno del gruppo ma anche al di fuori. Il gruppo cristiano è per sua natura un gruppo che muore in quanto forma testimoni cristiani destinati a portare la loro testimonianza al di là e al di fuori del gruppo.
Il gruppo tratta gli argomenti in base al contenuto, ma vuole anche vedere come le persone impostano la loro vita.
L’argomento di questi incontri sono i giovani e quali porte di accesso si possono trovare nel mondo giovanile per raggiungere l’obiettivo di formare una coscienza cristiana.
Come noi adulti o la persona cristiana in genere affrontiamo i giovani e come ci rapportiamo, in qualità di educatori, al mondo giovanile.
Lo possiamo vedere da come noi commentiamo i fatti del mondo giovanile, dai più semplici a quelli più eclatanti che ci mostra la televisione. Se osserviamo bene, a volte facciamo sul mondo giovanile un primo commento che è di carattere morale: vedendo nel giovane o nell’adolescente dei comportamenti che non sono ortodossi, non sono la traduzione del messaggio cristiano “amare come Gesù Cristo ama” ma sono comportamenti “trasgressivi”, una delle nostre reazioni, non solo di preti ma anche di laici formati, si potrebbe tradurre nella frase “I giovani di oggi sono cattivi, sono egoisti, non hanno il senso del sacrificio, pensano solo a se stessi e a divertirsi”. In sostanza si tratta di un commento che interpreta le intenzioni, in questo caso “cattive”, della realtà giovanile. Questa è la prima fotografia che facciamo del mondo giovanile quando noi vediamo che non accede immediatamente al messaggio cristiano. L’altra osservazione che noi facciamo è psicologica, ad esempio: “Oggi i giovani sono fragili, hanno delle insicurezze, non hanno un’identità, hanno paura della realtà e del mondo”. Le sensazioni di carattere morale e di carattere psicologico sono in realtà molto simili in quanto presuppongono che il giovane di oggi dovrebbe seguire i princìpi morali e religiosi o dovrebbe seguire i criteri di maturità che anche loro hanno dentro di sé: sono quindi trasgressori di un credo. Presupponiamo che la loro mentalità, il loro modo di vivere, di ragionare, di usare la coscienza dovrebbero essere uguali ai nostri. Siccome questo non accade i giovani sono cattivi, trasgressori ed egoisti. Si presuppone che il punto di partenza sia, o almeno dovrebbe essere, un accordo su ciò che vale nella vita, su ciò che è vita beata, su ciò che vuol dire successo, fallimento, amore … Siccome poi nella pratica questo accordo non lo troviamo, diciamo loro: “Vedi, tu invece di fare quello che dovresti fare, vai fuori strada perché sei cattivo o perché sei debole. Il presupposto di queste due interpretazioni è “I giovani dovrebbero ragionare e invece non ragionano, dovrebbero riflettere ed invece non riflettono”. In sostanza dovrebbero usare gli stessi strumenti antropologici che usiamo noi per misurare quello che è buono e quello che è cattivo, quello che è giusto e quello che è ingiusto. Siccome non lo fanno, allora puntiamo il dito. Perché queste due letture lasciano un po’ perplessi ? Il presupposto, che poi non si realizza nella realtà, è che ci dovrebbe essere un’antropologia condivisa, lo stesso modo di interpretare e vivere il mondo. Ma oggi questa antropologia comune non c’è più, e questo è il problema formativo di oggi. Parliamo con persone che hanno un altro modo di definire i criteri fondamentali del vivere. Non è che trasgrediscono a quello che hanno dentro e quindi disobbediscono ad una voce interiore, hanno un altro vocabolario, un’altra modalità di descrivere la vita, definire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che vale la pena e ciò che non vale la pena di fare. Esempio: Eravamo in una scuola superiore a parlare dell’altruismo che fa parte della nostra antropologia (amare l’altro come noi stessi). Per far capire il concetto di altruismo prendevo l’esempio dei missionari che vanno in terra di missione per fare un servizio d’amore ai poveri, addirittura a costo della vita: a volte dai telegiornali veniamo informati che alcuni di questi missionari vengono uccisi. Si tratta quindi dell’esempio massimo dell’amare un’altra persona: affermazione antropologica cristiana che penso noi tutti condividiamo. Un ragazzo si alza e dice. “Scusi, ma perché ci sono andati ? Problema loro !”. Quello che per me è testimonianza, per qualcun altro può apparire come stupidaggine. Altro esempio: la coppia in crisi. “Siamo in crisi e non ci vogliamo più bene. Quindi, se non ci vogliamo più bene, ci separiamo”. Sembra logico. Ma questo non è il messaggio cristiano, che invece dice: le difficoltà ci sono, ma in quanto nel sacramento ci siamo promessi “nella buona e nella cattiva sorte”, quando c’è la cattiva sorte noi la affrontiamo forse anche come occasione per rinnovare il nostro amore, perché è importante la fedeltà e l’indissolubilità. Lavorando con i giovani, questi mi dicono: “Ma quella che lei ci consiglia non è fedeltà, ma essere bugiardi l’uno con l’altra. Noi per onestà ci separiamo”. Questa antropologia non è una teoria, ma il modo immediato di reagire ai fatti della vita. Poco tempo fa ero andato con dei ragazzi fra i 18 e i 25 anni a fare 2 giorni nella casa in montagna della parrocchia. Pioveva e, volendo andare a fare un giro, avevo proposto di andare a prendere il mio ombrello che doveva essere in macchina. Purtroppo non c’era ed allora, rivolgendomi al ragazzo che voleva uscire, dico “Ce l’avrai tu, l’ombrello”, e lui: “No, ho guardato, ma mia mamma non l’ha messo nella valigia”: per lui era normale che, a 23 anni, fosse ancora la mamma a fargli la valigia. Questa è l’antropologia: vado ad affrontare un ambiente nuovo e come mi attrezzo ? non ce n’è bisogno, perché è la mamma che ci pensa. Al di là dell’episodio, questa è la logica di vita: un giorno questa persona dovrà affrontare delle difficoltà, aprirà la valigia che altri avrebbero dovuto riempire, non troverà niente e cosa farà ? Questo ragazzo può essere anche cristiano, ma con questo principio antropologico cosa succede ? Si illude che Dio sia quello che riempie la valigia, mentre noi sappiamo che Dia ci dà la forza perché noi, col suo aiuto, riempiamo la nostra valigia. Quando arriverà la pioggia, verificando che Dio non ha riempito la valigia, andrà in crisi (potremmo dire finalmente !). Questi piccoli episodi vi fanno vedere come ci troviamo di fronte ad un modo di impostare la vita che è diverso. Grazie a queste difficoltà, quello che per noi è segno di immaturità, per la loro antropologia è del tutto logico, e sarebbe strano se non ci fosse. E’ lineare. Noi diciamo che i giovani oggi sono confusi: non sono confusi, sono coerenti con se stessi secondo la loro antropologia. E’ il punto di partenza che è cambiato, per cui cambiano anche le conclusioni. Dobbiamo quindi riconoscere che i giovano sono persone che ragionano, solo che partono da premesse che sono diverse. Facendo un confronto con l’antropologia cristiana, possiamo dire che il problema di oggi non è un problema etico, morale e nemmeno psicologico, ma un problema di visione di vita che per la nostra antropologia cristiana è una visione di vita un po’ stretta. Allora il mondo giovanile di oggi, o almeno una parte, rivela una piccolezza di cuore e di mentalità. Da questa mentalità “piccolina” discendono scelte “piccoline”, comportamenti “piccolini”. Mi viene in mente il film “Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi”: la macchina del padre che rimpiccioliva gli oggetti, ha colpito con il suo raggi i figli che si sono rimpiccioliti e si sono persi con gli insetti nel giardino. Il giardino da luogo di gioco (il mondo come luogo di pace e di realizzazione), è diventato un luogo di minaccia dato che rischiavano di essere tagliati dal tosaerba del padre. Ci troviamo di fronte ad una povertà, ad una ristrettezza del cuore; se il cuore è ristretto, evidentemente funziona con criteri che son ristretti. Ma li vediamo noi ristretti, in base alla visione cristiana. Quando i criteri sono ristretti gli occhi si rimpiccioliscono, cioè della vita e della realtà noi riusciamo a cogliere solo dei pezzi, perdendo la visione d’insieme. Quando diciamo che i giovani hanno la cultura dell’immediato, questa non è un’interpretazione psicologica e morale: si tratta di una conseguenza. Se mi metto nell’ottica che sia normale che la mia valigia la prepari la mamma, io rimarrò un mammone, ma il fine ultimo della vita diventa un po’ un problema. Se rimango legato ai dettagli, alla cronaca, la vita non parla più, dato che la cronaca è sempre la stessa “minestra”. La vita non dà più informazioni affettive, perché non la vedo nel suo insieme; quando vedo solo i dettagli, la vita annoia. La vita non riesce più a suscitare degli affetti che non possono venire dai dettagli, quali ad esempio la meraviglia, lo stupore, il desiderio. La vita comincia a parlare un po’ meno e le soluzioni che quell’occhio piccolino dà ai dettagli della vita saranno altrettanto piccole. Non si tratterà più di pensare a cosa faccio della mia vita, ma saranno soluzioni tecniche che servono nell’immediato, per cui il cuore comincia ad atrofizzarsi. Ma questo lo possiamo vedere alla luce di come è destinato il cuore umano secondo il messaggio cristiano: amare come Gesù Cristo ama. Cos’è che allora, in questo cuore ristretto, trova difficoltà a ricevere delle risposte che non siano risposte immediate? Fanno difficoltà le risposte alle domande fondamentali che il cristiano si fa, anche se non esplicitamente: sono risposte alle domande di fondo che costituiscono la sua coscienza cristiana. A queste domande però non si riesce a dare che una risposta “piccolina”. Quali possono essere le domande di fondo che costituiscono una coscienza cristiana ? Senza andare a scomodare la teologia, possiamo ridurle a 4 domande di fondo, corrispondenti ad altrettante esperienze di vita, che la coscienza cristiana prima o poi si pone. La prima domanda di fondo sulla quale funziona la coscienza cristiana è “Noi siamo persone libere “ – cioè abbiamo un futuro che creiamo noi – “o siamo persone determinate, spinte da dietro ?”. Chi comanda nella mia vita ? Comando io e la progetto come pare a me dandole dei fini, oppure mi trovo in una situazione già fatta che poi mi porta a certe conclusioni ? Un’altra domanda di fondo della coscienza cristiana è la domanda del ‘perché’: “Che cosa mi motiva ad agire ? Cosa mi mette in movimento ed accende il mio cuore ?” La terza domanda è: “Qual è il fine che mi prefiggo e cosa voglio ?” La quarta domanda è “Cosa vuol dire essere realizzati, sentirsi vivi ?” Queste sono domande fondamentali perché la risposta costituisce proprio la mentalità di vita del cristiano. Il cristianesimo dice che noi siamo esseri liberi per scegliere (se vuoi, vieni e seguimi …) un bene che sia di vita, possibilmente il bene massimo: amare come Dio ama. Se noi siamo presenti alla vita, queste domande, tramite la cronaca, saltano subito fuori; queste domanda, suscitate dalla vita, immediatamente richiamano l’attivazione della coscienza cristiana. La vita poi si incarica di offrirci una o l’altra domanda a seconda degli episodi che si verificano nella nostra esistenza, piccoli o grandi. Anche voi potete vedere episodi della vostra vita concreta dietro ai quali la vita vi interpella. In base a quello che ti succede, tu sei libero o sei spinto ? Noi non ce lo diremo così chiaramente, però dovremo rispondere. Ho un figlio, ma il figlio mi è capitato o l’ho voluto ? Ma non tecnicamente. Lo dobbiamo sopportare oppure lui è così, mi dà fastidio che sia così, ma se non fosse così lo farei così. A seconda della risposta che noi diamo a queste 4 domande di fondo, allora avremo un certo modo di agire. Non dovremo stupirci del modo di agire, perché è la risposta a queste domande che cambia: data una certa risposta ne derivano determinate conclusioni. Esempio: una moglie, a fronte di bollette telefoniche cospicue, fa osservazione al marito appassionato di Internet e delle sex lines; il marito risponde: “Che problema c’è, non faccio niente di male, Quando scatta la voglia di sesso non si può resistere; poi con queste chat lines si crea un’atmosfera ambigua che è particolarmente eccitante. In quelle conversazioni anonime si può dire quello che si vuole, anche quello che nella vita non si direbbe mai: è un modo bellissimo, comodo, di conversare senza compromettersi. Le chat lines sono attraenti e sarà strano se questa sera non accenderò il computer per collegarmi a quei siti.” Se quel soggetto si dicesse “Io sono un essere libero”, per scegliere un bene che sia totale incomincerebbe non dico a sentirsi in colpa, ma a vedere meno attraente, meno simpatico, meno desiderabile questo modo di agire. C’è quindi un cuore un po’ ristretto, un po’ rattrappito e bisognerebbe che questo cuore venisse di nuovo invaso da affetti, da emozioni, da energie che lo spingano ad osare di più, a rischiare di più. E questo non si può attuare dal di fuori, anche se si possono fornire degli strumenti. Cosa vuol dire lavorare sull’antropologia e non sugli esiti comportamentali ? Come proponiamo il messaggio cristiano ? Che tipo di contatto vorremmo creare fra il messaggio cristiano e la interiorità del soggetto, che forse è un’interiorità un po’ povera ? Se è un cuore ‘ristretto’ penso che una pista di risposta sia presentare il messaggio cristiano come un messaggio di superiorità, cioè alzare il tiro della nostra proposta. Il messaggio cristiano è un messaggio che non ha tanti concorrenti nel rispondere alle domande che la vita pone: questo messaggio offre delle risposte di garanzia. Il soggetto, forse, rispetto a quel messaggio rimane indietro perché ha un cuore piccolo. Questo a volte capovolge il modo con cui noi presentiamo il messaggio cristiano, che non è nella sua sublimità: il nostro modo è ‘tirar dietro’ alle persone il messaggio cristiano, darglielo a tutti i costi. Il nostro metodo, se ci pensate bene, non è il rispetto della grandezza del messaggio, quel metodo che dice ad un giovane “Guarda che la vita non è un computer, non funziona perché tu hai trovato il tasto giusto e se non lo trovi si blocca: la vita è un giocattolo un po’ più complesso e se non lo tratti con cura, cioè nella sua visione globale, c’è il rischio che il giocattolo si rompa. Ma poi è difficile aggiustarlo.” Ecco la sublimità del messaggio cristiano, che tiene in considerazione proprio questa delicatezza e grandezza anche della tua vita, che non è una macchina ma un mistero, quindi non richiede risposte tecniche, ma risposte che garantiscano che la sai affrontare. In questo la risposta cristiana è qualitativamente superiore, cioè ti dà delle garanzie. Il nostro metodo è invece “tirar dietro”, specie ai giovani, il messaggio cristiano, con l’effetto che i giovani se ne vanno, o rimangono ma solo per giocare a fare i cristiani. La nostra preoccupazione è attirare i giovani e per questo dobbiamo trovare tutte le tecniche; per attirarli quindi li prendiamo nel loro punto debole, intercettando cioè i loro interessi. Ma quelli sono gli interessi del cuore piccolo, non gli interessi del “Voglio capire cos’è la vita”; si tratta degli interessi della musica, della moda, dei temi del bullismo, della violenza e di tutti gli argomenti che possono interessare il giovane nella speranza che “abbocchi”. Una volta che ha abboccato gli “tiriam dietro” il messaggio cristiano, cioè gli diciamo “Però fai a modo”. Pensiamo che intanto son venuti ed una buona parolina gliela possiamo sempre dire; diciamo “I giovani d’oggi seguono Internet, i reality … ma in fondo sono buoni, alla fine hanno ancora una religiosità, perché l’essere umano ha una religiosità che è interiore.” Pensiamo che siano deboli e si dimostrino cattivi, ma che la domanda religiosa oggi sia in loro ancora attiva. Ma di che domanda religiosa attiva si tratta ? Se l’occhio è piccolo e il cuore è piccolo, come sarà mai la domanda religiosa ? Speriamo che Dio li aiuto, perché ci si aspetta che sia Lui a metter loro l’ombrello nella valigia. Ma il punto di partenza della domanda religiosa cristiana è un altro: amare come Gesù Cristo ama e perdere la propria vita per ritrovarla. Noi dovremmo passare in esame il tipo di risposte che diamo ai giovani, perché se loro hanno il cuore piccolino e ci fanno delle domande povere, le nostre risposte a volte non sono meno povere delle domande che pongono; da questo loro saranno indotti a porre domande ancora più povere. E’ un circolo vizioso al ribasso. Il messaggio cristiano deve scioccare, rompere questa povertà; deve essere un messaggio che mette salutarmente in crisi, facendo comprendere che la vita non è piccola come si può pensare e che forse c’è qualcosa di più da esplorare. Quella crisi mi mette in viaggio facendomi intuire che la vita è un “pozzo di Sano Patrizio” per cui è bene che io ne goda maggiormente, ne approfitti di più anzichè fermarmi ai dettagli. Noi invece prendiamo il giovane e lo intercettiamo nelle sue cose “immediate”, dettagli sui quali lui comunque non fonda la sua vita (oggi ama un tipo di musica, domani sarà interessato da un altro); lo intercettiamo sul poco, diamo la risposta su quel poco per cui le nostre risposte sono povere, lui rimane nel suo ambiente e per la sua vita non farà riferimento al nostro messaggio, ma ad altri. Prendiamo il ragazzo nel suo tempo libero, non nei tempi seri quando lui si gioca la sua vita. Noi dobbiamo trasmettere il messaggio nella sua sublimità, non per tirar dentro le persone o per dare un messaggio a cui le persone debbano rispondere, ma un messaggi che pone delle domande sulla vita, delle domande di garanzia. Tralasciando le risposte cristiane, le risposte che il ragazzo troverà da altre parti sono inferiori. Ma noi formatori ci crediamo alla sublimità di queste verità cristiane ? cioè che la vita è veramente vita quando la perdo … Certamente noi tutti, ed io per primo, crediamo a queste verità, ma questo cosa comporta ? Noi ci crediamo perché sono verità logiche, plausibili, verità che si possono sostenere ma non superiori, sublimi, grandi: sono verità che possono stare alla pari di altre, perché ognuno la pensa come vuole. Non su quelle quindi si gioca il buon esito della vita; sono verità alle quali uno crede se ha fede. Sono vere nel senso che sono coerenti, ma non sono così vere da essere prese come quelle che descrivono il funzionamento della vita concreta. Queste verità mi dicono “La vita dovrebbe funzionare così, perché se non funziona così si ‘ingrippa’ ”. Questo è un altro modo di vivere le verità cristiane, sublimi perché mi descrivono come funziona la vita buona, la vita di realizzazione. Le altre risposte danno anche loro un esito, una bontà, una realizzazione, ma non è esattamente la stessa. Un esempio. Un prete seguiva due fidanzati per il matrimonio: uno dei due andava in chiesa, l’altro no e avevano deciso per la convivenza. Parlando di questa scelta quello che non andava in chiesa diceva: “Io non sono praticante, non credo e quindi ritengo che la relazione debba iniziare per prova, per cui noi proviamo e poi vedremo”. Questo prete, sentendo che non poteva far appello alla fede, non sapeva più cosa dire. Perché per noi certi valori (fedeltà, indissolubilità, …) sono importanti ? Forse perché la dottrina cattolica insegna così ? Non per questo, ma perché questi valori garantiscono il buon esito della vita umana, perché permettono delle esperienze affettive di unione e di intimità che altrimenti non si raggiungono. Sono valori che funzionano per la vita, sono parole di vita, quindi significa che la vita deve funzionare di più. La persona può anche lasciarli da parte, cioè non ragionare secondo l’ottica della donazione totale ‘nella buona e nella cattiva sorte’, però dovrebbe anche mettere in conto, rispettando la persona, che escludendo certi orizzonti la vita si impoverisce. Allora le persone non è che le terrorizziamo, le responsabilizziamo. Cosa pretendo dalla vita ? quali sono le condizioni migliori per le quali anche la nostra convivenza possa funzionare al meglio? Vedete allora come il messaggio cristiano non risponde all’oggi, ma dà il fondamento, la roccia sulla quale fondare la nostra casa. Credere a queste verità non equivale ad una scelta dogmatica e fondamentalista come hanno certi movimenti (Opus Dei, Legionari di Cristo) che ‘partono in quarta’ ed avanzano come carri armati e di fronte ai quali tu ti senti sempre peccatore. Bisogna sapere che un cuore piccolo funziona come tale, ma non è fatto per essere piccolo, per cui la persona, pensandoci bene, capisce che questa richiesta di garanzia è proprio quello che cercava. Se questo discorso funziona, il formatore chiede al gruppo e agli individui quali sono le domande fondamentali che questi giovani si stanno ponendo. Ad esempio, in un periodo di crisi economica quali sono le domande di fondo che si pone un giovane di 18 anni ? Se anche ha il cuore piccolino, il giovane, di fronte a queste domande, comincia ad allargare il cuore. Un altro intervento che allarga il cuore è l’aiutare il giovane ad uscire dal suo mondo piccolino, facendogli vedere che il mondo è più grande e non corrisponde al suo piccolo mondo. Un’immagine come esempio: una classe di ragazzi, durante una gita scolastica a Roma, va a visitare il Pantheon; mentre l’insegnante spiega ottenendo l’attenzione di un paio di ragazzi, tutti gli altri danno le spalle al Pantheon e messaggiano con i loro telefonini; quando fanno foto, non fotografano il Pantheon, ma si fotografano fra di loro. Ma perché sono venuti a Roma, cosa hanno visto ? Questo non succede perché sono cattivi, ma perché il loro mondo è così, è piccolino. Uscire dal tuo mondo per capire che esiste un mondo più ampio, ti ‘attrezza’, ti obbliga a riempire personalmente la valigia e a metterci l’ombrello: nel nostro mondo non piove, nell’altro forse sì …
C’è qualcosa che mi sfugge in questo ragionamento riguardo il messaggio ‘eccellente’. Queste cose che lei sta dicendo adesso me le diceva l’altro giorno mio figlio, ma a rovescio, nel senso che era lui che mi diceva “Tu, fra il tuo lavoro e i cappuccini vedi tutto il mondo. Guarda che il mondo non è tutto lì, nel mondo c’è altro !” e mi proponeva il suo: vita di strada, non fare niente … Certo che il messaggio eccellente di fronte a questa cosa … Io da un po’ ho smesso di proporre verbalmente: continuo a fare le cose in cui credo e lui non può far altro che guardarmi e risolvere i suoi problemi quando mi viene a chiedere aiuto. Io non capisco bene il discorso del messaggio eccellente.
Lei è preoccupata per le suo cose e suo figlio le dice “Guarda che il mondo non è quello lì: c’è un altro mondo !”. Lei dice che basta la testimonianza e continua a credere nei suoi valori perché vanno bene, ma vanno bene a lei e non a suo figlio. Noi crediamo a questo valori perché ‘suonano bene’ per noi, non perché fanno funzionare la vita. Se lei non prende suo figlio proprio lì, nelle proposte di vita, i suoi valori moriranno con lei. Il ragionamento di suo figlio è di una serietà enorme: sotto l’apparenza di un discorso piccolino lui le sta mostrando tutta la sua vita. Le sta chiedendo “Come posso impostare tutta la mia vita ?”, il resto fa parte del suo essere adolescente. “Cosa mi motiva: il lasciarmi andare e divertirmi o altre mete ?”. Perché non provare a metterlo nelle condizioni per cui questa sua intuizione venga sempre più messa a fuoco, dal momento che è sulla strada giusta ? Vale la pensa provare a dargli qualche messaggio che lui è stato serio perché si sta preoccupando di tutta la sua vita e non solo delle piccole cose di cui lei si preoccupa e forse si può dargli qualche imbeccata circa il fatto che il messaggio cristiano risponde forse proprio a questa sua tensione, a tutta la sua vita e non ad un dettaglio. E che c’è un messaggio che ha qualcosa da dire su quello che in questo momento gli interessa. Se poi riuscissimo a trovare alcuni aspetti del messaggio cristiano che fanno al caso suo, allora sarebbe il massimo. Per capire le domande che il ragazzo si pone noi potremmo anche chiederci “Dio che cosa può avere a che fare con la vita di queste persone, con le loro preoccupazioni ? come le legge, come le interpreta, come risponderebbe ?. Cosa vuole oggi Dio da una persona che sta guardando tutta la sua vita ? “ Relativizziamo la soluzione che il ragazzo si dà, ma teniamo per seria la domanda dal momento che capisce che la sua vita non è un giocattolo; favoriamo le esperienze che possono farlo uscire dal suo mondo piccolino per delle esperienze sfidanti Anche il gruppo deve porsi come obiettivo di fare questo tipo di esperienze, che tengono aperta questa consapevolezza di aver danti tutta la vita; le esperienze sfidanti sono quelle per le quali devo far ricorso a tutte le mie forze, quelle che mi obbligano a far vedere di che pasta sono fatto, a far uscire le mie risorse: se la mamma non mette l’ombrello nella valigia ed il figlio fa la valigia da solo, quando piove e non ha l’ombrello lui si ritrova lì per conto suo e la prossima volta si ricorderà l’ombrello. Da sfidato tira fuori delle energia che non aveva mai usato. Le esperienze di solitudine sono esperienze sfidanti nelle quali l’adolescente è solo; c’è una solitudine che soffoca, ma ce n’è una che dice “A questo punto ti devi “tirar su” i pantaloni da solo” Il gruppo può aiutare a fare delle esperienze sfidanti, quando non è un gruppo ‘nido’. E’ per questo che dicevamo che il gruppo deve essere aperto e si interroga dove possiamo trovare Dio nel mondo di oggi. Per allargare questo cuore occorrono esperienze che permettano ai giovani di narrarsi e narrare agli altri ciò che hanno scoperto della vita da queste esperienze sfidanti. E allora perché non proviamo a parlarci della nostra vita a questo livello, narrandoci cosa stiamo scoprendo del nostro essere e facendo festa per quello che si è trovato; ovviamente non una festa da discoteca, ma una festa fatta perché una ricerca ha dato un esito e possiamo dirci “Siamo stati bravi” e quindi abbiamo il diritto di brindare “al merito”.
Intervallo
Prima di ricominciare riassumo il messaggio che vorrei proporre e che consiste nell’analizzare come noi interpretiamo e sentiamo il mondo dell’adolescente o del giovane. Quando parliamo di un mondo piccolo e di un cuore che si è rattrappito intendiamo comunque mandare un messaggio di fiducia nei confronti del mondo giovanile: dire che il cuore è rattrappito significa riconoscere che non funziona come dovrebbe e potrebbe funzionare, quindi non diventa un’accusa o una critica ma è il riconoscimento che in quel mondo ci sono delle energie, delle domande che però non trovano spazio per esprimersi, per cui rimangono domande inespresse che poi sta a noi andare a cogliere in cosa consistano. Oggi il formatore, così come il genitore, deve fare un atto d’amore assolutamente gratuito nella formazione delle coscienze, perché noi, facendo leva sulla sublimità del messaggio cristiano, siamo chiamati a dare delle risposte che noi non avevamo bisogno di darci. Se accettiamo l’ipotesi che i giovani partano da presupposti diversi, occorre fare un lavoro formativo a loro servizio esclusivo, perché di quel lavoro formativo noi non ne abbiamo necessariamente bisogno. I presupposti della vita cristiana noi non avevamo bisogno di esplicitarli, perché noi abbiamo vissuto in un ambiente nel quale questi presupposti venivano dati quasi per scontati e non c’era bisogno di personalizzarli. La domanda “Ma chi me lo fa fare ?” noi forse non ce la siamo posta all’inizio del lavoro, perché attorno a noi tutti lavoravano e c’era un ambiente che aveva un certo consenso a riguardo dei valori e quindi non dovevamo porci queste domande esistenziali. Oggi il giovane si trova da solo a porsi queste domande estremamente importanti, e gli mancano i modelli di riferimento; a cosa si attacca quando si pone queste domande forti ? Pensiamo ad un giovane che dica “Io voglio bene alla mia ragazza”. Cosa vuol dire che vuol bene alla sua ragazza ? Ha tanti modelli diversi fra di loro: lui guarda i modelli di relazione delle persone che vivono nel suo condominio o nella sua strada e comincia a contare quanti modelli di relazione ci sono. Sono infiniti. E allora qual è la risposta di garanzia ? Siamo chiamati ad un tipo di amore che è estremamente oblativo e allora oggi, nella formazione, diventa estremamente importante chiederci con che tipo di amore amiamo i nostri figli o i nostri ragazzi. E’ un amore che corrisponde a ciò di cui loro hanno bisogno o un amore secondo le nostre categorie ? Forse li amiamo prendendo come fonte d’ispirazione per questo amore la nostra interiorità, ma forse l’amore di cui essi hanno bisogno non è lo stesso, è un amore che deve corrispondere alla loro interiorità, è un amore che serve a loro e non quello che suona bene a noi. Può essere anzi che l’amore che serve a loro a noi suoni non tanto amore. Per la madre che mette l’ombrello nella valigia del figlio, quello è amore in quanto soddisfa il suo cuore di mamma e non la possiamo giudicare, ma quell’amore è veramente quello di cui suo figlio ha bisogno ? Forse no, perché quell’amore fa crescere la mamma e non il figlio; ma allora bisogna trovare il tipo di amore che corrisponde alla situazione del ragazzo, anche se la madre potrebbe non vederlo come amore e viverlo con sensi di colpa. Tornando all’intervento della signora, non solo suo figlio le ha detto implicitamente “Mamma ti metto davanti tutta la mia vita”, ma anche “Mamma tu ti occupi dei dettagli, di piccole cose”. L’adolescente che dice queste cose è sano; l’adolescente che non accusa i genitori non è adolescente. A parte tutto si sta ponendo una domanda interessante. Lui ha davanti tutta la sua vita e, guardandosi intorno, valuta le risposte che gli altri danno e si chiede se le sue risposte possono valere anche per lui: lui per la sua vita vuole delle garanzie. C’è il caso poi che suo figlio, che avrà pur il cuore piccolo ma è furbo, e giunge alla conclusione che è meglio non lavorare perché è meglio rimanere adolescenti piuttosto che adulti depressi.
La serietà della mia vita per lui è pesante: vede che non vado al cinema, non vado a ballare, mi critica perché non mi sono rifatta un compagno perché queste secondo lui sono le cose divertenti, mentre quelle che faccio io non lo sono.
Ha ragione, perché le sta ponendo la domanda “Che cos’è che può dare vita ? Quello che tu fai dà vita o no ? Spiegamelo, perché se dà vita lo prendo, altrimenti no.” E’ importante “leggere” la domanda. Se noi diamo queste esperienze “forti” che portano una persona a confrontarsi è molto più facile che il giovane ritorni dentro di sé e così questa intuizione di fondare bene la sua vita viene focalizzata meglio. Il discorso delle esperienze importanti può poi essere concretizzato in tante cose piccole, ma è il messaggio che noi mandiamo ad avere importanza: non è indispensabile che il giovane vada a fare esperienze chissà dove. Piccolo esempio. Quest’inverno c’era un gruppo di seminaristi che volevano fare degli incontri con i giovani e per questo avevano preparato un piccolo depliant in cui presentavano le date degli incontri. Il volantino si chiudeva in questo modo: “Noi seminaristi siamo disponibili, previo accordo, su richiesta dei gruppi parrocchiali, ad incontrare dei gruppi di giovani ogni 2 mercoledì dalle 17 alle 22. Le modalità dell’incontro saranno la drammatizzazione di un brano biblico e la testimonianza da parte di un personaggio dello spettacolo.” I missionari saveriani di Parma, miei studenti, che hanno organizzato un’iniziativa analoga, hanno preparato un bigliettino di altro tenore: guardate come cambia la cosa e quanto diventa “sfidante”. Dice: “Ciao. Siamo un gruppo di undici giovani e meno giovani che studiano per diventare preti e missionari, ma intanto viviamo nella tua città in via … al numero … I nostri amici sono anche vostri amici e se ti proponiamo un contatto è anche colpa loro. Da loro sappiamo che più o meno hai la nostra età, che è già qualcosa in comune. Se vuoi vieni a casa nostra, non solo per conoscerci ma anche perché possiamo parlarti di dove andremo da missionari. Poi potremo anche pregare un po’. Sarà bello se scopriremo che qualcosa di interessante ci accomuna.” Vedete la sfida: noi siamo missionari, voi che cosa siete ? Noi non ti vogliamo vendere la luna, ma solo parlarti di una croce di luce verso la quale tentiamo di arrancare. Hanno fatto questo incontro ed hanno riportato sul loro bollettino il pensiero recapitato da un adolescente che, pur con il suo cuore piccolo, guardate come risponde quando viene posto di fronte a dei contenuti. “Io sapevo già che andando in via … mi sarei messo in una situazione imbarazzante, ma a me l’ambiguo è sempre piaciuto. Volevo provare qualche cosa di nuovo anche se, lo devo ammettere, in casa mia c’è sempre stato un certo odore di preti e di frati. Ma non vado da solo. Ho preso il mio amico con me, tanto per non sembrare una persona troppo seria. Poi ci siamo ritornati altre volte, il mio amico un po’ meno; però con lui abbiamo continuato a parlare di quello che ci era capitato, delle cose che avevamo detto e sentito. Strano, perché discorsi così fra me e lui non li avevamo mai fatti. E io continuo ancora a pensare a quelle cose e a quelle persone, e lo strano è che ‘ci penso senza pensarci’. Mi ha colpito il fatto che sono ragazzi come me anzi, modestamente, alcuni meno dotati di me. Non me l’hanno detto così come ve lo dico io, ma mi hanno fatto capire che per fare certe cose ci vogliono … due palle così. Io le ho ? Controllo, e semmai ci ritorno !” Questo per vedere la disponibilità di un cuore piccolo che potenzialmente si può allargare. Per queste cose formative, sui gruppi, sui temi che stiamo affrontando c’è questa rivista “3 Dimensioni” (Ed. Ancora - 3 numeri all’anno) che parla sia di aspetti formativi in senso religioso che di formazione dei giovani. Questa rivista è legata ad un sito internet www.isfo.it dove è riportato per intero l’articolo da cui ho tratto parte degli spunti per l’intervento di oggi (“Etica ed antropologia” – 2005 Numero 1). Sempre in questo numero c’è un articolo (non riportato sul sito) dal titolo “Giovani e volontariato: avventura che passa o esperienza che forma ?” in cui si sostiene che il volontariato è un’esperienza molto utile per la crescita, purchè non sia un’esperienza estiva, che passa, ma che ponga delle domande. Volevo concludere chiedendoci quali sono le domande di fondo (non di cronaca) che l’adolescente si pone quando, consapevole di avere davanti tutta la sua vita, si ferma un momento per avere una certa coscienza di se stesso. Forse non si pone le domande “Sono libero o sono spinto ?” come le ho presentate io, ma possono nascerne altre che investono, ad esempio, i sentimenti e che costituiscono un attimo sfuggente che ad un certo punto attraversa la loro mente. Un grandissimo psicologo, Erikson, dà una pista interessante: intende la vita umana come un’esistenza aperta al mistero. La nostra esistenza è qualcosa che ci supera sempre: noi non possiamo esaurire il significato di ciò che vuol dire esistere da persone umane e, aggiungiamo, da persone cristiane. Nessuno di noi, neanche all’ultimo momento della propria vita, può dire “Io ho sperimentato tutto ciò che l’esistenza umana offre”: ciascuno di noi ne presenta un aspetto. Per cui è il mistero, cioè qualcosa che è sempre più scopribile, è infinito; come dice S.Paolo “E’ il mistero di Cristo”. Il mistero di Cristo è in noi e noi ne facciamo esperienza nella nostra vita; questo mistero che noi sperimentiamo supera ogni nostra esperienza e conoscenza. Questa nostra esistenza, però, si fa conoscere progressivamente, cioè ci dice qual è il significato di vivere e ce lo dice attraverso la cronaca, attraverso le piccole cose. Ma la cronaca ci pone delle domande, anche spicciole, riguardanti il significato della vita (pensate alla malattia, al dolore ed alla morte). Questa però non ci fa vedere le domande tutte in una volta, ma rispetta la nostra crescita evolutiva e si presenta a noi, secondo le caratteristiche di ciascuno, man mano che andiamo avanti. Ma è probabile che ci siano domande che la vita fa a tutti e che sta a noi rintracciare nelle persone. Domande alle quali possiamo rispondere non con delle risposte tecniche, ma con delle virtù, perché la virtù è quella che ci permette di rispondere alle domande della vita. Riprendiamo soprattutto le domande dell’età giovanile che richiamano il mistero della vita che sta davanti. Le 8 domande che vi propongo, riprese da Erikson, sono riportate nei fogli che vi ho consegnato. Solo un accenno all’ultima, chiamata ‘Integrità personale/disperazione’, che attiene all’età anziana. Moriamo saggi o moriamo disperati ? E’ la persona anziana che dice “Ma alla fine dei conti, quello che nella vita ha valore, in base ad un’esperienza di tanti anni, sono poche cose.” Ma ripartiamo dall’inizio. Una delle risposte fondamentali ricercate dai più giovani riguarda la loro amabilità: “Io sono amabile ?”. Io scommetto che ciascuno di noi si è posto il problema della propria amabilità. Certo non ce lo siamo posti in questi termini: ce lo siamo posti con il nostro cuore piccolino, restringendo questa domanda e dandoci risposte piccoline. Forse l’abbiamo tradotta come “Sono simpatico io agli altri ?”. Ma non è che il mio cuore cerchi la simpatia. Alcuni hanno tradotto la domanda in termini fisici: “Sono alto abbastanza ? Ho un naso che va bene o va rifatto ?”. Ma quello che interessa non è il naso: è la risposta piccolina ad un’esigenza profonda che riguarda la mia amabilità. Questo è tipico dell’adolescente e del giovane. Si tratta di una domanda molto imbarazzante. Provate a porvela e vedrete come questa domanda apre la vita al mistero. La mattina quando ci facciamo la barba o le donne stanno davanti allo specchio, chiediamoci “Perché questa faccia è esportabile ?”. Allora ci accorgiamo che noi attribuiamo importanza ad alcune cose e ad altre no. La stessa cosa vale per il modo in cui ci vestiamo. Quando ci poniamo la domanda sulla nostra amabilità, la risposta che ne otteniamo è relativa: non siamo né completamente amabili né completamente non amabili. La virtù che si collega all’amabilità è la speranza: “Spero, nonostante tutto, di essere amabile, di avere qualcosa che regge e mi permette di essere degno”. Domanda fondamentale con risposte piccole. Altro tema è quello del progetto, non quello intellettuale, ma quello corrispondente alla capacità di essere autonomi, avere cioè un obiettivo e confidare di possedere la capacità di raggiungerlo, di percorrere il sentiero che porta ad esso. La domanda a cui risponde è “Quanto sono capace di tenere duro nella mia progettualità ? Quanto sono capace di mettere la mia firma sotto quello che voglio ? Progetto quello che io penso si debba progettare o quello che gli altri mi hanno detto che va progettato ?”. E’ quindi la capacità di darsi una finalità. L’altro tema che l’autore ci pone è quello della perseveranza e quindi della delusione, dato che prima o poi c’è qualcosa che intralcia il mio cammino. Magari a noi adulti potrà sembrare una questione di poca importanza, ma per il giovane si tratta di una cosa seria. Risponde alla domanda “Come mi trovo di fronte alla sconfitta ?”. Qualcuno sarà portato a pensare che se c’è la difficoltà e c’è la sconfitta, allora tanto vale divertirsi: quando c’è qualcosa che ti rende difficile il cammino, come è possibile reagire ? Abbiamo poi il tema dell’intimità, dell’amore. Chi è il “tu” per me ? Cosa ha a che fare con me ? Chi è quella persona ? Un alleato ? Una cosa da usare ? Una minaccia da evitare ? A volte il “tu” è un oggetto da sfruttare: pensate ad una mamma che chiede al figlio di lavare i piatti, visto che ha tempo, ed il figlio risponde “Se lo puoi fare tu, perché dovrei farlo io ?”. E’ una domanda che tutti ci poniamo. E sufficiente che ci fermiamo ad un semaforo e c’è l’Albanese che ci chiede i soldi; dopo andiamo per strada dove la maggioranza sono neri, poi semmai andiamo sul lavoro dove la maggioranza sono musulmani. Viene fuori presto la domanda “Chi è il tu per me ?”. L’ultimo tema che vi presento è quello della fecondità che non è tanto, come nel caso dell’adulto, il fare figli, ma il domandarsi se vale la pena che qualcosa di me rimanga. La domanda che si pone l’adolescente è questa: “E se qualcuno assomigliasse a me, sarebbe fortunato oppure no ?”. Pensate se un genitore quando un figlio gli brontola sempre dietro gli dicesse “E se qualcuno assomigliasse a te, ti piacerebbe ?” Legate a tutto questo emergono le virtù come la speranza, la volontà, la fermezza, la sollecitudine verso gli altri: tutte virtù che intercettano queste domande. Allora è importante che l’educatore di un gruppo si ponga nell’ottica di un cuore che è sì piccolo, ma attraversato da domande che sono molto serie, anche se non trovano molto spazio in questo cuore piccolo. Ci sono domande serie che riguardano i pilastri fondamentali di una vita riuscita, domande che il bambino si pone a modo suo, l’adolescente a modo suo, ecc. Bisogna riuscire a cogliere, al di là delle espressioni esterne, che c’è un mondo importante che sta attraversando la vita dell’altra persona, anche se non appare importante. Inutile dire che poi, nella realtà, facciamo quel che possiamo … Esperienza. In un gruppo parrocchiale si cercava di passare dalle domande un po’ sciocche a quelle più importanti e alla fine del percorso ho chiesto a loro di tirare le conclusioni che sono state le seguenti. “Don, non è che ci siamo riusciti molto, ma una cosa ci ha fatto particolarmente piacere: tu ci hai preso sul serio !” Queste domande mi sembrano adatta sia per un giovane che per un adulto. Mi viene in mente che molto tempo addietro, prima della conversione, feci un corso dove ci suggerivano di mettere determinate parole attaccate alle porte, allo specchio, ecc. Allora se io attacco per casa queste domande, i miei figli non mi possono fare osservazione: io le attacco per me, se poi loro le vogliono leggere … Fare quindi questa sorta di lavaggio del cervello in giro per casa è un’idea forzata ? In effetti ci sono poi diverse tecniche per fare arrivare questi messaggi, però mi sento di dare un consiglio: non è che dobbiamo ‘agganciare’ il giovane. Perché non vi fermate e raccontate la vostra storia ? Anche di fronte ad un esplicito rifiuto, non è detto che il dialogo sia interrotto; magari non tanto un dialogo esplicito quanto un dialogo fatto con gli occhi. L’importante è che quando il giovane esprime delle domande ci siano pronte delle risposte, in modo che sappia che da qualche parte le risposte ci sono. Le domande che abbiamo proposto oggi sono domande estremamente imbarazzanti, domande che ci fanno paura, anche se parlandone qui non sembra. Sono domande che generalmente liquidiamo, e se riusciamo a liquidarle siamo contenti. Sono però domande che ritornano, perché è la vita che ce le ripropone.
Da:_ A. Manenti, Vivere gli ideali/2; fra senso posto e senso dato, Dehoniane, Bologna, 2003, 38- 43
Individuare i significati di vita
La nota teoria di Erikson sul formarsi dell'identità psico-sociale descrive lo sviluppo dell'io secondo otto stadi successivi. Ciascuno di essi è segnato da una antinomia (o conflitto) fra due polarità: fiducia-sfiducia, autonomia-vergogna e dubbio, iniziativa-colpa, applicazione-inferiorità, identità-diffusione del ruolo, intimità-isolamento, fecondità-stagnazione, integrità personale-disperazione. Ogni stadio è costituito da un polo positivo (es. fiducia) e uno negativo (es. sfiducia). Risolvere bene il problema posto da ogni stadio non significa annullare il polo negativo della sfiducia, vergogna, disperazione ... in favore di quello positivo della fiducia, autonomia, integrità .... , quasi che crescere bene significhi cancellare la mancanza e lasciare solo la pienezza; anche la persona matura mantiene una certa dose di sfiducia, colpa, disperazione, isolamento ... La gestione degli otto stadi è matura se rispetta l'antinomia dei due elementi che li compongono. Per farlo occorre un principio integratore, qualcosa che permetta di riconoscersi contemporaneamente sicuri e dubbiosi, competenti e in colpa, uniti e separati .... Questo qualcosa è un criterio capace di fare sintesi cioè una virtù, intendendo con questo termine una qualità fondamentale di forza senza la quale il compito esigito da ogni stadio resta un enigma e grazie alla quale riusciamo invece ad orientarci. Perciò, agli otto conflitti corrisponderebbero altrettante otto virtù in grado di gestirli. Erikson stesso le ha così definite l: speranza ("convinzione permanente della realizzabilità dei desideri ferventi, nonostante le forze oscure e violente che segnano l'inizio dell'esistenza"), volontà ("incrollabile determinazione di esercitare la libera scelta e l'auto-controllo malgrado le inevitabili esperienze di vergogna e di dubbio vissute nell'infanzia"), fermezza di propositi ("coraggio di porsi e perseguire scopi validi, non inibito dalla sconfitta delle fantasie infantili, dal senso di colpa e dalla paura delle punizioni"), competenza ("libero esercizio della destrezza e dell'intelligenza nell'esecuzione di compiti, esercizio non ostacolato da inferiorità infantile"), fedeltà ("capacità di restare coerenti con i principi liberamente scelti, nonostante le inevitabili contraddizioni dei sistemi di valore"), amore ("reciprocità di devozione capace di superare sempre l'antagonismo inerente nella divisione delle funzioni"), sollecitudine ("la dilatante preoccupazione per ciò che è stato generato dall'amore, dalla necessità o dal caso; essa supera l'ambivalenza legandosi a un' obbligazione irreversibile"), saggezza ("interesse distaccato per la vita in sé, al cospetto stesso della morte"). Su questa linea, Meissner ha ipotizzato la corrispondenza con otto virtù cristiane: fede-speranza, contrizione, penitenza-temperanza, fortezza, umiltà, amore del prossimo, servizio/zelo/sacrificio di sé, carità 2. Siccome gli otto conflitti sono in sequenza evolutiva, ognuno di essi rappresenta una stagione della vita, ognuna delle quali è impegnata ad affrontare il compito indicato dal conflitto corrispondente, cioè da una serie di interessi che pongono relative domande e chiedono prese di posizione corrispondenti. Possiamo, perciò, dire che il bambino si pone domande tipiche della sua età diverse da quelle che caratterizzano il mondo adolescenziale, adulto e della vecchiaia, perché il bambino, l'adolescente, l'adulto e il vecchio appartengono a stadi evolutivi differenti. Ogni soggetto che si trova in un dato stadio lo riempie con una miriade di eventi di cronaca quotidiana del tutto personali e irripetibili, ma tutti quelli che si trovano in quello stadio stanno dibattendo un comune significato di vita, per cui tutti i bambini stanno confrontandosi con il volto bambino della vita, gli adolescenti con quello adolescenziale e così via. Il modello di Erikson è molto utile per il nostro tema. Ad ogni stadio, la vita fa conoscere un suo volto nella polarità positiva e negativa e l'insieme di questi otto stadi compongono il sublime volto del vivere da umani che a noi si svela per tappe successive stadio dopo stadio. L'utilità del modello di Erikson consiste nell' avvertirci che mentre ci addestriamo sulla cronaca dell'ora attuale ci apriamo progressivamente anche alla pienezza della vita e quando nella gestione del qui e ora insorge qualche difficoltà conviene trattarla non solo come problema tecnico ma come difficoltà a metabolizzare nuovi e più ampi volti della vita con relative domande e offerte. Gli otto stadi aiutano a "catalogare" la miriade di eventi spiccioli della cronaca quotidiana e, per ogni stadio, ipotizzano quale potrebbe essere il significato di vita in essi attivato. In questo modo è più facile individuare significati di vita in significati di cronaca. Ogni buona e cattiva sorte contiene una problematica riconducibile all'uno o all'altro degli otto stadi e poiché ogni stadio si caratterizza per una sua corrispondente domanda di vita e virtù, è possibile rintracciare nell'episodio spicciolo quali sono le domande più importanti che in esso trovano spazio e le forze per affrontarle. In altre parole, ognuno di noi, prendendo spunto dalla propria buona e cattiva sorte è indotto a riflettere su otto cardini intorno ai quali si gioca il buon esito dell'esistenza umana. Senza cadere in rigidi schematismi, il lettore può risalire dalla sua cronaca all'individuazione della reale posta in gioco in essa contenuta.
1. fiducia-sfiducia (0-1)
Credere in sé nel timore di sé.
Tema dell'amabilità
- Su che cosa fondo la stima di me stesso? Quale è la mia perla preziosa?
- Se qualcuno si avvicina troppo a me, temo di essere repellente, profumato, dare la scossa ...
- accetto che qualcosa, nella vita, mi manchi sempre? - e se gli altri mi conoscessero davvero ...
Speranza
2. autonomia-vergogna e dubbio (1-3)
Il coraggio nella trepidazione.
Tema della progettualità
- Fino a che punto sono disposto a pagare per la mia perla preziosa? E quando l'impulso va contro? - Chi è il padrone dei miei desideri: io o la convenzionalità?
- Delle mie scelte, anche in futuro, potrò dire "le ho volute io"? - Il momento del dubbio uccide le certezze finora credute?
Volontà
3. iniziativa-colpa (3-5)
Nella sconfitta ritentare.
Tema della perseveranza
- Perché mirare in alto se neanche io sono coerente ?
- E se mi ritrovo per terra ...
- perseverare per volontarismo o per desiderio? - Conviene diventare adulti?
Fermezza di propositi
4. applicazione-inferiorità (6)
Destrezza nell'eseguire i compiti e senso del limite.
Tema della competenza
- Accetto di rischiare oppure ho paura di farmi male?
- Ciò in cui oggi credo pagherà anche in futuro?
- Costruisco rapporti per azioni o per presenze?
- L'incontro con la aggressività e le competizioni della vita ... - Ho una gerarchia di priorità?
Competenza
5. identità-diffusione del ruolo (adolescenza)
Sentirsi interi nella frammentazione.
Tema della coerenza
- in un mondo che cambia, c'è qualcosa che rimane in eterno?
- so vivere nel conflitto?
- faccio il bene che vale o quello che gratifica? - Piacere agli altri o mostrarsi nella propria verità - Sono amabile per natura o perché mi camuffo?
Fedeltà
6. intimità-isolamento (giovinezza)
Stare insieme e sentirsi soli.
Tema dell'amore
- Chi è il tu per me: alleato da cercare, minaccia da evitare, oggetto da usare ... ?
- accetto che il tu mi deluda o se questo capita rompo con lui ... ?
- Se ci confidiamo, ci sapremo stimare ancora?
- Sono disponibile a lasciarmi trasformare da un incontro?
Amore
7. fecondità-stagnazione (età adulta)
Conservarsi e far nascere.
Tema della produttività
- Cosa vuol dire farsi furbi: saltarci fuori comunque o realizzare qualcosa?
- E' possibile offendere ciò che si ama ma sentirsi ancora solidali con ciò che di fatto si è offeso? - E se qualcuno assomigliasse a me ...
- Il massimo della vita: conservare se stessi o farsi afferrare da qualcosa e da qualcuno?
Sollecitudine
8. integrità personale-disperazione
Interesse per la vita anche se imprevista.
Tema della saggezza
- Ma alla fin dei conti, quali sono le poche cose che valgono? - Ultimamente, quale è il mio amore?
Saggezza
Rileggendo gli otto stadi con i rispettivi compiti evolutivi, possiamo ulteriormente semplificare i significati di vita implicati riconducendoli a tre grandi ambiti:
1 Relazione con se stessi (i conflitti 1-4 che per Erikson sono tipici dell'età infantile).
2. Relazione con il mondo esterno (i conflitti 4-5 che per Erikson caratterizzano l'età adolescenziale e giovanile).
3. Fondamento solido del rapporto con il mondo interno ed esterno (i conflitti 7 e 8 che per Erikson sono tipici dell'età adulta).
Amore di sé, amore per gli altri e sottrarre questi amori all'effimero diventano, così, i tre grandi compiti per riempire di senso la propria vita.
PER SCARICARE L'ARTICOLO SUL TUO PC, CLICCA QUI'
—————