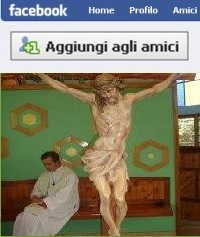Una Vita per la Missione
"Segni e simboli nella liturgia"
14.12.2014 20:13Nella vita umana segni e simboli occupano un posto importante. In quanto essere corporale e spirituale insieme, l'uomo esprime e percepisce le realtà spirituali attraverso segni e simboli materiali. In quanto essere sociale, l'uomo ha bisogno di segni e di simboli per comunicare con gli altri per mezzo del linguaggio, di gesti, di azioni. La stessa cosa avviene nella sua relazione con Dio. (Catechismo C.C.)
Nella liturgia i simboli servono a presentare attraverso la loro realtà materiale e tangibile una realtà invisibile consentendoci di riconoscerla, introducendoci con i nostri sensi in quel Mistero Pasquale che viene celebrato.
ACQUA
E' simbolo di vita, purificazione, morte e distruzione. Tutti questi significati li troviamo nella Sacra Scrittura come riferimento al sacramento del Battesimo (nuova vita, rinascita, purificazione)
Semplice, limpida, pronta a ristorare chi è assetato, a pulire ciò che è sporco.
Nello stesso tempo l'acqua richiama la profondità dei mari, insondabile e che trasmette un senso di forza, e richiama anche l'immagine della vita che da essa sgorga, veicolo della grazia divina. È l'elemento primordiale da cui ha avuto origine la vita stessa e che nel battesimo ci fa morire (affogare) e rinascere.
L'acqua viene usata per benedire, battezzare, come simbolo di nuova vita, di purificazione, noi stessi entrando in chiesa (non uscendo...) ci segniamo con il segno della Croce inumidendoci le dita e toccandoci fronte spalle cuore, come ricordo del battesimo e come gesto di purificazione, affinché l'animo nostro diventi puro grazie a quell' acqua. È il primo gesto penitenziale che compiamo, anche se lo abbiamo dimenticato, quando entriamo in chiesa.
PANE E VINO
Il pane è nutrimento, quello essenziale, quello dei poveri di tutti i tempi e di tutto il mondo. Si dice che il pane "è buono". Nella figura del pane Dio diventa vitale nutrimento per noi uomini. E' il pane VIVO; è il pane della Vita. ( Gv 6,34)
Il vino è bevanda, e non una semplice bevanda che spegne la sete, mira a qualcosa di più: rende lieto il cuore dell'uomo.
Senso del vino non è solo spegnere la sete, bensì di essere la bevanda della gioia.
Ed è sotto la figura del vino che Cristo elargisce il suo sangue. Non come bevanda "misurata", ma come sovrabbondanza (lo ha versato tutto) della prelibatezza divina.
Dio ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Mangiare e bere di Sé per avere la Vita con la V maiuscola.
C'è anche un altro significato nell'uso del pane e del vino nella liturgia. Essi sono al contempo frutto della terra, ovvero dono di Dio, e del lavoro dell'uomo. Non si usano ad esempio frutta e miele per le offerte che diverranno corpo e sangue di Cristo, ma pane e vino, poiché il Signore chiede all'uomo la sua collaborazione nel disegno della Salvezza. Ovvero il frumento deve essere lavorato, impastato, cotto dall'uomo, con i frutti del suo ingegno della sua inventiva (macine, forni). Così anche il vino, l'uva una volta raccolta va pestata, il mosto fatto fermentare al punto giusto. Dio chiede sempre la nostra collaborazione perché anche noi possiamo avere una parte attiva nel piano della nostra Salvezza.
OLIO
E' simbolo di salute, forza, benessere e pace. Tali significati ripresi dalla Sacra Scrittura rimandano alla grazia dello Spirito Santo donato nei sacramenti che scende sul battezzato, confermato, vescovo, sacerdote, infermo e sui luoghi destinati alle celebrazioni.
Distinguiamo tre oli:
il Crisma, l'olio dei Catecumeni e l'olio degli infermi.
Vengono benedetti (il crisma viene consacrato) in ogni cattedrale una volta all'anno il Giovedì Santo dal vescovo durante la messa crismale. Dopo la messa crismale gli oli vengono distribuiti ad ogni parrocchia.
Subito dopo il Battesimo si unge con il crisma il capo del battezzato
Per la Confermazione si traccia una croce sulla fronte del cresimando.
All'ordinazione il crisma si usa per ungere le palme delle mani dei presbiteri e le fronti dei vescovi.
Può essere usato anche nella consacrazione di calice e patena.
L'olio dei catecumeni viene usato nei riti preparatori al Battesimo come segno di fortezza nella lotta contro il peccato. Si tracciano con quest'olio una croce sul petto e un'altra fra le scapole del catecumeno.
L'olio degli infermi è l'olio che viene utilizzato per amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi.
FUOCO
Il fuoco è un elemento che consuma, brucia, purifica, distrugge, illumina, riscalda, produce energia. È simbolo pertanto della presenza della divinità, presenza invisibile ma forte e purificatrice; attorno al fuoco si raccolgono le persone e questa presenza favorisce la comunione, la riflessione, la meditazione.
IL CERO
In particolare parliamo del cero pasquale. Strettamente legato a quanto detto del fuoco anche il cero pasquale è simbolo della divinità e in modo particolare esso simboleggia nello specifico il Cristo risorto.
La notte di Pasqua infatti la celebrazione inizia proprio con l'accensione del cero fuori della Chiesa. Esso poi "feconda" tutta la comunità e le ridà nuova vita, tanto che tutti gli altri ceri simboli delle nostre vite come il cero pasquale è simbolo del Cristo, vengono accesi da esso.
Perché proprio il cero? Perché non solo produce luce e calore, ma si consuma. Il senso più profondo della vita sta nel consumarsi in verità e amore per Dio, come il cero in luce e fiamma.
La notte di Pasqua si fa un'altra azione con il cero: lo si immerge nel fonte battesimale per benedire l'acqua, dalla quale in seguito avranno nuova vita i battezzati. Questo gesto compiuto nella notte di Pasqua altro non è infatti che la rappresentazione simbolica dell'unione che genera: Cristo risorto feconda la sua Chiesa donandole la Vita.
LUCE
E' elemento vitale sia nel cosmo che per la vita dell'uomo. Per il cristiano la luce è Cristo. Il cero pasquale che viene acceso dal fuoco nella notte della veglia pasquale simboleggia la luce di Cristo che disperde le tenebre del peccato e della morte.
INCENSO
Il suo uso è antichissimo; veniva bruciato per emanare odore e profumare gli ambienti. Nelle liturgie l'uso dell'incenso è utilizzato per creare un ambiente solenne e festoso esprimendo rispetto e riverenza verso il Signore essendo segno dell'atteggiamento di preghiera e di adorazione verso Dio.
La nube che genera l'incenso insieme al suo odore è simbolo della presenza del divino cosi come ci dicono molti testi biblici.
L'odore dell'incenso inoltre suggerisce un percorso di santità a coloro che si lasciano portare da esso; l'odore dell'incenso (del divino) deve entrare in noi, sino al nostro cuore, per renderci santi. L'incenso usato durante la celebrazione eucaristica ci indica questa via: accogliere il Signore che bussa alla porta del nostro cuore riconoscendo la sua voce in mezzo a tante altre voci.
GESTI
Il Mistero Pasquale di Cristo è reso presente nella liturgia anche attraverso i gesti e le azioni che noi compiamo col nostro corpo. Il corpo, infatti, nella celebrazione, è una presenza determinante; noi parliamo con il nostro corpo e con i nostri gesti e atteggiamenti, comunichiamo i sentimenti, le sensazioni del cuore, a gioia o il dolore.
IN CHIESA
Partecipando alle celebrazioni dobbiamo esprimere col nostro corpo rispetto verso Dio che parla. Durante la celebrazione il metro di misura deve essere la verità, non bisogna fare movimenti costruiti. Nelle celebrazioni il discepolo non vive il suo rapporto con Dio privatamente ma insieme ai fratelli e le sorelle, lo vive come Chiesa; tutto ciò che compie lo deve fare insieme agli altri.
Vediamo dunque alcuni atteggiamenti da tenere in Chiesa durante le celebrazioni.
STARE IN PIEDI
E' gesto di onore e di rispetto verso Dio; manifesta la dignità dei figli di Dio che i cristiani hanno ricevuto col battesimo; significa confessare con il proprio corpo che la pasqua di Cristo ci ha salvati (i risorti stanno in piedi); è gesto di gioia con cui i figli di Dio attendono il Signore che viene.
STARE SEDUTI
E' mettersi in riposo fisico e spirituale durante la liturgia della Parola e durante la pausa di silenzio dopo la comunione per ringraziare il Signore. Due momenti caratterizzati dall'ascolto che il discepolo deve porre verso il Signore che parla. L'ascolto esige anche il silenzio che è il respiro della liturgia, lo spazio in cui risuona la Parola di Dio. È il gesto con cui ci disponiamo ad ascoltare Dio che parla e allo stesso tempo è il gesto con cui Lui ci mostra la sua accoglienza. Siamo infatti gli invitati alle nozze dell'Agnello e come tali veniamo fatti accomodare nella casa del nostro "ospite".
STARE IN GINOCCHIO
E' un gesto che richiama alla consapevolezza della propria povertà e della propria piccolezza di fronte alla grandezza e alla santità di Dio. Esprime la nostra adorazione. Legato allo stare in ginocchio abbiamo la genuflessione passando davanti al tabernacolo o davanti al SS Sacramento esposto e davanti alla croce il Venerdì Santo. (nb si fa inginocchiandosi su un solo ginocchio, il destro, senza appoggiare le mani sulle gambe...nei limiti del possibile...).
INCHINO
Davanti alla croce, all'altare, alle sante icone, al vescovo che presiede (e per traslazione al celebrante parroco in quanto rappresentante del Vescovo). Distinguiamo in inchino del capo e inchino profondo. L'inchino del capo è previsto anche quando vengono nominate insieme le tre persone della Santissima Trinità, il nome di Maria e del santo di cui si celebra la memoria.
LE MANI
Alzate: le mani sono il prolungamento della persona; esse accompagnano il nostro parlare. Le mani alzate esprimono la tensione verso l'alto; tutto l'uomo è come portato verso Dio.
Giunte: l'uomo che si pone in preghiera davanti a Dio congiunge le mani per manifestare il suo abbandono nelle sue mani e per affidarsi umilmente e interamente a lui. Le mani sono segno del nostro agire, del nostro lavorare, della nostra attività, quando le uniamo e le portiamo al cuore, ci disponiamo a cessare tutte le nostre opere ed, entrando nella stanza segreta del nostro cuore, entriamo in dialogo con Dio.
Battersi il petto: esprime il nostro sentimento di colpa, quella colpa che nasce dal peccato che ha la sua origine nel cuore. L'uomo peccatore deve rompere il cuore di pietra per ricevere da Dio un cuore nuovo, il cuore di carne.
Segno di croce: è il segno più importante del nostro essere cristiani; è il gesto con cui noi confessiamo la nostra fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E' il gesto con cui iniziamo ogni preghiera, ogni attività. È il segno che ci collega a Cristo stesso e ci impegna per tutta la vita.
ABBIGLIAMENTO E PARAMENTI SACRI
A) GLI ABITI FESTIVI DEI CRISTIANI PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
Da diverse generazioni, i cristiani hanno utilizzato gli abiti migliori, più belli e meglio confezionati, per partecipare ai vari sacramenti, e in particolare alla celebrazione dei sacramenti del Battesimo, dell'Eucaristia Prima Comunione ed Eucaristia domenicale e del Matrimonio.
QUALE SIGNIFICATO RELIGIOSO HANNO TALI ABITI?
-
La liturgia della Chiesa riserva un ruolo importante ai segni, e dunque anche all'abbigliamento delle persone che vi partecipano. Attraverso i segni viene espresso visibilmente ciò che è invisibile.
Il culto liturgico coinvolge la persona intera: il suo intelletto, i suoi sentimenti ed i suoi sensi, la sua anima e il suo corpo, la sua dimensione interiore ed esteriore. La retta disposizione interiore, richiesta dal servizio a Dio, si esprime anche nel comportamento esteriore e nell'abbigliamento, in quanto gli elementi esteriori contribuiscono a rafforzare le attitudini, i sentimenti e le convinzioni interiori.
Il mondo materiale, inoltre, prezioso e buono, è un mezzo importante attraverso il quale Dio si manifesta all'uomo e attraverso il quale la persona conosce e comunica con Dio. -
Gli abiti festivi esprimono la fede e la devozione di coloro che li hanno commissionati, confezionati e di quanti li indossano. Tali vesti oltre che esprimere, possono anche favorire, alimentare e rafforzare la fede e devozione di tutti i partecipanti alla celebrazione sacramentaria, i quali possono così comprendere maggiormente l'importanza della celebrazione anche dal particolare e festivo abbigliamento delle persone. Infatti conta molto non solo ciò che essi ascoltano, ma anche ciò che vedono. Invece la trascuratezza anche nel modo di vestire è indice che la fede è debole e che scarsa è l'importanza attribuita all'azione che si sta compiendo.
-
La particolare cura nel vestiario usato per la celebrazione dei sacramenti esprime la distinzione fra sacro e profano nella vita quotidiana. Questa distinzione è particolarmente importante nel nostro tempo, in quanto si osserva una tendenza a cancellare la distinzione tra «sacrum» e «profanum», data la generale diffusa tendenza (almeno in certi luoghi) alla dissacrazione di ogni cosa. Occorre invece riscoprire, evidenziare e rispettare la sacralità del mistero di Dio, che si fa presente e che agisce in modo speciale nei Sacramenti, istituiti da Cristo e custoditi e celebrati con devozione dalla Chiesa lungo i secoli.
Gli abiti festivi aiutano anche a cogliere la dimensione comunitaria insita in ogni Sacramento, che è sempre celebrazione di tutta la Chiesa. Infatti, poiché l'uomo ha una natura che lo porta a vivere in società, ha bisogno delle espressioni sensibili che lo aiutino a vivere questa esperienza della vita comunitaria. Le vesti indossate dai partecipanti alla celebrazione di un sacramento evidenziano la sua dimensione comunitaria, ecclesiale e non solo individuale. E' la celebrazione festosa, non solo di tutta una comunità familiare, parentale, parrocchiale, ma anche di tutta la Chiesa, che condivide la gioia del singolo.
B) LE VESTI DEL SACERDOTE PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
Quanto detto circa gli abiti festivi indossati dai fedeli quando partecipano alla celebrazione dei Sacramenti cristiani, è valido anche per i paramenti liturgici utilizzati dal sacerdote nel presiedere la celebrazione dei vari Sacramenti.
Ma occorre aggiungere ulteriori motivazioni e finalità che giustificano, in modo specifico e proprio, l'uso di dignitosi paramenti liturgici da parte del sacerdote. Ed è proprio per questi specifici motivi e significati che le vesti che indossano i sacerdoti, prima di essere destinate all'uso liturgico, vengono opportunamente benedette.
QUALI SONO LE FINALITA' SPECIFICHE DELLE VESTI LITURGICHE DEL SACERDOTE CELEBRANTE?
Il paramento liturgico indossato dal sacerdote nella celebrazione dei sacramenti indica la particolare missione che svolge il sacerdote nella celebrazione sacramentaria. Egli, in ogni sacramento, agisce non semplicemente come uomo, ma come rappresentante di Cristo.
L'abito, che il sacerdote indossa, gli ricorda che non può considerarsi come un «proprietario», che liberamente dispone del testo liturgico e del sacro rito come di un suo bene peculiare, così da dargli uno stile personale e arbitrario, ma gli ricorda che sta agendo a nome di un Altro, compiendo una missione che è distinta da quella degli altri fedeli.
Infatti "nella Chiesa, corpo mistico di Cristo, non tutte le membra svolgono lo stesso compito. Questa diversità di compiti, nella celebrazione dell'Eucaristia, si manifesta esteriormente con la diversità delle vesti sacre, che perciò devono essere segno dell'ufficio proprio di ogni ministro" (MESSALE ROMANO, Ordinamento generale, n. 335).
Tenendo conto di ciò, la Chiesa è intervenuta a dare opportune indicazioni sul come devono essere in generale gli arredamenti liturgici e in particolare le vesti sacre, al fine anche di esprimere al meglio la dimensione innanzi tutto religiosa e spirituale della celebrazione sacramentaria, evitando ogni forma di spettacolarizzazione o di rappresentazione teatrale.
Devono ispirarsi ad uno stile di semplicità, nelle forme e nei materiali usati, senza eccessivi ornamenti e sfarzi. Gli ornamenti possono presentare immagini o simboli, che ne indichino l'uso sacro.
(MESSALE ROMANO, Ordinamento generale, nn. 289; 342-344, 390).
QUAL E' LA TIPOLOGIA DELLE VESTI LITURGICHE DEL CELEBRANTE?
Ecco i principali tipi di vesti liturgiche utilizzate dal sacerdote per la celebrazione dei sacramenti:
-
L'amitto: panno bianco da applicare intorno al collo, quando il camice non copre completamente l'abito comune del sacerdote. È un panno di forma rettangolare di ca. 80 per 60 centimetri, che viene posto intorno al collo e sulle spalle per coprire l'abito comune. Viene legato ai fianchi grazie a due fettucce, le quali possono essere cucite all'amitto o da esso separabili. L'amitto può essere di tela, di lino o di canapa; al centro ha una croce che viene baciata dal sacerdote prima di indossarlo. Mentre il ministro lo indossa recita in segreto " Imponi, o Signore, sul mio capo l'elmo della salvezza, per vincere gli assalti del demonio". Si porta sotto il camice nel rito romano sopra nel rito ambrosiano.
-
Il camice o alba: veste di stoffa bianca, che è lunga sino alle caviglie e che copre completamente l'abito del sacerdote. Esso è indossato non solo dal sacerdote presidente, ma anche dai ministri e dai ministranti. Indossando il camice si intende richiamare simbolicamente il battesimo, nel quale ogni cristiano riceve la nuova veste bianca, simbolo stesso della purezza di Cristo. Il sacerdote, mentre lo indossa prima della Celebrazione eucaristica, recita la seguente preghiera: "Purificami, Signore, e monda il mio cuore, perché per il Sangue dell'Agnello senza macchia io meriti le gioie eterne". I camici moderni sono provvisti di un colletto che aderisce al collo e sono muniti di cerniere sul petto o sulla spalla. Vi sono inoltre nuove tipologie di camice che richiamano le vesti monastiche con maniche larghe e cappucci. Sopra il camice il celebrante indossa il cingolo alla vita, la stola, la casula (o, se è un diacono, la dalmatica).
-
Il cingolo: cintura in stoffa che stringe il camice a livello dei fianchi del celebrante. Può essere omesso purché il camice sia fatto in modo tale da aderire da solo ai fianchi. Il sacerdote mentre lo indossa prima della celebrazione eucaristica, recita la seguente preghiera: "Cingimi, Signore, con il cingolo della purezza e liberami dalle passioni della libidine, affinché rimanga sempre in me la virtù della continenza e della castità". Esso è quindi segno penitenziale e ricorda anche gli Ebrei che consumarono l'agnello pasquale con i fianchi cinti (Es 12,11).
-
La stola: il più importante paramento, è a forma di sciarpa, portata dal sacerdote e dal vescovo sul collo. Il diacono invece la indossa di traverso sulla spalla sinistra. Il colore varia a seconda dei tempi liturgici. Il sacerdote, mentre la indossa prima della Celebrazione eucaristica, recita la seguente preghiera: "Donami, Signore, la stola dell'immortalità, che persi a causa del peccato dei progenitori; e benché indegnamente accedo ai tuoi santi misteri, io ottenga ugualmente la tua grazia"; la stola è infatti segno dei fiumi d'acqua viva che scendono sugli eletti (Gv 7, 38)
-
La casula (o pianeta): paramento che il sacerdote celebrante indossa sopra il camice e la stola; è confezionato nei vari colori liturgici.
-
La cotta: sopravveste bianca, spesso ornata di pizzo, lunga fino al ginocchio, con maniche corte e larghe, da indossare sopra la talare. Viene usata anche dai ministranti, che servono all'altare (chierichetti). La cotta viene indossata dal clero in tutte le celebrazioni liturgiche, fatta eccezione della messa (in questo caso i diaconi, i presbiteri o i vescovi celebranti devono obbligatoriamente indossare il camice). Se durante la celebrazione della messa è presente un ministro ordinato che indossa la cotta, significa che questi non sta celebrando o concelebrando ma semplicemente assistendo.
-
La dalmatica è un paramento liturgico consistente in una lunga tunica che arriva all'altezza delle ginocchia e provvista di ampie maniche. Era ricamata in oro, tessuta anche in filigrana d'oro, con smalto e perle, ai tempi dei romani ed ancora oggi viene prodotta con questi materiali. Essa è l'abito proprio dei diaconi, che la indossano nelle Celebrazioni liturgiche.
-
Il velo omerale: panno per coprire e riparare in segno di rispetto, da portare sulle spalle, quando il sacerdote tiene l'ostensorio durante la benedizione eucaristica solenne o durante una processione presentazione delle offerte
-
Il piviale: veste liturgica usata originariamente per le processioni e in seguito anche per la Liturgia delle Ore nelle feste solenni e per la celebrazione dei Sacramenti al di fuori della Messa e per la benedizione col Santissimo Sacramento.
QUALI SONO I COLORI LITURGICI PER LA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI, E IN PARTICOLARE DELLA S. MESSA?
I colori evidenziano il tempo liturgico e la rispettiva caratteristica particolare che la celebrazione presenta nei vari tempi liturgici. Secondo il tipo e la finalità della celebrazione, i giorni e i tempi liturgici dell'anno ecclesiastico, sono prescritti per i paramenti i seguenti colori: il bianco, il rosso, il verde, il violetto, il rosaceo e il nero. In ogni periodo dell'anno liturgico, è possibile sostituire i suddetti vari colori con il colore oro, per particolari motivi di solennità.
-
Bianco: si usa nel tempo pasquale e nel tempo natalizio, nelle feste della Madonna e dei santi non martiri. E' il colore della gioia pasquale, della luce e della vita.
-
Verde: si usa nel tempo ordinario. Esprime la giovinezza della Chiesa, la ripresa di una vita nuova.
-
Rosso: si usa nella domenica delle Palme, nel Venerdì Santo, nella Pentecoste, nelle feste dei santi martiri. Significa il dono dello Spirito Santo che rende capaci di testimoniare la propria fede anche fino al martirio (indica anche il sangue)
-
Viola: si usa in Avvento, in Quaresima, nella liturgia dei defunti. Indica la speranza, l'attesa di incontrare Gesù, lo spirito di penitenza, la speranza cristiana nei momenti della sofferenza e del lutto.
-
Rosaceo : si usa solo nel rito romano per la terza domenica di Avvento e per la quarta domenica di Quaresima. Indica l'attesa che prepara la Solennità che s'avvicina.
-
Nero: si usa talvolta nei funerali e nelle celebrazioni per i defunti.
-
Azzurro: si usa soprattutto nelle feste della Madonna, per richiamare il colore del cielo.
ARREDI E VASI SACRI
Anche gli oggetti usati per la celebrazione hanno un loro valore simbolico, poiché devono essere forgiati secondo certe norme. La loro bellezza estetica e i materiali pregiati utilizzati devono infatti far capire come ciò che dovranno contenere, l'uso che se ne dovrà fare è rivolto a materia divina e merita pertanto la maggiore bellezza possibile.
-
Calice: oggetto liturgico utilizzato per contenere il vino durante la Celebrazione Eucaristica. Normalmente si presenta in forma di coppa svasata appoggiata su un alto piede. Viene realizzato con materiali preziosi, tipicamente d'argento esteriormente e dorato interiormente, ma a volte può anche essere fatto di altri materiali.
- Patena: oggetto simile ad un piccolo piatto circolare. Durante la Celebrazione Eucaristica l'Ostia vi viene posta sopra prima di essere consacrata . La patena può essere utilizzata anche durante la Comunione dei fedeli per evitare che ostie o frammenti di ostia possano cadere a terra inavvertitamente.
- Pisside: oggetto liturgico usato per conservare le ostie consacrate dopo la Celebrazione Eucaristica. Durante la Celebrazione eucaristica la Pisside con le ostie può essere deposta sull'altare. Al di fuori della celebrazione la Pisside con le ostie è conservata dentro il tabernacolo. È un contenitore, generalmente, munito di piede e di coperchio. È sovente realizzato in metallo prezioso, come l'oro e l'argento.
< >Ostensorio: (dal latino ostendĕre, mostrare), nella liturgia cattolica, è l'oggetto usato per l'esposizione solenne (ostensione) del Corpo di Cristo (l'Ostia consacrata) per l'adorazione eucaristica e per la benedizione eucaristica. Solitamente è forgiato in oro, argento e/o altri metalli preziosi ed è spesso a forma raggiera, come un sole. Solitamente quando sono portati in processione vengono coperti con il velo omerale. Palla : chiamata anche animetta, consiste in un quadrato di stoffa, generalmente bianco, su cui può essere ricamata una croce o altri abbellimenti, e che può avere una consistenza dura o soffice. Generalmente viene inamidato. La sua funzione è quella di coprire il calice e la patena onde evitare che prima della consacrazione possano entrarvi elementi esterni e corrompenti, come polvere o detriti.- Corporale: è costituito di un panno di forma quadrata di tela di lino inamidato. Durante la celebrazione della Messa, dapprima il corporale è posto piegato sopra al calice; durante l'offertorio il celebrante lo distende sull'altare per posarvi sopra la patena contenente l'ostia e il calice contenente il vino. Il suo nome proviene dal fatto che, ponendovi sopra l'ostia transunstanziata che è diventata il corpo di Gesù, sostiene il corpo stesso di Gesù Cristo. Per lo stesso motivo nei vecchi sacramentari ambrosiani veniva chiamato sindone.
- Purificatorio, o anche purificatoio, è un oggetto liturgico cattolico. Il purificatorio è un rettangolo di lino con una piccola croce ricamata, che può avere varie dimensioni e serve durante la messa: per pulire la patena prima di deporvi l'ostia consacrata dopo la recita del Padre Nostro; per pulire il calice prima di versare il vino e l'acqua; per asciugarsi le labbra dopo aver bevuto dal calice; e infine per pulire il calice alla fine della comunione.
- Conopeo: copertura in tessuto rimovibile del tabernacolo. può essere di varie forme:
-
può coprire integralmente il tabernacolo;
-
può coprire solo la parte anteriore del tabernacolo (soluzione più diffusa);
-
può coprire solo la parte intorno all'anta del tabernacolo.
-
- Conopeo: copertura in tessuto rimovibile del tabernacolo. può essere di varie forme:
- Purificatorio, o anche purificatoio, è un oggetto liturgico cattolico. Il purificatorio è un rettangolo di lino con una piccola croce ricamata, che può avere varie dimensioni e serve durante la messa: per pulire la patena prima di deporvi l'ostia consacrata dopo la recita del Padre Nostro; per pulire il calice prima di versare il vino e l'acqua; per asciugarsi le labbra dopo aver bevuto dal calice; e infine per pulire il calice alla fine della comunione.
- Corporale: è costituito di un panno di forma quadrata di tela di lino inamidato. Durante la celebrazione della Messa, dapprima il corporale è posto piegato sopra al calice; durante l'offertorio il celebrante lo distende sull'altare per posarvi sopra la patena contenente l'ostia e il calice contenente il vino. Il suo nome proviene dal fatto che, ponendovi sopra l'ostia transunstanziata che è diventata il corpo di Gesù, sostiene il corpo stesso di Gesù Cristo. Per lo stesso motivo nei vecchi sacramentari ambrosiani veniva chiamato sindone.
- Pisside: oggetto liturgico usato per conservare le ostie consacrate dopo la Celebrazione Eucaristica. Durante la Celebrazione eucaristica la Pisside con le ostie può essere deposta sull'altare. Al di fuori della celebrazione la Pisside con le ostie è conservata dentro il tabernacolo. È un contenitore, generalmente, munito di piede e di coperchio. È sovente realizzato in metallo prezioso, come l'oro e l'argento.
—————