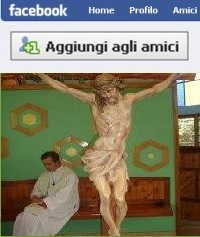Una Vita per la Missione
Documento Finale "VII Congresso Mondiale della Pastorale dei Migranti"
16.02.2015 15:57
Pontificium Consilium De Spirituali Migrantium Atque
Itinerantium Cura
VII Congresso Mondiale della Pastorale dei Migranti
Roma, 17 – 21 novembre 2014
Tema: «Cooperazione e sviluppo nella pastorale delle migrazioni»
DOCUMENTO FINALE
I. L’EVENTO
1. Il VII Congresso Mondiale della Pastorale dei Migranti si è svolto da lunedì 17 a venerdì 21 novembre 2014, presso l’Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana, in Via Urbano VIII, n. 16, Città del Vaticano. Ne era tema “Cooperazione e sviluppo nella pastorale delle migrazioni”.
2. Al Congresso hanno partecipato 284 delegati provenienti da oltre 90 Paesi dei cinque continenti. Tra di loro alcuni Cardinali e il Patriarca Maronita di Antiochia, Arcivescovi, Vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, membri di Istituti secolari, operatori pastorali laici, nonché numerosi rappresentanti di associazioni o movimenti cattolici, ecclesiali e laici. Erano presenti, inoltre, sei Delegati Fraterni provenienti dal Patriarcato Ecumenico, dal Patriarcato Rumeno Ortodosso, dalla Chiesa Ortodossa di Grecia, dalla Comunione Anglicana, dalla Federazione Luterana Mondiale e dal Consiglio Mondiale delle Chiese.
3. Il Congresso è stato inaugurato solennemente da S.E. il Cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, alla presenza dell’On. Angelino Alfano, Ministro degli Interni del Governo Italiano, di Ambasciatori e Rappresentanti delle missioni diplomatiche accreditate presso la Santa Sede, della Dott.ssa Francesca Di Giovanni, in rappresentanza della Seconda Sezione per le Relazioni con gli Stati della Segreteria di Stato, che ha pronunciato un intervento, dei membri delle organizzazioni internazionali e non governative, tra cui l’invitato d’onore l’Ambasciatore William Lacy Swing, Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, esperti e rappresentanti di organizzazioni direttamente o indirettamente impegnate nel benessere materiale e spirituale dei migranti.
4. Il Congresso era stato concepito in modo tale che ciascuna giornata fosse dedicata ad un argomento specifico nel più ampio contesto del tema dell’evento. La metodologia applicata in ciascuna giornata di lavoro era strutturata in modo da culminare, attraverso varie conferenze e successivi dibattiti (tavole rotonde) sugli interventi principali, nello scambio personale e nella messa in comune di idee e riflessioni concrete durante i gruppi di lavoro del pomeriggio.
5. Il primo giorno del Congresso, martedì 18 novembre 2014, è stato aperto dalla concelebrazione eucaristica all’Altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro, presieduta da S.E. il Cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Dicastero. Le sessioni di lavoro erano dedicate al tema della diaspora, in particolare alla migrazione per lavoro, fenomeno caratteristico di numerose nazioni. La conferenza principale è stata svolta da S.E. il Cardinale Luis Antonio Tagle, Arcivescovo di Manila e Membro del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, sul tema “Diaspora e Cooperazione allo sviluppo del mondo e della Chiesa”. Nel contesto di questo intervento è emerso un aspetto importante spesso condizionato dalla migrazione per lavoro, cioè quello della famiglia. Questa è stata al centro della prima Tavola rotonda, intitolata “Famiglia migrante nel contesto della diaspora”, a cui sono stati invitati tre oratori provenienti da altrettanti contesti culturali per condividere il proprio punto di vista sull’argomento: S.E. Mons. John Charles Wester, Vescovo di Salt Lake City (USA), S.E. Mons. Lucio Andrice Muandula, Vescovo di Xai-Xai (Mozambico), e S.E. Mons. Mario Toso, Vescovo Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e la Pace (Santa Sede). La Tavola rotonda è stata moderata da Mons. Domenico Pompili, Sotto-Segretario della Conferenza Episcopale Italiana.
6. Continuando la riflessione sulla cooperazione e lo sviluppo della pastorale delle migrazioni, la parola chiave dei lavori della seconda giornata (mercoledì 19 novembre) è stata “partner”. L’intervento principale, dal titolo “I migranti in qualità di partner nello sviluppo dei Paesi d’origine, di transito e di destinazione”, è stato svolto dal Dott. Johan Ketelers, Segretario generale della Commissione Internazionale Cattolica per le Migrazioni (CICM), di Ginevra, e Consultore del Pontificio Consiglio. Il concetto di “partner” è stato poi sviluppato nel corso del dibattito della seconda Tavola rotonda, che ha preso in considerazione “Il ruolo delle donne migranti tra cooperazione e sviluppo”. Tre oratori, Suor Patricia Ebegbulem da Lagos (Nigeria), Coordinatrice dell’ “African Network Against Human Trafficking”, la Dott.ssa Martina Liebsch, Advocacy and Policy Director di Caritas Internationalis (Santa Sede), e Suor Rosita Milesi da Brasilia (Brasile), Direttrice dell’Istituto delle Migrazioni e dei Diritti Umani (Instituto Migrações e Direitos Humanos), hanno partecipato al dibattito, che è stato moderato dalla Dott.ssa Angela Ambrogetti, giornalista e direttrice di www.korazym.org (Italia).
7. La terza giornata del Congresso, giovedì 20 novembre, è stata dedicata al tema della dignità del migrante. L’oratore della conferenza principale, dal titolo “Dignità del migrante, creato a immagine e somiglianza di Dio, figlio di Dio, in cui è impressa l’immagine di Cristo migrante”, è stato S.E. l’Arcivescovo Silvano M. Tomasi, Osservatore Permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, a Ginevra (Svizzera). La terza Tavola rotonda ha prestato attenzione alla questione dei giovani migranti e al loro ruolo nella società e nella Chiesa. I tre oratori invitati, incaricati di sviluppare e dibattere sul tema “Giovani migranti: potenzialità nel costruire ponti di cooperazione tra le società verso lo sviluppo”, erano: S.E. Mons. José Domingo Ulloa Mendieta, Arcivescovo di Panama City (Panama) e Presidente del SEDAC, S.E. il Vescovo Barthélémy Adoukonou, Segretario del Pontificio Consiglio per la Cultura (Santa Sede), e il Rev. P. Maurizio Pettenà, Direttore Nazionale dell’ “Australian Catholic Migrant & Refugee Office” di Canberra (Australia) e Consultore del Pontificio Consiglio.
8. Durante il Congresso, i partecipanti hanno avuto l’occasione di assistere a brevi presentazioni preparate da undici Conferenze Episcopali, come pure di ascoltare la testimonianza della Dott.ssa Maria De Lourdes Jesus, giornalista capoverdiana residente a Roma, che ha condiviso la propria storia personale di esperienza della migrazione dal proprio Paese e di integrazione nella società italiana. Questi momenti hanno dato l’opportunità di saggiare e di essere testimoni, almeno in piccola parte, della ricchezza e della varietà offerte dalla Chiesa cattolica nella pastorale dei migranti.
9. Il Congresso si è concluso venerdì 21 novembre con l’udienza del Santo Padre Francesco. Dopo la presentazione del Comunicato stampa finale e il discorso di chiusura di S.E. il Cardinale Antonio Maria Vegliò, Presidente del Pontificio Consiglio, nell’Aula Magna della Pontificia Università Urbaniana, i partecipanti si sono mossi alla volta del Palazzo Apostolico, dove sono stati ricevuti dal Santo Padre alle ore 12.00. Rivolgendosi loro, Papa Francesco ha sottolineato che coloro che emigrano aspirano ad un futuro migliore per le loro famiglie, anche a rischio di delusioni e insuccessi. I migranti possono realizzare questo desiderio di un avvenire migliore per se stessi e per le proprie famiglie, ma allo stesso tempo, a ciò si accompagnano anche alcuni problemi. La Chiesa deve rimanere luogo di speranza per i migranti, che vivono spesso situazioni di delusione, sconforto e solitudine. Infine, invocando la protezione della Sacra Famiglia, che ha sperimentato la durezza dell’esilio in Egitto, il Santo Padre ha impartito a tutti i presenti la sua Benedizione apostolica.
II. CONCLUSIONI
L’obiettivo del VII Congresso Mondiale della Pastorale dei Migranti è stato quello di analizzare il fenomeno delle migrazioni, prestando particolare attenzione ai migranti economici. I partecipanti tuttavia riconoscono l’esistenza di flussi migratori misti, che possono consistere di rifugiati, sfollati interni, migranti per motivi climatici, ecc., come pure la difficoltà esistente, a volte, nell’effettuare una distinzione chiara tra questi movimenti.
Tuttavia, alla luce della finalità dell’evento, i partecipanti al Congresso hanno affermato quanto segue:
1. La migrazione continua ad essere un segno dei tempi, in cui la centralità della persona umana e la dignità umana acquisiscono un’importanza sempre maggiore.
2. Lo sviluppo rappresenta un processo dinamico che implica crescita, responsabilizzazione e progresso, e il cui obiettivo finale è quello di incrementare le capacità umane, ampliare l’ambito delle decisioni umane, e creare un ambiente sicuro e stabile in cui tutti i cittadini di uno stesso Paese possano vivere, lavorare e professare la propria fede con dignità ed uguaglianza, tanto nel contesto civile quanto in quello ecclesiale.
3. La dignità umana di ciascun migrante è di somma importanza. Le variabili religiose, etniche, sociali e culturali, la cittadinanza o la mancanza di essa, non cambiano questo fatto che conferisce a ciascun individuo un valore e una dignità inerenti e incommensurabili, in cui ogni vita umana è e deve essere considerata sacra.
4. I benefici che possono derivare dalla presenza dei migranti superano di gran lunga i fattori puramente economici, e ne traggono giovamento non solo i Paesi che ricevono, ma anche quelli d’origine, e in alcuni casi perfino le comunità di transito.
5. Il transito dei migranti riveste una particolare rilevanza. Esso non rappresenta unicamente un semplice collegamento tra la partenza e l’arrivo dei migranti, ma è fonte di alcune delle difficoltà che i migranti vivono.
6. Esiste la spiacevole tendenza da parte delle comunità e delle organizzazioni ecclesiali a lavorare in maniera isolata, creando così un vuoto che può esporre il migrante alla violazione dei suoi diritti ed essere fonte di difficoltà nella creazione di programmi pastorali adeguati nella Chiesa di arrivo (tra questi, la proclamazione del Vangelo, la formazione per la ricezione dei Sacramenti, l’evangelizzazione e l’interiorizzazione dei valori e dei concetti cristiani).
7. La fede e la pietà popolare dei migranti sono espressione della loro esperienza personale della fede cristiana, e rappresentano un legame tra la Chiesa di partenza e quella di arrivo. L’integrazione non implica né una separazione artificiale né un’assimilazione, ma dà piuttosto l’opportunità di identificare il patrimonio culturale del migrante e riconoscere i suoi doni e talenti per il bene comune dell’intera comunità ecclesiale.
8. Le moderne politiche migratorie tendono a sottolineare la dimensione individuale della decisione di una persona di migrare, concentrandosi sull’aspetto lavorativo della migrazione invece di prendere in considerazione la famiglia migrante. In effetti, la politica migratoria nazionale è spesso una delle cause all’origine della separazione familiare e dell’eventuale conseguente rottura delle relazioni familiari.
9. Spesso la famiglia migrante si trova divisa tra l’esperienza di sradicamento dal luogo di origine, da una parte, e la mancanza di integrazione nella nuova società, dall’altra. Ciò crea una sorta di tensione che esercita una forza distruttiva tanto sui singoli individui quanto sull’intera famiglia.
10. La questione della separazione familiare, originata da sistemi di migrazione imperfetti, è motivo di grande preoccupazione/importanza per la pastorale dei migranti, in particolare per i Paesi con una forte diaspora.
11. La pastorale dei migranti deve tener conto della distinzione tra la prima, la seconda e la terza generazione, ciascuna delle quali possiede caratteristiche e difficoltà proprie e specifiche.
12. Oggi le donne migranti sono riconosciute non solo come dipendenti o parte del processo di ricongiungimento familiare, bensì come agenti indipendenti, che provvedono al sostentamento della famiglia e/o sono artefici del proprio progetto migratorio. La migrazione può essere un importante strumento/occasione di responsabilizzazione per le donne.
13. I giovani migranti necessitano di un ambiente sociale che permetta e favorisca il loro sviluppo fisico, culturale, spirituale e morale.
14. Esistono tre aree in cui i giovani migranti possono più chiaramente costruire ponti tra le società, impegnandosi con le persone con cui vivono e al cui fianco lavorano, cioè attraverso i loro rapporti con gli altri, la loro educazione e la loro vita lavorativa.
15. Le sètte continuano a crescere e a rappresentare una sfida concreta alla pastorale dei migranti, in special modo per quanto riguarda le giovani generazioni.
16. Nel più ampio contesto della migrazione, in cui una vasta maggioranza dei migranti moderni non sono né cattolici né cristiani, la cooperazione ecumenica e il dialogo interreligioso rivestono un’enorme importanza.
III. RACCOMANDAZIONI
In considerazione delle conclusioni derivate dal VII Congresso Mondiale, i partecipanti desiderano dichiarare il loro impegno a porre in atto le seguenti raccomandazioni:
1. Le comunità ecclesiali locali devono lavorare assieme per stabilire un comune approccio umano ai problemi e alle difficoltà inerenti la migrazione (ad esempio collaborando con le Conferenze Episcopali, i Governi, le organizzazioni non governative, e le organizzazioni a carattere religioso), al fine di tutelare i diritti dei migranti e prevenire il traffico di esseri umani, lo sfruttamento e altri crimini del genere. Insistendo sul lavoro all’interno delle reti sociali (che inizia dal semplice scambio di contatti, come indirizzi e-mail, numeri di telefono, dettagli Skype e indirizzi degli operatori pastorali per i migranti) si può rafforzare una pastorale più generalizzata.
2. Coloro che, nella Chiesa, hanno la responsabilità della missione dell’insegnamento si sforzeranno di ampliare la loro conoscenza e comprensione del Magistero della Chiesa riguardo la migrazione. Ciò, a sua volta, ha la capacità di trasformare quotidianamente la teoria in pratica a livello locale.
3. I pastori della Chiesa devono parlare con una sola voce in materia di migrazione. La Chiesa è una voce profetica per la corretta integrazione dei migranti nelle comunità di accoglienza, tenendo presente l’universalità della comunità cattolica ecclesiale. Ciò comporta un approccio pastorale più ampio e che vada oltre l’aspetto puramente caritatevole.
4. La Chiesa può fare un uso migliore dei mezzi di comunicazione per incrementare i diritti dei migranti. La sensibilizzazione a livello parrocchiale locale, l’incoraggiamento a votare per la giustizia e l’uguaglianza, la creazione di centri studi e le pubblicazioni hanno la capacità di trasformare la narrazione sulla migrazione. L’opinione pubblica deve essere adeguatamente informata in merito alla vera situazione dei migranti non solo nel Paese di accoglienza, ma anche in quello d’origine.
5. Poiché il fenomeno della migrazione irregolare è motivo di sfruttamento del lavoratore migrante e della sua famiglia, i fedeli devono sostenere politiche di immigrazione più giuste ed inclusive da parte dei Governi, che aiutino il migrante nella sua ricerca di opportunità di lavoro e di migliori condizioni di vita, salvaguardino il ruolo della famiglia e delle donne, e al tempo stesso prevengano lo sfruttamento e/o il traffico di migranti lavoratori e altre forme di abuso.
6. La Chiesa è, a tutti i livelli, una comunità di speranza e d’azione che si esprime attraverso la solidarietà nei confronti dei migranti, la loro difesa (in particolare di bambini e minori non accompagnati), la sensibilizzazione dei fedeli ad un impegno concreto, gli sforzi destinati ad affrontare le cause all’origine della migrazione forzata, e attraverso l’assistenza nella fornitura di cibo, alloggio, cure mediche e assistenza legale ai migranti, a prescindere dal loro status.
7. La Chiesa nel luogo di origine, la Chiesa di transito e quella nel luogo di accoglienza devono migliorare la comunicazione e la comunione, e lavorare insieme per creare programmi di prevenzione, organizzati dalle loro rispettive Conferenze Episcopali.
8. La collaborazione tra Chiesa d’origine e Chiesa d’accoglienza deve essere intensificata, in particolare per quanto riguarda le due prime generazioni di migranti. Attraverso la preparazione degli operatori pastorali e sociali a tendere ponti tra le due realtà, una tale collaborazione richiede un dialogo tra le due culture e tiene conto dei problemi specifici di ciascuna generazione.
9. Tutti gli operatori pastorali al servizio dei migranti devono adoperarsi affinché la voce dei migranti sia ascoltata; ciò, a sua volta, facilita la difesa nei loro confronti. La Chiesa, poi, deve far sì che le loro storie siano riconosciute ed apprezzate.
10. I programmi pastorali diocesani e le iniziative riguardanti i giovani migranti devono concentrarsi sulla loro formazione integrale, che includa la preparazione per diventare collaboratori attivi tra la loro cultura di origine e quella del Paese in cui vivono attualmente. Per una migliore comprensione reciproca, è necessario mettere in rilievo il rispetto della cultura l’uno dell’altro.
11. I programmi pastorali diocesani devono prendere in considerazione la necessità di lavorare con le scuole professionali locali al fine di dare vita a programmi di specializzazione che riconoscano e diano il necessario accredito ai giovani migranti, così che il contributo delle loro capacità e talenti possa, a sua volta, essere un’opportunità per cooperare allo sviluppo del loro Paese d’origine, quando tornano a casa.
12. I programmi di formazione per sacerdoti, religiosi e operatori pastorali devono tener conto delle dimensioni teologica e pastorale dei migranti. La formazione del clero e dei laici, pertanto, richiede formazione interculturale, conoscenza, formazione al dialogo e valorizzazione del potenziale dei migranti, che includa il loro ruolo nella nuova Evangelizzazione. A livello locale, questo si esprime nella necessità di formazione di mediatori culturali, che sappiano parlare la lingua e che capiscano la cultura dei migranti e l’espressione di fede che essi portano con sé.
13. Devono poi essere rafforzati e intensificati la presenza e il ruolo dei Movimenti ecclesiali e delle Associazioni, le cui strutture hanno il vantaggio di operare in un contesto differente (e allo stesso tempo più flessibile) da quello delle strutture ecclesiali formali della pastorale dei migranti.
14. Ogni Conferenza Episcopale, o corrispondente struttura ecclesiale gerarchica delle Chiese Orientali, dovrebbe creare un particolare organismo (ufficio, commissione, sottocommissione) specificamente impegnato nella pastorale delle migrazioni. Questo potrebbe costituire un passo in avanti verso la costruzione di una rete migliore tra le Chiese. Il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, a sua volta, potrebbe essere il punto di riferimento comune o di coordinamento di questa pastorale specifica.
—————