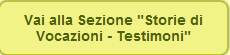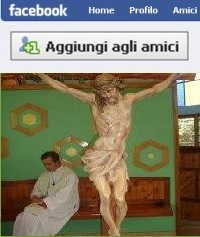Una Vita per la Missione
Dietrich Bonhoeffer, martire del nazismo
27.03.2014 16:02
Dietrich Bonhoeffer nasce a Breslavia (oggi Wroclaw in Polonia) il 4 febbraio 1906, sesto di otto figli. Sua madre, Paula von Hase, è figlia di un professore di teologia. Suo padre, Karl Bonhoeffer, è professore di psichiatria e neurologia, proviene da una famiglia di giuristi e teologi. La madre si assume in prima persona l’insegnamento primario dei suoi figli maggiori. Anche se la famiglia non frequenta assiduamente il culto nella parrocchia luterana, tuttavia la madre si preoccupa di educare i figli al protestantesimo con la preghiera, il canto corale e la lettura della Bibbia in famiglia.
Dietrich è uno studente diligente, brillante e precoce. A sedici anni, ancora liceale, comunica ai genitori il desiderio di studiare teologia e la vocazione al pastorato. Non sappiamo con certezza quando maturò questa vocazione: forse in occasione della morte in guerra nel 1918 del fratello maggiore Walter. Nel 1923 Bonhoeffer inizia gli studi di teologia a Tubinga. Nel 1927, a 21 anni, riceve il dottorato con una tesi dal titolo “Sanctorum communio. Una ricerca dogmatica sulla sociologia della Chiesa”. Si tratta di una ricerca dogmatica sulla Chiesa come luogo concreto della manifestazione di Dio.
Dopo aver superato questa prima tappa universitaria, assume un ministero pastorale: per un anno, dal 1928-1929, è pastore vicario nella parrocchia di lingua tedesca a Barcellona; nell’anno seguente ritorna a Berlino dove si dedica alla formazione di un gruppo di adolescenti poveri del quartiere periferico di Wedding e nel contempo insegna teologia sistematica, segue il seminario di von Harnack, redige la sua tesi di abilitazione su un tema filosofico, “Atto ed Essere. Filosofia trascendentale ed ontologia nella teologia sistematica”, dove ricerca una antropologia ecclesiale, ovvero parlare dell’esistenza umana inserita in un contesto sociale che è la comunità ecclesiale, luogo dove si incontra l’altro, cioè il Dio di Gesù Cristo e gli altri uomini.
• La chiesa: è cappellano degli studenti universitari e segue un gruppo di catecumeni nel quartiere operaio di Prenz-lauer Berg; si deve tenere presente che nel 1932 ci sono in Germania più di sei milioni di disoccupati.
• L’università: come docente incaricato tiene alcuni corsi e seminari su La natura della Chiesa, su Creazione e Caduta (è un commento a Gen 1-3), su Chi è e chi era Gesù Cristo? (è un corso di cristologia). Questi corsi e seminari esercitarono un grande interesse tra gli studenti.
• Il movimento ecumenico: partecipa attivamente a varie iniziative e organizzazioni ecumeniche. Per lui l’ecumenismo non è una semplice collaborazione o dialogo tra le Chiese, ma un compito confessante, ovvero quello di confessare la fede nella situazione concreta in cui si vive, in cui si trova ogni Chiesa locale. E non bisogna dimenticare che a quel tempo la Chiesa protestante e la Chiesa cattolica vivevano il problema dell’odio razziale di Hitler, della guerra e dello sfruttamento sociale. L’ecumenismo per Bonhoeffer è il movimento critico del vangelo di fronte agli eventi concreti della società e della chiesa; e in quel tempo gli eventi sono segnati dall’avvento del nazismo al governo, con la Chiesa protestante e, in parte, la Chiesa cattolica schierati a favore.
In questi anni Bonhoeffer coltiva la dimensione personale della fede, riscoprendo la potenza della Bibbia e la forza della preghiera per alimentare sempre meglio i suoi molteplici impegni: per la pace, per l’ecumenismo, per la giustizia, e per il suo ministero pastorale accanto ai catecumeni del quartiere operaio. Si va convincendo che la fede cristiana non è cercare Dio senza il mondo o difendere Dio contro il mondo, ma stare con fedeltà in questo mondo benedetto da Dio, essere accanto a tutti pregando perché giunga il Regno di Dio in questa terra.
Il 30 gennaio 1933 Hitler è nominato cancelliere, primo ministro della Germania. L’avvento del nazismo al governo purtroppo è diventato realtà. La Chiesa protestante e la Chiesa cattolica, salvo alcune eccezioni, appoggiano la politica di Hitler, con la speranza di vedere superata la disoccupazione e allontanata la minaccia del comunismo. Si pensava che Hitler avrebbe comunque garantito ordine, pace sociale e ridato dignità alla Germania… Ma la famiglia Bonhoeffer non si fa alcuna illusione: con Hitler soltanto guerra e terrore.
Il 1° febbraio Dietrich è chiamato a pronunciare una conferenza alla radio di Berlino sul tema “Mutamenti del concetto di capo nella giovane generazione”, dove mette in risalto il concetto idolatrico e seduttore di capo, di Führer. La trasmissione viene subito interrotta. Il 28 febbraio vengono sospesi tutti i diritti della persona, la libertà di stampa, il segreto della corrispondenza epistolare e del telefono. La motivazione è «per la protezione del popolo e dello Stato». In aprile il governo promulga il boicottaggio dei negozi ebrei, la proibizione di ogni funzione pubblica agli ebrei e ai cristiani di discendenza ebraica.
In una conferenza su “La Chiesa di fronte al problema degli ebrei”, Bonhoeffer prende pubblicamente posizione sull’odio razziale. Egli rimane deluso e sconcertato dalla posizione ufficiale della Chiesa protestante, la quale, assieme alla Chiesa cattolica ufficiale (salvo alcune eccezioni), considera l’antisemitismo e l’odio razziale un problema marginale.
Nonostante i suoi numerosi interventi sulla pace, sul Discorso della Montagna, sulla confessione della fede e sul rifiuto dell’eresia neonazista, Bonhoeffer rimane isolato nella sua Chiesa, nel movimento ecumenico e nel mondo accademico. Per questo nell’ottobre del 1933 parte per esercitare il ministero pastorale a Londra in due parrocchie di lingua tedesca. Vi rimane per due anni fino all’aprile del 1935. Qui approfondisce i legami ecumenici e lotta affinché si riconosca la “Chiesa confessante”, che si stava allora costituendo come Chiesa indipendente dallo Stato, come la rappresentante legittima del protestantesimo tedesco.
Intanto in Germania il regime di Hitler ha ormai ben saldo il potere. Bonhoeffer intuisce che bisogna prepararsi a tempi molto duri, non solo per la Germania, ma anche per tutta l’Europa e per tutto il mondo. Bisognava preparare i futuri pastori della Chiesa confessante a contrastare l’ideologia anticristiana del nazismo e a predisporsi per la ricostruzione che avverrà in un lontano futuro. Il 28 agosto in una assise ecumenica in Danimarca, Bonhoeffer lancia un drammatico appello in favore di un grande concilio ecumenico per la pace, affinché i cristiani non si rivolgano le armi gli uni contro gli altri, perché è come rivolgerle contro Cristo. Sarà l’ultimo suo intervento pronunciato in una sessione ecumenica.
Nella primavera del 1935 Bonhoeffer è incaricato dalla Chiesa confessante come responsabile della formazione spirituale e pastorale dei futuri pastori in uno dei cinque Seminari pastorali, quello di Zingst-Finkenwalde, vicino Stettino. Bonhoeffer accetta volentieri questo incarico. Imposta la formazione dei futuri pastori sull’esperienza della vita comune (Bonhoeffer era attratto dalla vita comunitaria dei monasteri), orientata da quattro grandi opzioni di fondo: (a) la confessione di fede di fronte all’eresia del nazismo; (b) la sequela di Gesù Cristo “a caro prezzo”; (c) la cura del culto (preghiera personale e comunitaria) e della vita spirituale (lettura della Bibbia); (d) essere la voce dei “muti” e dei perseguitati (nel caso concreto gli ebrei) contro lo Stato dittatoriale.
Bonhoeffer, attraverso i corsi di teologia, la vita comunitaria e fraterna, la preghiera e la lettura della Bibbia, prepara i futuri pastori alle prove imminenti e alla guerra. E infatti, i suoi seminaristi, per punizione, venivano inviati dalla Gestapo tra le truppe che combattevo al fronte russo. Su 150 giovani, 80 morirono al fronte. L’esperienza di questo Seminario-comunità durerà solo due anni e mezzo. Alla fine del settembre 1939 la Gestapo la chiuderà. I libri che racchiudono questa esperienza sono Sequela, pubblicato nel 1937, e Vita comune, pubblicato nel 1939.
Nel gennaio 1938 il regime nazista proibisce a Bonhoeffer di risiedere a Berlino, tranne per motivi famigliari. Il 18 settembre del 1939 la Germania ha invaso la Polonia: è l’inizio della seconda guerra mondiale. Il 4 settembre 1940 viene proibito a Bonhoeffer di prendere pubblicamente la parola e gli viene ordinato di comunicare alla polizia i suoi soggiorni. La Gestapo lo sta già pedinando. I suoi amici, sapendo che Bonhoeffer è deciso a non prestare il giuramento militare ad Hitler e che dunque rischia di essere giustiziato, ottengono per lui un invito per recarsi ad insegnare negli Stati Uniti. Bonhoeffer vive drammaticamente questo soggiorno: gli sembra di essere diventato un po’ come il profeta Giona, in fuga dalle sue responsabilità.
Il 20 luglio 1944 fallisce l’attentato ad Hitler, che Bonhoeffer aveva appoggiato “per necessità”, come ultima ratio. I legami di Bonhoeffer con i congiurati saranno accertati definitivamente nell’autunno del 1944. Per Bonhoeffer è l’inizio della fine. Viene trasferito nel carcere della Gestapo della Prinz-Albrecht-Strasse e qui sottoposto interrogatori ricattatori e a torture. Da qualche testimonianza del suo compagno di cella veniamo a sapere che Bonhoeffer, nonostante tutto, aveva sempre una parola di fede e speranza per tutti tratte dalla S. Scrittura.
All’inizio del 1945 viene condotto con un gruppo di prigionieri in diversi campi di concentramento. Un ufficiale dei Servizi Segreti, Payne Best, così testimonia: «Bonhoeffer era tutto umiltà e dolcezza. Sembrava sempre emanare da lui un’atmosfera di bontà, di gioia nei più piccoli avvenimenti della vita, di profonda gratitudine per il semplice fatto che lui c’era ancora. […] È uno degli uomini rari che ho incontrato, il cui Dio era reale e anche prossimo a lui».
Il martedì di Pasqua 1945 viene internato nel campo di Flossenbürg. La domenica in Albis, su richiesta dei compagni di prigionia, Bonhoeffer celebra il servizio liturgico: commenta le letture bibliche del giorno e conclude con l’orazione. All’improvviso si spalanca la porta: viene chiamato dalle guardie a recarsi con loro. Raccoglie le sue robe e lasciando la sala dice: «È la fine. Per me, è l’inizio della vita». Il giorno dopo, il 9 aprile 1945, quando già si sente in lontananza l’artiglieria americana, all’età di 39 anni Dietrich Bonhoeffer viene impiccato.
Dopo aver ripercorso l’itinerario tragico della sua esistenza, di D. Bonhoeffer vogliamo ora ripercorrere l’itinerario del suo pensiero teologico-spirituale. Certo, non è stato un intellettuale da “salotto”. La sua riflessione l’ha sempre ancorata alla S. Scrittura – letta, meditata e pregata nello Spirito – e alla vita ecclesiale e sociale del suo tempo (perciò è teologico-spirituale).
Per Bonhoeffer il Cristo-per-me/per-noi, cioè il Cristo Risorto e Vivente, è Colui che oggi si rende presente a noi come Parola, come Sacramento (in particolare nell’Eucaristia), come Comunità. E in queste tre presenze egli si comunica e sta accanto a noi nella sua teo-umanità, vale a dire non solo come Dio ma anche come uomo, cioè con la sua debolezza creaturale, con le complessità, le complicazioni, i fallimenti, i dolori e le gioie della vita. Cristo è uomo e Dio sia nel suo abbassamento che nel suo innalzamento nella Gloria, per cui anche nel suo abbassamento, nella sua debolezza (mangiatoia, croce) egli è Dio, il Dio debole e umile che noi incontriamo e dal quale riceviamo sapienza e forza.
c) La sequela “a caro prezzo”. Che cosa dice Cristo a noi che lo seguiamo? Per rispondere a quest’altra domanda, Bonhoeffer scrive nel 1937 Sequela. Si tratta di un corso che il formatore Bonhoeffer tenne al Seminario-comunità di Finkenwalde per i futuri pastori: esso mostra uno degli orientamenti fondamentali che lui aveva dato alla loro formazione teologica e spirituale. L’opera è una meditazione sulle Beatitudini e il Discorso della Montagna, sulla missione dei discepoli, sulla chiesa come “Corpo di Cristo”. Ci soffermiamo solo su un tema-chiave della sua riflessione: la sequela di Cristo “a caro prezzo”, seguire Lui costi quel che costi.
Bonhoeffer, in polemica con la tradizione luterana, rileva che accentuando solamente la salvezza per grazia, cioè che la salvezza è dono gratuito di Dio e non merito nostro, si dimentica un aspetto essenziale: le opere che a caro prezzo dobbiamo fare proprio in quanto siamo stati salvati per grazia, vale a dire la sequela di Cristo Gesù, l’obbedienza a Dio e alla sua Parola nelle scelte della vita quotidiana. Qui Bonhoeffer ha davanti a sé le derive della chiesa protestante tedesca, la quale, mentre afferma la salvezza per grazia, nello stesso tempo, senza alcun serio discernimento evangelico, accoglie Hitler come l’uomo della provvidenza, come il capo mandato da Dio…
Perciò Bonhoeffer distingue la “grazia a buon mercato” dalla “grazia a caro prezzo”. La “grazia a buon mercato”: è la grazia «come merce in vendita promozionale» dove «il conto è già stato pagato», per cui «tutto si può avere gratis»; è il misconoscimento della potenza efficace della Parola di Dio e della sua incarnazione in Gesù; è il misconoscimento di Gesù Vivo che interpella il nostro oggi; è il perdono senza pentimento e conversione, è l’accoglienza della grazia «senza bisogno che cambi qualcosa del nostro modo di vivere», dove anzi avanza sempre di più l’omologazione alle logiche idolatriche, evidenti e sottili, presenti nel mondo.
La “grazia a caro prezzo” invece è tutto l’opposto: è la sequela di Cristo Gesù sulla via della croce, sulla via del dono di sé, senza sconti, è l’obbedienza alla Parola di Dio viva ed efficace; è «il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale l’uomo va a vendere con gioia tutto ciò che aveva; […] la signoria regale di Cristo, per amore del quale l’uomo strappa da sé l’occhio che lo scandalizza […]; il vangelo che si deve sempre di nuovo cercare, il dono per cui si deve sempre di nuovo pregare, la porta cui si deve sempre di nuovo bussare. [..] La grazia è a caro prezzo soprattutto perché è costata cara a Dio, perché gli è costata cara la vita del Figlio – “siete stati riscattati a caro prezzo” (1Cor 6,20) – e perché non può essere a buon mercato per noi ciò che è costato caro a Dio».
Perché Bonhoeffer ha cambiato prospettiva? Perché, guardando l’atteggiamento omologante della sua chiesa nei confronti del nazismo, comprende che ciò che rende credibile l’evangelizzazione non è la comunicazione della “pura dottrina” ma la “forma della chiesa”, lo stile di vita della chiesa, cioè dei suoi fedeli e dei suoi pastori. E la forma della chiesa è la “sequela a caro prezzo”, il suo fondamento è la Parola di Dio incarnata in Cristo Gesù. Indicata la prospettiva, Bonhoeffer traccia sapientemente lo stile dell’evangelizzatore. Egli non è il padrone ma il testimone della Parola che lo traversa, lo interpella in prima persona e lo fa vivere.
Da qui per Bonhoeffer è evidente che la Chiesa è una comunità e non una somma di individui. La chiesa è una comunione di santi che sono anche peccatori, i quali hanno bisogno del perdono di Dio ma anche del perdono reciproco. Quindi nella Chiesa si dovrebbe prendere le distanze da ogni forma di individualismo e di autoreferenzialità, come pure da ogni forma di culto idolatrico del capo e di ricerca di potere e di privilegi, e, alla sequela di Cristo, invece vivere come Chiesa-per-gli-altri e come Chiesa-con-gli-altri, vale a dire come Chiesa del servizio e come Chiesa della comunione, della riconciliazione e della pace; perché il “luogo” vero della Chiesa non è il “luogo” che ella stessa si sceglie per garantire la propria sopravvivenza, ma il “luogo” che le sceglie Cristo, dove Lui la pone tra gli uomini e al servizio degli uomini che per una causa giusta, tra mille contraddizioni, faticano, soffrono e gioiscono.
Così tra me e l’altro, c’è un terzo che ci unisce (comunione e non “fusione”) e nello stesso tempo ci tiene discretamente distanti (solitudine e non isolamento), e questo Terzo è Gesù Cristo. Per questo è importante per Bonhoeffer, nella edificazione quotidiana della vita comune cristiana, oltre la meditazione della Parola di Dio e la preghiera, anche, davanti a Dio, la reciproca intercessione e, tra i fratelli, la confessione reciproca delle colpe (che non è il sacramento della riconciliazione).
La Chiesa, a motivo dell’incarnazione di Cristo, Dio l’ha posta e voluta nel mondo. Ora, afferma Bonhoeffer, il mondo, con tutta la sua complessità, è diventato adulto, non ha più bisogno di un “dio tappabuchi” a cui ricorrere per dare risposte là dove la scienza oggi rimane muta (non sappiamo per il futuro). Il Dio della Bibbia non è un “dio tappabuchi”: egli si rivela nel suo abbassamento in Gesù Cristo come un Dio vulnerabile che ci aiuta a dare un senso alla vita, stando accanto a noi nella sofferenza. Questo Dio i cristiani sono chiamati a testimoniare nel mondo, senza venir meno alle loro responsabilità.
—————