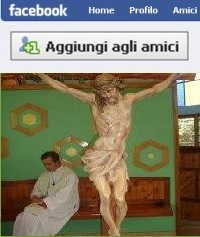Una Vita per la Missione

Nota: Cliccando sul documento interessato in grassetto verde, si verrà indirizzati direttamente al documento in questione
PRINCIPALI DOCUMENTI SULLA MISSIONE
1. Magistero Pontificio
- Maximum illud (30 novembre 1919). Lettera apostolica di Benedetto XV, influenzata dal Beato Conforti, sulla propagazione della fede cattolica in tutto il mondo. Scopo della missione: la gloria di Dio e la salvezza dell’anima.
- Rerum Ecclesiae (28 febbraio 1926). Lettera enciclica di Pio XI sull’incremento delle missioni (raccomanda il clero indigeno). Scopo della missione è dilatare il regno di Cristo. L’evangelizzazione di tutti i popoli è "continua sollecitudine" del Papa.
- Evangelii praecones (2 giugno 1951). Lettera enciclica di Pio XII per il rinnovato impulso alla missione, nel 25° della Rerum Ecclesiae (rispetto della cultura). Scopo della missione: procurare nuovi seguaci di Cristo e "plantatio ecclesiae".
- Fidei donum (21 aprile 1957). Lettera enciclica di Pio XII, sulla condizione delle missioni cattoliche in Africa. Si richiama il concorso di tutta la Chiesa nell’opera missionaria e l’aiuto scambievole tra le Chiese con l’invio di sacerdoti.
- Princeps pastorum (28 novembre 1959). Lettera enciclica di Giovanni XXIII, nel 240° della Maximum illud. Scopo della missione: dalle missioni alle Chiese locali. Importanza dei laici ed educazione del clero locale.
- Nostra aetate (28 ottobre 1965). Dichiarazione del Concilio Vaticano II sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane.
- Ad gentes - (7 dicembre 1965). Decreto del Concilio Vaticano II sull’attività missionaria della Chiesa. Scopo della missione è la dilatazione nel tempo e nello spazio della missione di Cristo (n. 3):
- Ecclesiae sanctae (6 agosto 1966). Lettera apostolica "motu proprio" di Paolo VI. Norme per l’applicazione di alcuni decreti del Concilio Vaticano II, specie dell’Ad gentes:
- Quo aptius (24 febbraio 1969). Istruzione della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli sulla cooperazione missionaria dei vescovi attraverso le Pontificie Opere missionarie e la solidarietà delle diocesi per le missioni.
- Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975). Esortazione apostolica di Paolo VI, sull’evangelizzazione nel mondo contemporaneo.
- Postquam apostoli (25 marzo 1980). Nota direttiva della Congregazione per il Clero, sulla collaborazione fra le Chiese particolari. La Nota contiene affermazioni importanti:
- Slavorum Apostoli (2 giugno 1985). Lettera enciclica di Giovanni Paolo II, sull’opera evangelizzatrice dei Santi Cirillo e Metodio. Scopo della missione: rincarnare l’evangelo nella cultura dei popoli.
- Redemptoris missio (7 dicembre 1990). Lettera enciclica di Giovanni Paolo II, sulla permanente validità del mandato missionario. Vera "summa" missionaria.
- Dialogo ed annuncio (19 maggio 1991). Istruzione del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso e della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Note e norme sull’annuncio del Vangelo e il dialogo interreligioso.
- Ecclesia in Africa (14 settembre 1995). Esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II sulla Chiesa in Africa e la sua missione evangelizzatrice.
- Tertio millennio adveniente (10 novembre 1994). Lettera apostolica di Giovanni Paolo II, per il Giubileo del 2000, sulla missione della Chiesa all’interno dell’universale famiglia umana.
- Cooperatio missionalis (1 ottobre 1998). Istruzione della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Aggiornamento della precedente Istruzione Quo aptius (24 febbraio 1969) sulla cooperazione missionaria.
- Ecclesia in America (22 gennaio 1999). Esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II sull’incontro con Gesù Cristo vivo, via per la conversione e la solidarietà in America.
- Porta fidei (11 ottobre 2011) Lettera apostolica in forma di motu proprio di Benedetto XVI con la quale si indice l'anno della fede.
2. Magistero episcopale italiano
- Evangelizzazione del mondo contemporaneo (28 febbraio 1974). Documento dell’episcopato italiano in preparazione della IV Assemblea generale ordinaria del sinodo dei vescovi.
- La cooperazione missionaria della Chiesa che è in Italia (21 gennaio 1975). Documento della Commissione episcopale per la cooperazione tra le Chiese ().
- Il coordinamento delle attività di cooperazione missionaria (30 marzo 1978). Documento della Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese, sulla struttura generale dell’organizzazione della cooperazione missionaria nella Chiesa locale.
- L’impegno missionario della Chiesa italiana (25 marzo 1982). Documento pastorale della Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese. Pubblicato a 25 anni dall’enciclica Fidei donum, è il primo "Direttorio" per l’impegno missionario della Chiesa italiana. Propone alla Chiesa italiana di uscire da se stessa e di mettersi in cammino per la costruzione del regno di Dio in tutto il mondo. Propone i Centri Missionari Diocesani come luogo e strumento per sostenere l’impegno missionario (n. 43).
- L’impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani (21 aprile 1982). Nota pastorale della Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese, sul servizio missionario dei sacerdoti diocesani italiani in Africa e America Latina nel XXV anniversario dell’enciclica Fidei donum.
- Sacerdoti in missione nelle Chiese sorelle (2 giugno 1984). Nota pastorale della Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese sulla valutazione del servizio missionario promosso dalla Fidei donum.
- Comunione e comunità missionaria (22 giugno 1986). Documento pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Il Convegno Ecclesiale di Loreto (1985) aveva parlato di "nuova missionarietà" e, l’anno dopo, questo documento iscrive le scelte pastorali della Chiesa italiana nell’orizzonte della missione universale.
- Catechisti per una Chiesa missionaria (29 giugno 1986). Messaggio del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana al primo Convegno nazionale dei catechisti italiani.
- Gli istituti missionari nel dinamismo della Chiesa italiana (10 febbraio 1987). Nota pastorale della Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese. La Nota riafferma la validità degli istituti missionari - e delle congregazioni religiose aventi missioni - e, nello stesso tempo, invita a rievidenziare il fatto che sono espressione e sostegno dell’impegno per la missione universale della Chiesa locale.
- Il laici nella missione "ad gentes" e nella cooperazione tra i popoli (25 gennaio 1990). Nota pastorale della Commissione Episcopale per la cooperazione tra le Chiese. È il riconoscimento dell’accresciuta presenza dei laici all’interno della cooperazione missionaria.
- Evangelizzazione e testimonianza della carità - (8 dicembre 1990). Documento della Conferenza Episcopale Italiana. Orientamenti pastorali per gli anni ’90. La C.E.I., nel tracciare le linee orientative per la pastorale del decennio, insiste sulla responsabilità che hanno le nostre Chiese in ordine alla prima evangelizzazione di altri contesti e alla cooperazione missionaria con le altre Chiese sorelle del Sud del mondo e dell’Est europeo.
- Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il Convegno di Palermo (26 maggio 1996). Nota pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. La nuova evangelizzazione sul territorio riceverà slancio e ispirazione da una sincera ed effettiva apertura alla missione universale.
- Orientamenti pastorali dal 2003 ai nostri giorni
- - Seminari e Convegni
- Vademecum - Gli aiuti della Chiesa italiana ai paesi in via di sviluppo. Frutto di un seminario di studio (22-24 febbraio 1990) dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e di altri organismi ecclesiali. È un tentativo per individuare orientamenti comuni in merito alla cooperazione internazionale delle comunità cattoliche, sul piano degli aiuti economici.
- Prospettive dell’impegno missionario della Chiesa italiana. Atti del primo Convegno Missionario Nazionale (Verona, 12-15 settembre 1990). L’impegno missionario, comune responsabilità di tutti. Il Centro Missionario Diocesano luogo di coordinamento della realtà missionaria.
- A 13 anni dal documento "Postquam Apostoli". Atti del Seminario di studio (Roma, 21-24 giugno 1993). Come le Chiese particolari in Italia si sono rinnovate per vivere la cooperazione interecclesiale e missionaria, in modo speciale attraverso una migliore distribuzione del clero e per trovare nuovo slancio.
- La dimensione missionaria nel piano pastorale della Chiesa particolare. Atti del Convegno (Collevalenza, 19-22 aprile 1994). La missione al cuore della pastorale di ogni comunità.
- Preti per la missione - La dimensione missionaria nella spiritualità del presbitero diocesano. Atti del Convegno (Roma, 3-6 febbraio 1997). Risvegliare la spiritualità missionaria dei presbiteri diocesani perché ricordino che il loro ministero è per tutto il mondo e conducano le loro comunità a vivere la dimensione universale della fede.
- Il fuoco della missione - Per un rinnovato slancio missionario delle comunità cristiane. Atti del secondo Convegno Missionario Nazionale (Bellaria, 10-13 settembre 1998). Accogliere e annunciare il Vangelo tenendo come punto di riferimento il mondo nella sua globalità: interpellati dai problemi e dalle sfide più urgenti e confrontati con l’esperienza evangelizzatrice delle giovani Chiese.

MAXIMUM ILLUD
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XV
AI PATRIARCHI, PRIMATI,
ARCIVESCOVI E VESCOVI
DEL MONDO CATTOLICO
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI MISSIONARI
NEL MONDO
Venerabili Fratelli,
salute e Apostolica Benedizione.
La grande e sublime missione che, sul punto di ritornare al Padre, il Nostro Signore Gesù Cristo affidò ai suoi discepoli quando disse: « Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura » [1], non doveva certamente terminare con la morte degli Apostoli, ma durare, per mezzo dei loro successori, sino alla fine dei tempi, cioè sino a quando fossero esistiti sulla terra degli uomini da salvare col magistero della verità. È infatti fin da quel giorno che « essi andavano e predicarono per ogni dove » [2], e in modo che la « loro voce si è diffusa per tutta la terra, e le loro parole sino ai confini del mondo » [3]. La Chiesa di Dio, memore del divino mandato, non cessò mai, attraverso il corso dei secoli, di inviare per ogni dove banditori e ministri della divina parola che annunziassero l’eterna salvezza recata al genere umano da Cristo. Persino durante il periodo dei primi tre secoli del cristianesimo, quando la furia delle persecuzioni, scatenate dall’inferno, pareva dovesse affogare nel sangue la Chiesa nascente, la voce del Vangelo fu bandita e risuonò fino agli estremi confini dell’Impero Romano. E quando poi furono concesse pubblicamente alla Chiesa la pace e la libertà, assai maggiori furono i suoi progressi compiuti con l’apostolato in tutto il mondo, per opera specialmente di uomini insigni per zelo e santità. È l’epoca in cui Gregorio l’Illuminatore conduce l’Armenia alla fede cristiana; Vittorino la Stiria; Frumenzio l’Etiopia; quando Patrizio conquista a Cristo gl’Irlandesi; Agostino gli Inglesi; Colomba e Palladio gli Scoti; Clemente Willibrord, il primo Vescovo di Utrecht, evangelizza l’Olanda, Bonifacio e Ausgario la Germania, Cirillo e Metodio gli Slavi. Allargandosi ancora la cerchia dell’apostolato, Guglielmo de Rubruquis penetra con la face del Vangelo fra i Mongoli, il beato Gregorio X manda missionari in Cina, e i figli di Francesco d’Assisi poco dopo vi stabiliscono una fiorente cristianità, abbattuta in seguito dalla tempesta della persecuzione.
Poi, scoperta l’America, una schiera di uomini apostolici, fra i quali è da ricordare principalmente Bartolomeo Las Casas, gloria e luce dell’Ordine Domenicano, si consacra alla protezione di poveri indigeni, contro l’infame tirannia degli uomini, allo scopo di liberarli dalla durissima schiavitù dei demoni. Nella stessa epoca Francesco Saverio, degno egli pure di essere paragonato agli Apostoli, dopo aver tanto sudato nelle Indie Orientali e nel Giappone per la gloria di Dio e la salvezza delle anime, muore sul limitare dell’Impero Cinese, verso il quale anelava, quasi dischiudendo con la sua morte la via ad una nuova evangelizzazione di quelle sterminate regioni, dove i solerti figli di tanti Ordini religiosi e di tanti Istituti missionari avrebbero esercitato l’apostolato tra mille vicissitudini.
Infine l’Australia, l’ultimo continente scoperto, e parimenti l’Africa centrale, esplorate con audacia e costanza, ricevettero gli araldi della Fede cristiana; e nell’immenso mare Pacifico non esiste alcuna isola, per quanto sperduta, che non sia stata raggiunta dallo zelo operoso dei nostri Missionari.
Fra questi, molti, anelando alla salvezza dei propri fratelli, sull’esempio degli Apostoli giunsero ai fastigi della santità. E molti altri, coronando con il martirio il loro apostolato, suggellarono la loro Fede con il sangue.
In verità, è motivo di grande stupore constatare che, dopo tante così gravi fatiche sofferte dai nostri nel propagare la Fede, dopo tante illustri imprese ed esempi di invitta fortezza, siano ancora così numerosi coloro che giacciono nelle tenebre e nelle ombre della morte, dato che il numero degli infedeli, secondo un recente computo, arriva al miliardo.
Noi, pertanto, commiserando l’infelicità di una così rilevante moltitudine di anime, e desiderosi, per sacro dovere Apostolico, di renderle partecipi della divina Redenzione, vediamo con viva gioia e conforto che, sotto l’influsso dello Spirito di Dio, va ogni giorno aumentando in varie parti della cristianità lo zelo dei buoni nel promuovere e sviluppare le sacre Missioni fra gl’infedeli. E appunto per assecondare questo movimento e dargli vigoroso impulso in tutto il mondo, come dobbiamo e ardentemente auspichiamo, Noi, dopo avere implorato insistentemente lume ed aiuto dal Signore, inviamo a voi, Venerabili Fratelli, questa lettera, che infervori voi, il vostro clero e i popoli a voi affidati, e vi indichi in qual modo possiate giovare a questa santissima causa.
Innanzi tutto rivolgiamo la parola a coloro che, in qualità di Vescovi o di Vicari o di Prefetti Apostolici, presiedono alle sacre Missioni; da loro infatti dipende direttamente la propagazione della Fede, ed è in loro che la Chiesa tiene riposta la speranza della sua maggiore espansione. Non ignoriamo quanto sia vivo in loro lo spirito dell’apostolato. Ci sono ben note le immense difficoltà che essi hanno dovuto superare e l’ardue prove che hanno subìto, specie in questi ultimi anni, non solo per non perdere le posizioni già acquisite, ma anche per dilatare sempre più il regno di Dio. Tuttavia, ben conoscendo il loro attaccamento e la loro filiale pietà verso questa Sede Apostolica, apriamo loro con piena fiducia il Nostro cuore, come farebbe un padre coi suoi figli. Pensino dunque innanzi tutto che essi, come si dice, devono essere l’anima della loro Missione. Perciò siano specialmente col loro zelo di esemplare edificazione ai loro sacerdoti e cooperatori, esortandoli e incoraggiandoli sempre a maggior bene. Poiché tutti quelli che in qualsivoglia modo lavorano in questa vigna del Signore devono capire, sperimentare, e diremo quasi sentire che essi nel superiore hanno un vero padre, vigile, diligente, pieno di premura e di carità, che tutto e tutti abbracciando affettuosamente condivide con loro gioie e dolori, asseconda e promuove ogni buona iniziativa e, in una parola, considera come cosa sua propria tutto ciò che a loro appartiene. La sorte di una Missione dipende, si può dire, dal modo con cui è diretta: perciò può riuscire assai dannosa l’inidoneità di chi la governa. Infatti, chi si consacra all’Apostolato delle Missioni, abbandona patria, famiglia e parenti; si avventura spesso a un lungo e pericoloso viaggio, disposto e pronto a tollerare qualunque travaglio pur di guadagnare moltissime anime a Cristo. Se egli pertanto ha un superiore che lo assiste in ogni circostanza con provvida carità, non v’è dubbio che l’opera riuscirà assai fruttuosa; altrimenti v’è assai da temere che egli, abbattuto a poco a poco dalle contrarietà e dai disagi, finisca con l’abbandonarsi in braccio allo scoraggiamento e all’inerzia.
Inoltre, chi presiede a una Missione deve cercare di dare ad essa il massimo incremento e sviluppo. Essendo infatti affidato alla sua cura tutto il territorio della sua Missione, è chiaro che egli dovrà rispondere dell’eterna salvezza di tutti gli abitanti di quella regione. Perciò egli non si deve accontentare di avere conquistato alla Fede, fra tutta quella moltitudine, qualche migliaio di anime, ma procuri di coltivare e di mantenere coloro che ha dato a Gesù Cristo, in modo che nessuno di essi ritorni sulla via della perdizione. E non creda di avere compiuto interamente il suo dovere, se prima non si sarà adoperato con tutte le sue forze a cristianizzare anche il restante numero di infedeli, che è di solito di gran lunga superiore. Perciò, per facilitare sempre più la predicazione del Vangelo, sarà di notevole giovamento creare nuovi centri e nuove cristianità, che daranno poi luogo,a loro volta, a nuovi Vicariati o Prefetture, quando si giudichi opportuno di suddividere quella Missione. A questo proposito Ci piace dare una meritata lode a quei Vicari Apostolici i quali, così facendo, contribuiscono a far prosperare il Regno di Dio, e che, ove non possano trovare nuovi cooperatori nel proprio Ordine, sono ben lieti di accoglierne altri di diversa famiglia religiosa.
Al contrario, quanto sarebbe riprovevole la condotta di colui che, essendogli stata assegnata da coltivare una parte della vigna del Signore, la considerasse come esclusiva sua proprietà, geloso che altre mani gliela tocchino. E quale tremenda responsabilità non verrebbe egli ad incontrare dinanzi all’eterno giudice, specialmente se trovandosi la sua piccola cristianità — come spesso avviene — quasi perduta in mezzo ad una moltitudine di infedeli e non bastando alla catechizzazione di questi la sua opera con quella dei suoi, si ostinasse a non chiedere l’aiuto di altri cooperatori! Invece il Superiore della Missione, che è premuroso soltanto della gloria di Dio e della salvezza delle anime, se occorre chiama cooperatori da ogni parte perché lo aiutino nel suo santo ministero, senza badare se essi siano di un altro Ordine o di diversa nazionalità, « purché ad ogni modo sia annunziato Cristo » [4]; e non chiama solo coadiutori, ma anche coadiutrici, per le scuole, per gli orfanotrofi, per i ricoveri, per gli ospedali, ben persuaso che tutte queste opere di carità sono un mezzo efficacissimo nelle mani della divina Provvidenza per la propagazione della Fede.
Inoltre, il buon Superiore della Missione non restringe la sua azione al suo solo territorio, disinteressandosi di quanto accade al di fuori; ma quando lo richieda la carità di Cristo o la sua gloria — la sola cosa che a lui importi — cerca di stare in relazione con i suoi colleghi confinanti. Vi sono infatti sovente degli interessi che riguardano la stessa regione, i quali non possono essere ben curati senza il comune accordo. Ed è pure assai vantaggioso per la Religione che i capi delle Missioni, potendo, tengano periodicamente delle adunanze per consigliarsi e incoraggiarsi a vicenda. Infine, chi presiede alla Missione deve rivolgere le sue principali premure alla buona formazione del clero indigeno, sul quale specialmente sono riposte le migliori speranze delle nuove cristianità. Infatti il sacerdote indigeno, avendo comuni con i suoi connazionali l’origine, l’indole, la mentalità e le aspirazioni, è meravigliosamente adatto a instillare nei loro cuori la Fede, perché più di ogni altro conosce le vie della persuasione. Perciò accade spesso che egli giunga con tutta facilità dove non può arrivare il missionario straniero.
Affinché però possa conseguire i frutti sperati, è assolutamente necessario che il clero indigeno sia istruito ed educato come si conviene. Non è quindi sufficiente una formazione qualsiasi e rudimentale, tanto da poter essere ammesso al sacerdozio, ma essa deve essere completa e perfetta come quella che si suol dare ai sacerdoti delle nazioni civili. Insomma, non si deve formare un clero indigeno quasi di classe inferiore, da essere soltanto adibito nelle mansioni secondarie, ma tale che, mentre si trovi all’altezza del suo sacro ministero, possa un giorno assumere egli stesso il governo di una cristianità. Poiché, come la Chiesa di Dio è universale, e quindi per nulla straniera presso nessun popolo, così è conveniente che in ciascuna nazione vi siano dei sacerdoti capaci di indirizzare, come maestri e guide, per la via dell’eterna salute i propri connazionali. Dove dunque esisterà una quantità sufficiente di clero indigeno ben istruito e degno della sua santa vocazione, ivi la Chiesa potrà dirsi bene fondata, e l’opera del Missionario compiuta. E se mai si levasse il nembo della persecuzione per abbattere quella Chiesa, non vi sarebbe da temere che, con quella base e con quelle radici così salde, essa non soccomberebbe agli assalti nemici.
Per la verità, la Sede Apostolica ha sempre insistito perché questo importantissimo compito fosse ben compreso dai Superiori delle Missioni ed effettuato con tutto l’impegno: ne siano prova gli antichi e nuovi Collegi fondati in quest’alma Città per la formazione dei chierici esteri, specialmente di rito orientale. E nonostante ciò, vi sono ancora purtroppo delle regioni in cui, benché la Fede cattolica vi sia penetrata da secoli, non vi si riscontra che un clero indigeno assai scadente. Parimenti vi sono parecchi popoli, che pure hanno già raggiunto un alto grado di civiltà sì da poter presentare uomini ragguardevoli in ogni ramo dell’industria e della scienza, e tuttavia, benché da secoli sotto l’influenza del Vangelo e della Chiesa, ancora non hanno potuto avere Vescovi proprî che li governassero, né sacerdoti così influenti da guidare i loro concittadini. Questo dimostra che nell’educare il clero destinato alle Missioni si è finora seguito qua e là un metodo assai difettoso e manchevole. Ad ovviare perciò ad un tale inconveniente, vogliamo che la Sacra Congregazione di Propaganda Fide prenda, come crederà opportuno, misure e disposizioni adatte per le varie regioni; s’interessi della fondazione e del buon andamento dei Seminari sia regionali che interdiocesani; e sorvegli in modo particolare la formazione del clero nei singoli Vicariati e nelle diverse Missioni.
Ed ora rivolgiamo il discorso a voi, dilettissimi Figli, quanti siete, coltivatori della vigna del Signore, da cui più direttamente dipendono la propagazione della verità cristiana e la salvezza di tante anime. Anzitutto è necessario che voi abbiate un gran concetto della vostra eccelsa vocazione. Pensate che l’incarico a voi affidato è assolutamente divino ed è al di sopra dei piccoli interessi umani, perché voi recate la luce a chi giace nelle ombre di morte, dischiudete la porta del cielo a chi corre verso la rovina eterna. Considerando dunque che a ciascuno di voi fu detto dal Signore: « Scordati del tuo popolo, e della casa di tuo padre » [5], ricordatevi che voi non dovete propagare il regno degli uomini ma quello di Cristo, e non aggiungere cittadini alla patria terrena, ma a quella celeste. Da qui si comprende quanto sarebbe deplorevole se vi fossero Missionari i quali, dimentichi della propria dignità, pensassero più alla loro patria terrestre che a quella celeste; e fossero preoccupati di dilatarne la potenza e la gloria al di sopra di tutte le cose. Sarebbe questa una delle più tristi piaghe dell’apostolato, che paralizzerebbe nel Missionario lo zelo per le anime, e ne ridurrebbe l’autorità presso gl’indigeni. Questi, infatti, quantunque barbari e selvaggi, comprendono sufficientemente ciò che vuole e cerca da loro il Missionario, e conoscono, si direbbe al fiuto, se egli ha per caso altre mire all’infuori del loro bene spirituale. Poniamo che egli non abbia del tutto deposto questi intenti umani, e non si comporti pienamente da vero uomo apostolico, ma dia motivo a supporre che egli faccia gl’interessi della sua patria; senz’altro tutta l’opera sua diverrà sospetta alla popolazione; la quale facilmente sarà indotta a credere che la religione cristiana non sia altro che la religione di una data nazione, abbracciando la quale uno viene a mettersi alla dipendenza di uno stato estero, rinunciando in tal modo alla propria nazionalità.
E veramente Ci recano gran dispiacere certe Riviste di Missioni, sorte in questi ultimi tempi, nelle quali più che lo zelo di estendere il regno di Dio, appare evidente il desiderio di allargare l’influenza del proprio paese: e stupisce che da esse non trapeli nessuna preoccupazione del grave pericolo di alienare in tal modo l’animo dei pagani dalla santa religione. Non così il Missionario cattolico, degno di questo nome. Non dimenticando mai che non è un inviato della sua patria, ma di Cristo, egli si comporta in modo che ognuno può indubbiamente riconoscere in lui un ministro di quella religione che, abbracciando tutti gli uomini che adorano Dio in spirito e verità, non è straniera a nessuna nazione, e « dove non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, Barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo in tutti » [6].
Un altro grave inconveniente da cui deve con ogni cura guardarsi il Missionario è il cercare altri guadagni che non siano quelli delle anime. Non occorre a questo riguardo che spendiamo troppe parole. Come potrebbe, infatti, colui che fosse avido del danaro cercare unicamente e convenientemente la gloria di Dio, come è suo dovere e, per promuoverla, salvando il suo prossimo, essere pronto a sacrificare ogni suo avere e la stessa sua vita? Si aggiunga che egli in tal modo verrebbe a perdere molto della sua autorità e del suo prestigio presso gli infedeli, specialmente se questa smania di lucro, come facilmente accade, fosse già in lui diventata avarizia: perché nessuna cosa, più di questo sordido vizio, è spregevole al cospetto degli uomini e più sconveniente al regno di Dio. Il buon predicatore del Vangelo, invece, imiti anche in ciò accuratamente l’Apostolo delle genti, il quale non solo disse a Timoteo: « Quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, contentiamoci di questo » [7], ma ebbe in tanta considerazione il disinteresse che, pure in mezzo a tantissime attività del suo ministero, si procurava il vitto con il lavoro delle sue mani.
Senonché, prima di iniziare il suo apostolato, occorre che il Missionario vi si disponga con un’accurata preparazione; quantunque si potrebbe osservare che non v’è poi bisogno di tanta scienza per chi va a predicare Cristo in mezzo ai popoli rozzi e incivili. Infatti, sebbene sia vero che a convertire e salvare le anime è immensamente più efficace la virtù che il sapere, però, se uno non si sarà acquistato prima un certo corredo di dottrina, s’accorgerebbe in seguito del gran presidio che gli manca per conseguire il successo nel suo santo ministero. Poiché non è raro il caso che il Missionario si trovi senza libri e senza la possibilità di consultare qualche dotta persona; e che intanto debba rispondere alle obiezioni mossegli contro la Fede, e sciogliere questioni e problemi difficilissimi. A ciò si aggiunga che quanto più egli si mostrerà istruito, tanto maggiore sarà la stima che godrà fra la gente; in specie poi se si troverà tra un popolo che ha in pregio e in onore lo studio e il sapere; conseguentemente sarebbe assai sconveniente che i banditori della verità fossero inferiori ai ministri dell’errore. Pertanto, mentre i seminaristi chiamati da Dio saranno preparati convenientemente per le Missioni estere, dovranno essere istruiti in tutte le discipline che occorrono al Missionario, sia sacre che profane. E ciò appunto vogliamo che sia fatto con ogni cura nelle scuole del Pontificio Collegio di Propaganda Fide; dove pure ordiniamo che d’ora innanzi sia impartito uno speciale insegnamento di tutto ciò che ha attinenza con le Missioni.
La prima cosa che il Missionario deve conoscere è la lingua del popolo, alla cui conversione intende dedicarsi. E non basta che ne abbia una conoscenza qualsiasi, ma bisogna che la possieda in modo da poterla parlare correttamente e con speditezza. Infatti egli è debitore ad ogni sorta di persone, tanto ai rozzi quanto ai sapienti; né può ignorare quanto sia facile ad uno che parli bene, accattivarsi la benevolenza di tutti. Riguardo alla spiegazione della dottrina cristiana, il diligente Missionario non l’affidi ai catechisti, ma la tenga per sé come una mansione tutta sua propria, anzi come il principale dei suoi obblighi, ben sapendo che per nessun altro scopo egli è stato mandato da Dio se non per predicare il Vangelo. Talvolta può accadere che come ministro e rappresentante della santa religione egli debba comparire davanti alle autorità del paese, oppure sia invitato a qualche adunanza di dotti: e allora come potrebbe sostenere il decoro del suo grado, se, per ignoranza della lingua, non sapesse esprimere i suoi pensieri?
Noi pertanto proprio questo abbiamo avuto testé di mira quando, per dare sviluppo e incremento alla Chiesa in Oriente, abbiamo fondato qui in Roma uno speciale Istituto perché coloro che si daranno all’apostolato in quelle regioni riescano ben addottrinati in ogni cosa, ma specialmente nella conoscenza delle lingue e dei costumi d’Oriente. E poiché questo Istituto Ci pare di una grande opportunità, approfittiamo di questa occasione per esortare tutti i Superiori degli Ordini e delle Famiglie religiose, a cui sono affidate Missioni in Oriente, di mandar quivi i loro alunni, destinati alle stesse Missioni, perché vi acquistino una solida cultura.
Ma innanzi tutto, a colui che si accinge all’apostolato è indispensabile, come abbiamo già detto, la santità della vita. Infatti è necessario che sia uomo di Dio colui che Dio predica, e abbia in odio il peccato chi tal odio intìma. Specialmente presso gli infedeli, che sono guidati più dall’istinto che dalla ragione, è assai più profittevole la predica dell’esempio che quella delle parole. Sia pur dotato il Missionario dei più bei pregi di mente e di cuore, sia pur pieno di dottrina e di cultura; ma se queste qualità non sono congiunte ad una vita intemerata e santa, ben poca o nessuna efficacia esse avranno per la salvezza dei popoli; anzi il più delle volte saranno di nocumento a lui stesso ed agli altri.
Sia egli adunque esemplarmente umile, obbediente e casto: sia specialmente pio, dedito alla preghiera e in continua unione con Dio, patrocinando con zelo presso di Lui la causa delle anime. Poiché quanto più sarà congiunto con Dio, tanto più abbondantemente gli sarà concessa la grazia del Signore. Ascolti l’esortazione dell’Apostolo: « Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza » [8]. Rimossi tutti gli ostacoli con l’aiuto di queste virtù, l’accesso della verità nei cuori degli uomini è facile ed agevole, e non vi è volontà tanto pervicace che possa resistere. Pertanto il Missionario che, ad imitazione del Signore Gesù, arda di carità, riconoscendo anche nei più perduti pagani dei figliuoli di Dio, redenti con lo stesso prezzo del sangue divino, non si irrita per la loro rozzezza, non si sgomenta dinnanzi alla perversità dei loro costumi, non li disprezza o disdegna, non li tratta con asprezza e severità,ma cerca di attirarli con tutte le dolcezze della benignità cristiana, per condurli un giorno all’abbraccio di Cristo, il Buon Pastore. In proposito egli suole meditare quel passo della Sacra Scrittura: « Quanto è benigno e soave, o Signore, il tuo spirito in tutte le cose! Pertanto, tu a poco a poco correggi gli erranti, e li ammonisci per i loro peccati, e parli loro affinché, messa da parte la malizia, credano in te, o Signore… Ma tu, sovrano della virtù, giudichi senza passione e con grande indulgenza ci governi » [9]. E quale mai avversità, quale traversia o pericolosa contingenza potrà scoraggiare un simile messo di Gesù Cristo? Nessuna: poiché, riconoscente come egli è verso Dio che l’ha chiamato ad una missione così eccelsa, egli è disposto a tutto, a tollerare generosamente i disagi, le villanie, la fame, le privazioni, la stessa morte più dura, pur di strappare anche una sola anima dalle fauci dell’inferno.
Con questi intendimenti e propositi, il Missionario, sull’esempio di Cristo Signore e degli Apostoli, s’accinge fidente a compiere il suo mandato: ma si ricordi di riporre ogni sua fiducia in Dio. È tutto un lavoro divino, come dicemmo, la propagazione della sapienza cristiana, poiché Dio solo sa penetrare nelle anime, illuminare le menti con lo splendore del vero, accendere nei cuori la fiamma della virtù, e apprestare all’uomo le opportune energie perché possa abbracciare e seguire ciò che egli ha conosciuto come vero e buono. Quindi se il Signore non aiuterà il Ministro affaticato, sarà vano ogni suo sforzo. Malgrado tutto ciò, proceda egli pure animosamente nel suo lavoro, confidando nel soccorso della grazia divina, la quale non viene mai negata a chi la invoca.
A questo punto non si possono ignorare le donne, le quali, fin dai primordi del cristianesimo, hanno efficacemente collaborato con i predicatori nella diffusione del Vangelo. E sono specialmente degne di una ben meritata lode quelle vergini consacrate a Dio, che si trovano in gran numero nelle sacre Missioni, dedite o all’educazione dei fanciulli o ad altre svariate opere di pietà e di beneficenza: e vogliamo che esse da questa Nostra lode prendano nuova lena e coraggio per accrescere sempre più le loro benemerenze a favore della Chiesa; tenendo per certo che la loro opera sarà tanto più vantaggiosa, quanto più esse s’impegneranno alla propria perfezione spirituale.
Ed ora Ci piace rivolgere la parola a tutti coloro che, per gran misericordia di Dio, sono già in possesso della vera fede e ne fruiscono gl’immensi benefizi. Innanzi tutto devono por mente allo strettissimo obbligo che a loro incombe di aiutare le Missioni. Infatti, Dio « comandò a ciascuno di aver cura del proprio prossimo » [10], e questo dovere è tanto più stretto quanto maggiore è il bisogno in cui versa il prossimo. Ma chi, più dell’infedele, ha bisogno del nostro fraterno soccorso, trovandosi egli nell’infelicità di non conoscere Iddio, in balia delle più sfrenate passioni e sotto la durissima tirannia del demonio? Perciò tutti coloro che contribuiscono, secondo le proprie forze, ad illuminarli, soprattutto aiutando l’opera dei Missionari, forniscono a Dio la più gradita testimonianza della loro gratitudine per averli favoriti del dono della Fede.
Gli aiuti che si possono fornire alle Missioni, e che i Missionari non cessano di chiedere, sono di tre tipi. Il primo è alla portata di tutti, ed è di rendere loro propizio il Signore per mezzo della preghiera. Già più di una volta abbiamo osservato che l’opera dei Missionari sarà sterile e vana se non verrà fecondata dalla grazia divina; come diceva di sé Paolo: « Io piantai, Apollo innaffiò; ma è Dio che ha fatto crescere » [11]. Per impetrare poi questa grazia non vi è che un modo: esso consiste nella perseveranza della preghiera umile, avendo detto il Signore: « Qualsiasi cosa domanderanno, sarà loro concessa dal Padre mio » [12]. Né vi può essere dubbio riguardo all’esaudimento di questa preghiera, trattandosi di una causa così nobile e così accetta agli occhi di Dio. Perciò, come un giorno Mosè in cima al colle, alzando le mani al cielo, impetrava il divino aiuto a favore degli Israeliti che combattevano contro gli Amaleciti, cosi tutti i cristiani devono, pregando, levare aiuto ai banditori del Vangelo, mentre questi sudano nella vigna del Signore. E poiché appunto a tale scopo è stato istituito l’« Apostolato della preghiera », Noi qui lo raccomandiamo vivamente a tutti i fedeli, augurandoCi che nessuno si rifiuterà di appartenervi, ma che tutti, anzi, vorranno, se non di fatto, almeno con il cuore partecipare alle sante fatiche apostoliche.
In secondo luogo, è necessario sopperire alla scarsità dei Missionari, che, se era già sentita prima, si è fatta molto più sensibile dopo la guerra, così che parecchie parti della vigna del Signore difettano di coltivatori. Noi pertanto facciamo appello alla vostra diligenza, Venerabili Fratelli: e voi farete cosa degna del vostro amore per la religione, se stimolerete nel clero e negli alunni del Seminario diocesano la vocazione alle Missioni appena qualcuno ne dia la testimonianza. Non lasciatevi ingannare da alcuna immagine di bene o da considerazioni umane, temendo che sia sottratto alla vostra diocesi quanto avrete dato alle Missioni. Al posto di un Missionario che voi lascerete partire, Dio susciterà più sacerdoti che saranno utilissimi alla vostra diocesi. E qui facciamo vive premure ai Superiori degli Ordini e degli Istituti religiosi che si dedicano alle Missioni estere, perché vogliano destinarvi soltanto il fiore dei loro alunni, coloro cioè che per santità di vita, spirito di sacrifizio e zelo delle anime si mostrino veramente idonei all’arduo ministero dell’apostolato. E quando i Superiori verranno a sapere che i loro Missionari hanno felicemente portato qualche popolazione dalla turpe superstizione alla sapienza cristiana e vi hanno fondato una chiesa abbastanza stabile, permettano pure che tali veterani soldati di Cristo si trasferiscano per strappare un altro popolo dalle mani del diavolo e lascino ad altri, senza rimpianto, il compito di ingrandire e migliorare quanto da loro stessi assicurato a Cristo. In tal modo, mentre contribuiranno a giovare ad una grande quantità di anime, attireranno anche sulle loro Famiglie religiose i più eletti doni della bontà divina.
Ma per sostenere le Missioni si richiedono anche i mezzi materiali, e non pochi, specialmente essendone di molto cresciuti i bisogni a seguito della guerra, che ha devastato o distrutto scuole, ricoveri, ospedali, dispensari ed altre fondazioni di carità. Facciamo quindi caldo appello a tutti i buoni, perché nei limiti delle proprie forze, vogliano largamente provvedervi. Infatti, « Se uno ha ricchezze di questo mondo, e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l’amore di Dio? » [13]. Così l’Apostolo Giovanni, parlando di coloro che sono oppressi dalle necessità materiali. Ma quanto più in questo caso si deve osservare la santa legge della carità, trattandosi non solo di soccorrere una infinita quantità di gente che si dibatte fra la miseria e la fame, ma anche e principalmente di strappare una moltitudine ingente di anime dalla schiavitù di Satana per conquistarla alla libertà dei figliuoli di Dio? Pertanto desideriamo in special modo che siano aiutate dalla generosità dei cattolici quelle opere che sono appositamente istituite a vantaggio delle Missioni. E in primo luogo l’«Opera della Propagazione della Fede », tante volte dai Pontefici Nostri Predecessori encomiata e vogliamo che la Sacra Congregazione della Propaganda ne prenda una particolare cura perché diventi ogni giorno più feconda di ottimi frutti. Essa principalmente ha da fornire gli ampi mezzi richiesti per il mantenimento delle Missioni già create e delle altre che si dovranno formare: confidiamo pertanto che i cattolici del mondo intero non vorranno permettere che mentre altri dispongono di potenti mezzi per spargere l’errore, i nostri per diffondere la verità abbiano a lottare con l’indigenza. Raccomandiamo pure vivamente l’«Opera della Santa Infanzia », che si propone di amministrare il Battesimo ai bambini moribondi degli infedeli. Opera tanto più commendevole perché vi possono partecipare anche i nostri fanciulli, i quali così, venendo a conoscere quanto sia inestimabile il dono della Fede, imparano anche a portare il loro contributo assieme ad altri. Né va dimenticata l’« Opera di San Pietro », la quale ha per scopo la buona formazione del clero indigeno delle Missioni. Così pure vogliamo sia diligentemente osservato ciò che fu prescritto dal Nostro Predecessore di felice memoria Leone XIII: cioè che nel giorno dell’Epifania si raccolga in tutte le chiese del mondo l’obolo « per il riscatto degli schiavi dell’Africa » e che il ricavato sia trasmesso alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide.
Ma perché i Nostri voti più sicuramente e felicemente si adempiano, è necessario che voi, Venerabili Fratelli, organizziate, in un modo affatto speciale, il vostro clero a proposito delle Missioni. I fedeli sono generalmente ben disposti e propensi a soccorrere l’opera dell’apostolato; e non bisogna che lasciate disperdere queste buone disposizioni, anzi cerchiate di trarne il maggior profitto per le Missioni. A questo scopo sappiate che è Nostro desiderio che sia istituita in tutte le diocesi dell’orbe cattolico l’associazione chiamata « Unione Missionaria del Clero »; e vogliamo che essa sia alle dipendenze della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, alla quale abbiamo già dato a questo scopo tutte le opportune facoltà. Fondata or non è molto in Italia, questa associazione si è in breve diffusa in varie regioni, e siccome gode di tutto il Nostro favore, è stata da Noi già arricchita di molte Indulgenze. E ben a ragione: poiché, mediante essa, l’azione del clero viene ad essere sapientemente ordinata, sia ad interessare i fedeli nella conversione di tanti pagani, sia a dare sviluppo e incremento a tutte le Opere già approvate da questa Sede Apostolica a beneficio delle Missioni.
Ecco, Venerabili Fratelli, quanto volevamo comunicarvi intorno alla propagazione della Fede in tutto il mondo. Se tutti faranno, come ne siamo certi, il loro dovere, i Missionari all’estero e i fedeli in patria, possiamo fondatamente sperare che le sacre Missioni, riavutesi dai gravissimi danni della guerra, ritorneranno a prosperare. E qui, sembrandoCi che il divino Maestro esorti Noi pure, come un giorno Pietro, con le parole: « Avanti, prendi il largo » [14], un grande ardore di paterna carità Ci spinge a voler condurre tutta intera l’umanità all’amplesso di Lui. Infatti aleggia sempre vivo e potente lo Spirito di Dio sulla sua Chiesa, né può restare infruttuoso lo zelo di tanti uomini apostolici che lavorarono e lavorano tuttora a dilatarne i confini. Stimolati dal loro esempio, sorgeranno altre schiere di apostoli che, sorretti dalle preghiere e dalla generosità dei buoni, conquisteranno a Cristo tantissime anime.
Sia propizia ai comuni voti la grande Madre di Dio, Regina degli Apostoli,e impetri sui banditori del Vangelo l’effusione dello Spirito Santo; con l’auspicio di Lei, e come pegno di paterna benevolenza, impartiamo di cuore a voi, Venerabili Fratelli, al vostro Clero e al vostro popolo l’Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 novembre 1919, anno sesto del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
PER SCARICARE LA LETTERA APOSTOLICA "MAXIMUM ILLUD" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

RERUM ECCLESIAE
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO XI
AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI,
PRIMATI, ARCIVESCOVI, VESCOVI
ED AGLI ALTRI ORDINARI
AVENTI PACE E COMUNIONE
CON LA SEDE APOSTOLICA:
CHE ISTITUISCE UN MUSEO MISSIONARIO
DA ALLESTIRE NEL PALAZZO DEL LATERANO
Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione.
Esaminando con attenzione gli annali della Chiesa, a nessuno può sfuggire come, fin dai primi secoli del Cristianesimo, i Romani Pontefici rivolsero le loro principali cure e provvidenze a che si diffondessero la luce della dottrina evangelica e i benefìci della civiltà cristiana ai popoli che ancora « giacevano nelle tenebre e nell’ombra della morte », senza fermarsi mai per difficoltà incontrate o per ostacoli che si frapponessero. E veramente, altro intento non ha la Chiesa se non di rendere partecipe tutto il genere umano dei frutti della Redenzione, dilatando in tutta la terra il regno di Cristo; e il Vicario in terra di Gesù, Principe dei Pastori, chiunque egli sia, lungi dal potersi appagare della semplice difesa e custodia del gregge divinamente affidatogli da governare, ove non voglia venir meno ad uno dei principali suoi obblighi deve altresì procurare con ogni zelo di guadagnare a Cristo quanti ne sono ancora lontani. Orbene, in ogni tempo i Nostri predecessori, com’è noto, eseguirono fedelmente il loro divino mandato d’insegnare e di battezzare tutte le genti; e i sacerdoti da loro inviati, non pochi dei quali, o per esimia santità di vita o per il martirio incontrato, sono pubblicamente venerati dalla Chiesa, si adoperarono, sia pure con vario esito, ad illuminare della nostra fede l’Europa e poscia regioni fino allora ignote man mano che venivano scoperte ed esplorate. Con varietà di successo, diciamo; perché accadde talora che dopo tanti tentativi e fatiche riuscite quasi inutili, e uccisi o cacciati i Missionari dal campo che avevano cominciato a dissodare, questo o riuscì appena a perdere un poco della sua selvatichezza, o pur essendo già stato cambiato in un giardino smaltato di fiori, in processo di tempo, abbandonato a se stesso, andò a poco a poco nuovamente ingombrandosi di spini e di rovi. Tuttavia è motivo di consolazione il vedere come in questi ultimi anni gli Istituti, che si dedicano alle Missioni tra gli infedeli, hanno raddoppiato il lavoro ed i frutti, e che da parte dei fedeli alle aumentate opere dei Missionari si rispose con l’aumento dei sussidi. Al che certo grandemente conferì la Lettera Apostolica, che l’immediato Nostro predecessore, di s.m., indirizzò all’Episcopato il 30 novembre 1919 « sulla propagazione della fede cattolica nel mondo »; perché in essa, mentre il Pontefice ne stimolava la diligenza e lo zelo nel procurare aiuti, indicava con sapientissimi avvisi ai Vicari e ai Prefetti Apostolici gl’inconvenienti da rimuovere e le opere da praticarsi dai loro dipendenti per rendere più fruttuoso l’esercizio del sacro apostolato.
Quanto a Noi, Venerabili Fratelli, ben sapete che fino dagli inizi del Pontificato Ci siamo proposti di adoperarCi con ogni mezzo per spianare ai popoli pagani l’unica via della salute recando ogni giorno più oltre, per mezzo dei predicatori apostolici, la luce della verità evangelica. In tale proposito Ci parve di fermare il Nostro desiderio su due punti, ambedue, più che opportuni, necessarii, e l’uno strettamente unito con l’altro; vale a dire, il numero molto maggiore di operai evangelici, ben formati e corredati di svariate cognizioni, da inviarsi nelle sterminate regioni ancora prive della cultura cristiana, e la maggiore intelligenza del dovere che stringe i fedeli a cooperare ad un’Opera così santa e fruttuosa con entusiasmo e fervore, con l’assiduità delle preghiere e con la generosità. E non fu questo anche lo scopo per cui volemmo che sorgesse la Mostra Missionaria Vaticana? E, grazie alla benignità del Signore, molti cuori giovanili, come Ci fu detto, al vedersi quasi spettatori della grazia divina e della magnanimità e nobiltà umana, concepirono i primi germi della vocazione apostolica; e l’ammirazione per gli operai evangelici, da cui furono pervase tante schiere di visitatori, Ci fa fin d’ora prevedere, con buoni motivi di speranza, che essa non sarà vana né sterile di frutti. Ma perché non abbiano ad essere dimenticati o a venir meno gli insegnamenti così importanti che gli stessi oggetti delle Missioni nella eloquenza del loro silenzio impartirono, abbiamo ordinato, come già saprete, l’istituzione di un Museo dove collocare con disposizione più opportuna gli oggetti scelti fra i principali. Tale Museo sorgerà nel Nostro Palazzo del Laterano; in quel luogo, cioè, dal quale, concessa la pace alla Chiesa, dai Nostri predecessori furono poi inviati tanti uomini apostolici, mirabili per santità di vita e per lo zelo della religione, in quelle terre che sembravano «già biondeggiare di messi ». Così tutti i Missionari che, gregarii e specialmente capitani, per così dire, visiteranno il Museo, confrontando tra di loro le statistiche e i metodi di ciascuna Missione, ne trarranno ispirazione per opere migliori e più grandi; e anche i semplici fedeli; crediamo, proveranno la stessa commozione di coloro che hanno esaltato la Mostra Vaticana. Intanto, per meglio infiammare all’azione l’ardore accesosi nel popolo cristiano per le Missioni, indirizziamo a Voi, Venerabili Fratelli, il Nostro appello, implorando l’aiuto della vostra operosità. Se mai in altra impresa fu conveniente e necessario che voi vi impegnaste, la dignità del vostro ufficio ed anche il vostro affetto filiale per Noi non vi permettono di non adoperarvi in questa occasione con ogni zelo e diligenza. Certo, per parte Nostra, fino a quando la divina Provvidenza Ci manterrà in vita, questo dovere del Nostro ufficio apostolico Ci terrà in continua sollecitudine, perché ripensando sovente che i pagani sono tuttora circa un miliardo non abbiamo requie nel Nostro spirito [1] e Ci sembra di sentirCi intimare all’orecchio «Grida, non darti posa, alza la tua voce come una tromba » [2].
Non occorre insistere per dimostrare quanto sarebbe alieno dalla virtù della carità, che riguarda Dio e tutti gli uomini, se coloro che appartengono all’ovile di Cristo non si dessero pensiero dei miseri i quali vanno errando lontano. Certo il debito di carità che ci stringe a Dio richiede non solo che procuriamo di accrescere il numero di coloro i quali lo conoscono e lo adorano « in spirito e verità» [3], ma altresì che assoggettiamo al regno dell’amabilissimo Redentore quanti più possiamo, affinché riesca ogni giorno più fruttuosa « l’utilità nel sangue suo » [4] e ci rendiamo sempre meglio accettevoli a lui, mentre sopra ogni altra cosa a lui torna gradito che gli uomini si salvino e giungano al riconoscimento della verità [5]. Che se Gesù Cristo diede come carattere distintivo dei suoi seguaci l’amore vicendevole [6], potremmo noi forse dimostrare ai nostri prossimi carità maggiore o più insigne, che procurando di trarli dalle tenebre della superstizione e d’istruirli nella vera fede di Cristo? Anzi, questo supera qualunque altra opera o prova di carità, come l’anima è più pregevole del corpo, il cielo della terra, l’eternità del tempo; e chiunque esercita quest’opera di carità secondo le sue forze, dimostra di stimare il dono della fede quant’è giusto che lo stimi, e inoltre manifesta la sua gratitudine verso la bontà di Dio partecipando ai poveri infedeli questo stesso dono, il più prezioso di tutti, e con ciò gli altri beni che ad esso vanno uniti. Se nessun fedele può esimersi da tale dovere, potrà forse esimersene il clero, che per una mirabile scelta e vocazione partecipa del sacerdozio ed apostolato di Gesù Cristo, Nostro Signore, potrete esimervene voi, Venerabili Fratelli, che insigniti della pienezza del sacerdozio siete divinamente costituiti pastori, ciascuno per la sua parte, del clero e del popolo cristiano? Certo è che leggiamo aver Gesù Cristo ordinato, non solo a Pietro, la cui cattedra Noi occupiamo, ma a tutti gli Apostoli di cui voi siete i successori: « Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura » [7]; dal che appare appartenere sì a Noi la cura della propagazione della fede, ma in modo che anche voi dovete partecipare con Noi a tale impresa e aiutarCi per quanto ve lo permette l’adempimento de1 vostro ufficio particolare. Non v’incresca dunque, Venerabili Fratelli, seguire volonterosamente le Nostre paterne esortazioni, sapendo che Dio ci domanderà un giorno stretto conto di così importante affare.
Anzitutto, con la parola e con gli scritti procurate di introdurre e di gradatamente estendere la santa consuetudine di pregare « il Padrone della messe, perché mandi operai alla sua messe » [8], e d’implorare per gl’infedeli gli aiuti del lume e della grazia celeste; e a ragion veduta parliamo di consuetudine e di usanza stabile e continua, che, come ognun vede, presso la divina misericordia ha più valore ed efficacia che non preghiere indette o una volta sola o di quando in quando. E veramente i predicatori evangelici potrebbero ben affaticarsi, e versar sudori, e dare anche la vita per condurre i pagani alla religione cattolica; potrebbero usare ogni industria, ogni diligenza e ogni genere di mezzi umani; ma tutto ciò non gioverebbe a nulla, tutto cadrebbe a vuoto, se Dio con la sua grazia non toccasse i cuori degli infedeli per intenerirli e trarli a sé. Ora è facile capire che, non mancando a nessuno la possibilità della preghiera, tutti hanno in mano questo aiuto e questo quasi alimento delle Missioni; perciò farete cosa conforme ai Nostri desideri e all’indole e al sentimento dei fedeli, se ordinerete di aggiungere, per esempio, al Rosario della Beata Vergine e ad altre simili preghiere, solite a recitarsi nelle parrocchie e nelle altre chiese, qualche preghiera speciale per le Missioni e per la conversione dei pagani alla fede. A questo intento, Venerabili Fratelli, siano chiamati a cooperare e si infiammino specialmente i fanciulli e le Religiose; bramiamo cioè che negli asili, negli orfanotrofi, nelle scuole, nei collegi giovanili e nelle case e conventi di Religiose salga ogni giorno la preghiera al cielo per far discendere su tanti infelici, su tante popolose nazioni pagane la misericordia divina; ad anime pure ed innocenti che potrà mai rifiutare il Padre celeste? D’altra parte tale usanza dà a sperare che nel tenero cuore dei giovanetti, avvezzatisi a pregare per la salute degli infedeli col primo sbocciare del fiore della carità, possa con l’aiuto di Dio insinuarsi il desiderio dell’apostolato: desiderio che, coltivato con cura, darà forse con l’andar del tempo buoni operai al ministero apostolico.
Tocchiamo qui di passaggio un argomento degno, Venerabili Fratelli, della vostra più attenta considerazione. A tutti sono noti i gravissimi danni recati alla propagazione della fede dall’ultima guerra, mentre dei Missionari gli uni, richiamati in patria, caddero nell’immane conflitto, gli altri allontanati dal campo delle loro fatiche dovettero lasciare per molto tempo il proprio terreno incolto; danni e perdite che si dovettero e si debbono tuttora riparare, né solo per far ritornare le cose allo stato di prima, ma anche per farle progredire e prosperare.
Inoltre, sia che si guardino le sterminate estensioni di luoghi non ancora aperti alla cristiana civiltà, o l’immenso numero di coloro che sono ancora privi dei benefìci della redenzione, o le necessità e le difficoltà da cui i missionari, per la scarsezza del numero, si sentono impacciati e trattenuti, è necessario che i Vescovi e tutti i cattolici si adoperino concordemente perché il numero dei sacri legati cresca e si moltiplichi. Pertanto se in ogni vostra diocesi vi sono giovinetti o chierici o sacerdoti, che diano segno di essere da Dio chiamati a così sublime apostolato, anziché contrastarli in alcun modo, dovete col favore e con l’autorità vostra secondarne le propensioni e i desiderii. Vi sarà lecito, senza dubbio, di mettere a prova spassionatamente gli spiriti per vedere se sono da Dio [9], ma una volta convinti che l’ottimo proposito sia nato e vada maturando per ispirazione di Dio, non penuria di clero né necessità alcuna della diocesi devono disanimarvi e trattenervi dal dare il consenso, mentre quelli delle vostre contrade, avendo, diciamo così, sotto mano i mezzi di salute, sono molto meno lontani dalla salvezza che non siano gli infedeli, massime quelli che persistono nella loro ferocia e barbarie. Offrendosi poi l’occasione di un fatto simile, incontrate di buona voglia, per amor di Cristo e delle anime, la perdita di qualcuno dal clero, se pur perdita debba dirsi; giacché se vi priverete di qualche coadiutore e compagno delle vostre fatiche, il Divino Fondatore della Chiesa certamente supplirà o col versare più copiose grazie sulla diocesi o col suscitare nuove vocazioni al sacro ministero. Nondimeno, perché questa faccenda si leghi bene con le altre cure dell’ufficio pastorale, cercate d’istituire presso di voi l’Unione Missionaria del clero, o, se già è istituita, incitatela col consiglio, con l’esortazione, con l’autorità vostra ad un’azione sempre più viva. Tale Unione, provvidenzialmente fondata otto anni or sono dal Nostro immediato antecessore, fu arricchita di molte indulgenze e posta sotto la giurisdizione della S. Congregazione di Propaganda; diffusasi, poi, in questi ultimi anni, in molte diocesi dell’Orbe cattolico, Noi medesimi l’abbiamo onorata, non una volta sola, con testimonianze di pontificia benevolenza. Tutti i sacerdoti che ad essa appartengono e, nel modo conveniente alla loro condizione, gli alunni delle sacre discipline, secondo lo scopo dell’istituzione, chiedono essi stessi, massime nel Santo Sacrificio della Messa, e stimolano gli altri a chiedere il dono della Fede per le innumerevoli moltitudini d’infedeli; ogni volta, e dovunque per loro si possa, predicano al popolo circa l’apostolato da promuovere presso gl’infedeli, ovvero procurano che di tanto in tanto, in giorni e adunanze stabilite, se ne tratti in comune e fruttuosamente; diffondono nel popolo opuscoli di propaganda; e dove in alcuno riscontrino felicemente i semi di siffatto apostolato, gli procurano i mezzi per la debita formazione ed istruzione; in tutti i modi favoriscono entro i confini della propria diocesi l’Opera della Propagazione della Fede, e le altre due che sono ad essa sussidiarie. Quante offerte poi abbia raccolte sinora l’Unione Missionaria del Clero per aiutare queste stesse opere, quante di più in futuro ne lasci sperare — crescendo la generosità dei fedeli d’anno in anno — voi non l’ignorate, Venerabili Fratelli; parecchi di essi, ciascuno nel proprio territorio, vengono utilizzati come patroni e sollecitatori; è da desiderare tuttavia che ormai non vi sia più ecclesiastico alcuno, il quale non arda della fiamma di questa carità. Infatti all’Opera della Propagazione della Fede, principale fra tutte le altre opere Missionarie, che (salva la gloria della piissima donna la quale ne fu la fondatrice, e della città di Lione), trasferimmo qua, con rinnovato ordinamento, dandole in certo modo la cittadinanza romana, è necessario che il popolo cristiano venga in soccorso con una liberalità pari alle molteplici necessità delle Missioni presenti e di quelle che si aggiungeranno in futuro.
Quante e quanto grandi siano tali necessità e quale sia per lo più la povertà dei banditori del Vangelo, appariva abbastanza dalla stessa Mostra Vaticana; ma forse tanti e tanti non se ne accorsero neppure, abbagliati com’erano dalla quantità, dalla novità e dalla bellezza delle cose esposte. Non abbiate vergogna dunque e non vi rincresca, Venerabili Fratelli, di farvi quasi mendicanti per Cristo e per la salute delle anime; con lo scritto e con l’eloquenza che scaturisce dal cuore, insistete presso i vostri fedeli perché con il proprio fervore e con munificenza moltiplichino e rendano molto più copiosa la messe che l’Opera della Propagazione della Fede raccoglie ogni anno. Siccome poi nessuno è da ritenere più bisognoso e nudo, nessuno più infermo e affamato e assetato di chi è privo della cognizione e della grazia di Dio, non v’è chi non veda che a chi usa misericordia verso uomini che sono i più miseri, non mancheranno certo la misericordia e la rimunerazione divina.
All’Opera principale della Propagazione della Fede si aggiungono, come dicemmo, altre due, le quali, poiché la Sede Apostolica le ha fatte sue, i fedeli cristiani a preferenza di altre opere, che hanno scopi particolari, con offerte date o raccolte da ogni parte debbono aiutare e mantenere, vale a dire l’Opera intitolata della San Infanzia e l’altra di San Pietro Apostolo. Ufficio di quella è, com’è ben noto a tutti, invitare i nostri fanciulli perché si abituino a risparmiare e ad offrire tali somme specialmente per la redenzione e l’educazione cattolica dei bambini degli infedeli, nei luoghi dove si suole abbandonarli od ucciderli; compito di questa è operare con preghiere e collette affinché scelti giovani indigeni possano essere debitamente formati nei Seminari ed assunti ai sacri Ordini, affinché più facilmente coloro che appartengono alla stessa razza possano, con l’andare del tempo, venire convertiti a Cristo od essere rafforzati nella fede.
A questo sodalizio di San Pietro Apostolo, come sapete, poco tempo fa demmo per patrona celeste Teresa del Bambino Gesù, come colei che, mentre viveva quaggiù la vita claustrale, prendeva sotto la sua cura e, per dir così, adottava questo o quel missionario per aiutarlo, come soleva, con le preghiere, con le volontarie o prescritte penitenze corporali e soprattutto offrendo al Divino Sposo i veementi spasimi della malattia, di cui soffriva. E Noi, sotto gli auspici della vergine di Lisieux, Chi ripromettiamo più abbondanti frutti; ed in proposito grandemente Ci rallegriamo che Vescovi in gran numero si siano compiaciuti di farsi soci perpetui dell’Opera, che Seminari ed altre unioni di giovani cattolici si siano impegnati a sostenere le spese del mantenimento e dell’istruzione di qualche chierico indigeno.
Queste due Opere, che giustamente sono chiamate sussidiarie della principale, come dal Nostro antecessore di felice memoria Benedetto XV vennero raccomandate alla sollecitudine dei Vescovi con la Lettera Apostolica sopra ricordata, così Noi non cessiamo di raccomandarvela, fiduciosi come siamo che, per le vostre esortazioni, i fedeli cristiani non soffriranno mai d’esser vinti e superati in liberalità dagli acattolici, che con tanta larghezza soccorrono i propagandisti dei loro errori.
Ma è tempo ormai che rivolgiamo il discorso a Voi, Venerabili Fratelli, Diletti Figli, i quali per avere lungamente, faticosamente e prudentemente esercitato la sacra ambasceria fra i pagani, siete stati fatti degni d’essere preposti ai Vicariati e alle Prefetture con autorità apostolica. E dapprima, per dire dei progressi in genere che le Missioni hanno conseguito in questi ultimi anni e che si debbono alla vostra carità e solerzia, Ce ne rallegriamo sommamente con Voi e con i messaggeri evangelici che Voi reggete e governate. Quali doveri principalmente v’incombessero, e quali inconvenienti si avessero ad evitare nell’adempimento di chi, l’immediato antecessore Nostro vi insegnò con tanta sapienza e magnificenza di eloquio, che non si sarebbe potuto meglio; tuttavia Ci piace, Venerabili Fratelli, Diletti Figli, farvi sapere qual è il Nostro pensiero su certi punti.
Innanzi tutto richiamiamo l’attenzione vostra su quanto importi che gl’indigeni vengano ascritti al clero: se ciò non si fa con tutte le forze, riteniamo che il vostro apostolato non solo riuscirà monco, ma troppo a lungo ne deriveranno ostacolo e ritardo allo stabilirsi e all’organizzarsi della Chiesa in codeste regioni. Volentieri confessiamo e riconosciamo che in qualche luogo si è già cominciato a riflettere e a provvedere con l’erigere Seminari, nei quali giovani indigeni di belle speranze vengono debitamente istruiti e formati per ascendere alla dignità sacerdotale e per ammaestrare nella fede cristiana persone della propria razza; nondimeno siamo ancora troppo lontani dal traguardo a cui è necessario si giunga in tal materia. Voi ricordate quel che il Nostro predecessore di felice memoriaBenedetto XV lamentò a questo proposito: « Purtroppo vi sono ancora delle regioni in cui, benché la Fede cattolica vi sia penetrata da secoli, non vi si riscontra che un clero indigeno assai scadente. Parimenti vi sono parecchi popoli, che pure hanno già raggiunto un alto grado di civiltà, sì da poter presentare uomini ragguardevoli in ogni ramo dell’industria e della scienza, e tuttavia, benché da secoli sotto l’influenza del Vangelo e della Chiesa, ancora non hanno potuto avere Vescovi proprî che li governassero, né sacerdoti così influenti da guidare i loro concittadini » [10].
Forse non si è mai sufficientemente considerato per quale via e in qual modo il Vangelo cominciò ad essere propagato e la Chiesa di Dio a stabilirsi fra le genti. Accennando rapidamente a tale argomento mentre si chiudeva ufficialmente la Mostra Missionaria, ricordavamo che dai primi documenti letterari dell’antichità cristiana appariva manifestamente come il clero, messo a capo dagli Apostoli ad ogni nuova comunità di fedeli, non era importato di fuori, ma era preso e scelto dai nativi del paese. Per aver poi il Romano Pontefice affidato a voi e ai vostri coadiutori l’ufficio di predicare la verità cristiana alle genti pagane, non dovete credere che i sacerdoti indigeni siano fatti solo per assistere i missionari nei compiti di minor momento e per completare in qualche modo l’opera loro. A che, di grazia, debbono mirare le Sacre Missioni se non a questo, che la Chiesa di Cristo si istituisca e si stabilisca in tanta immensità di paesi? E da che cosa la Chiesa sarà formata presso i pagani, se non da tutti quegli elementi con i quali già presso di noi si formò, vale a dire dal popolo e dal clero proprio di ciascuna regione, e dai propri religiosi e religiose? Perché mai impedire al clero indigeno di coltivare il campo suo proprio e nativo, che è quanto dire di governare il suo popolo? Per poter procedere ogni giorno più spediti nel guadagnare a Cristo sempre nuovi infedeli non vi gioverà sommamente il lasciare ai Sacerdoti indigeni le stazioni, perché le custodiscano e le coltivino più vantaggiosamente? Anzi, essi riusciranno utilissimi quanto mai, e più di quanto si possa credere, nell’allargare sempre più il regno di Cristo. « Infatti il Sacerdote indigeno — per usare le parole dello stesso Nostro predecessore – avendo comuni con i suoi connazionali l’origine, l’indole, la mentalità e le aspirazioni, è meravigliosamente adatto ad instillare nei loro cuori la Fede, perché più di ogni altro conosce le vie della persuasione. Perciò accade spesso che egli giunga con tutta facilità dove non può arrivare il missionario straniero » [11].
Che dire poi della scarsa conoscenza della lingua per cui i missionarî stranieri riescono talora così impacciati nell’esprimere il loro pensiero che ne restano molto indebolite la forza e l’efficacia della loro predicazione? E a questi si aggiungono altri inconvenienti, dei quali conviene tenere giusto conto, sebbene sembri che possono solo accadere di rado o con facilità essere allontanati. Si supponga che per una guerra o per altri avvenimenti politici nel territorio di una missione si soppianti un governo con un altro, e si chieda o si decreti l’allontanamento dei missionari stranieri di una determinata nazione; si supponga altresì — cosa certo più difficile da avvenire — che gli indigeni, raggiunto un grado più alto di civiltà e quindi una certa maturità civile, vogliano, per rendersi indipendenti, cacciare dal loro territorio governatori, soldati e missionari della nazione straniera da cui dipendono, e che ciò non possano fare se non col ricorrere alla violenza. Quale rovina, domandiamo, sovrasterebbe allora in quei paesi sulla Chiesa, se non si fosse provveduto pienamente alle necessità della popolazione convertita a Cristo disponendo come una rete di sacerdoti indigeni per tutto quel territorio? Ma inoltre — poiché alle presenti condizioni di cose conviene in pieno la sentenza di Cristo: « La messe è molta, ma gli operai sono pochi » [12] — la stessa Europa da cui proviene la maggior parte dei missionarî, abbisogna oggigiorno di clero, e tanto più ne abbisogna quanto più importa, con l’aiuto di Dio, ricondurre i fratelli dissidenti all’unità della Chiesa e strappare gli acattolici dai loro errori; e tutti sanno che se al presente non è minore di prima il numero dei giovani chiamati alla vita sacerdotale o religiosa, assai minore è il numero di coloro che ubbidiscono alla divina chiamata.
Da quanto abbiamo detto, Venerabili Fratelli e Figli Diletti, consegue essere necessario fornire i vostri territori di un numero tale di sacerdoti indigeni, che bastino da soli sia ad estendere i confini della società cristiana, sia a reggere la comunità dei fedeli della propria nazione, senza dover contare sull’aiuto del clero avventizio. E di fatto in qualche luogo, come dicevamo poc’anzi, si cominciò ad aprire Seminari per alunni indigeni, erigendoli in luoghi situati tra Missioni limitrofe appartenenti al medesimo Ordine o Congregazione, dove i singoli Vicari e i Prefetti Apostolici inviano e mantengono a proprie spese giovani scelti, per riaverli un giorno ordinati sacerdoti e pronti per il sacro ministero. Pertanto ciò che qua e là si è da taluno incominciato, desideriamo, anzi ordiniamo, che tutti i Superiori delle Missioni cerchino parimenti di fare, in modo che non venga tenuto lontano dal sacerdozio e dall’apostolato nessun indigeno che dia buone speranze e mostri vera vocazione. Certo, quanti più saranno gli alunni che sceglierete per tale formazione — ed è assolutamente necessario che siano moltissimi — tanto maggiori saranno le vostre spese; ma non perdetevi di animo, confidando nell’amabilissimo nostro Redentore, alla cui provvidenza spetterà fare in modo che, aumentando la generosità dei cattolici, affluiscano alla Santa Sede i mezzi con cui più largamente aiutarvi ad effettuare un’opera tanto salutare.
Se ciascuno di voi deve procurarsi il maggior numero possibile di chierici indigeni, dovete anche studiarvi di indirizzarli e formarli alla santità che si addice al grado sacerdotale e a quello spirito di apostolato congiunto allo zelo della salute dei propri fratelli, in modo che siano pronti a dare persino la vita per i membri della propria tribù e nazione. Importa tuttavia moltissimo che al medesimo tempo questi alunni ricevano una buona e profonda formazione scientifica, sacra e profana, chiara e metodica, e non con corsi troppo accelerati e sommari, ma con il solito corso di studi. Persuadetevi infatti che se nei Seminari formerete soggetti esimi per illibatezza di vita e per pietà, abili ai ministeri e assai esperti nell’insegnamento della legge divina, preparerete uomini che non solo si attireranno in patria la stima anche delle autorità e dei dotti, ma potranno un giorno esser destinati al governo delle parrocchie e delle diocesi, che verranno erette non appena a Dio così piacerà, con buona speranza di frutto. Certo sbaglierebbe chi stimasse questi indigeni come una razza inferiore e di ingegno ottuso. Infatti,una lunga esperienza dimostra che i popoli delle estreme regioni orientali ed australi talora non la cedono ai nostri e possono benissimo gareggiare con essi e tener loro fronte per acume di mente. Che se nel cuore delle terre barbare si trovano uomini di somma lentezza nell’apprendere, ciò si deve alla condizione della loro vita che, avendo esigenze ristrettissime, non li costringe a fare grande uso della loro intelligenza. Se di quanto abbiamo detto voi, Venerabili Fratelli, Diletti Figli, potete essere testimoni, Noi pure possiamo far fede, avendo quasi sotto gli occhi l’esempio di quegli indigeni che, istruiti nei collegi di Roma in ogni genere di discipline, non solo pareggiano gli altri alunni in prontezza di ingegno e nell’esito degli studi, ma spesso anche li superano. Inoltre non dovete permettere che i sacerdoti indigeni siano ritenuti quasi di grado inferiore e quindi addetti soltanto ai più umili ministeri, come se essi non fossero insigniti dello stesso sacerdozio dei vostri missionari, o non partecipassero dello stesso apostolato; anzi abbiate delle preferenze per essi che un giorno dovranno governare le Chiese fondate col vostro sudore e con le vostre fatiche, e le future comunità cattoliche. Non vi sia perciò differenza tra Missionari europei e indigeni; si colmi ogni solco di separazione e gli uni agli altri si uniscano con vicendevole rispetto e carità.
E poiché per l’organizzazione della Chiesa nelle vostre popolazioni è necessario, come abbiamo detto, servirsi degli elementi di cui essa per divino consiglio dispone, dovete per conseguenza stimare come uno dei doveri principali del vostro ufficio l’istituzione di Congregazioni religiose indigene, maschili e femminili. E non è forse giusto che anche i novelli seguaci di Cristo possano professare i consigli evangelici, ove si sentano dalla divina ispirazione invitati e spinti a vita più perfetta? Su questo punto è bene che i Missionari e le Religiose che lavorano nel vostro campo non si lascino condizionare troppo dall’amore per la propria Congregazione, sebbene in sé giusto e legittimo, e sappiano invece guardare le cose con una certa larghezza di idee. Quindi se vi sono indigeni desiderosi di arruolarsi nelle Congregazioni antiche, non sarebbe certamente giusto sconsigliarli o impedirli, purché diano affidamento di poterne assimilare lo spirito e di riuscire a stabilire nella loro patria una prole non degenere, ma neppure dissimile da quella dell’Istituto abbracciato; ma riflettete scrupolosamente e senza motivi di particolare interesse, se non torni più vantaggioso fondare nuove Congregazioni che meglio corrispondano all’indole e alle inclinazioni degli indigeni e alle esigenze delle condizioni di quella data regione.
Né è da tacersi un altro punto importantissimo per la diffusione del Vangelo; quanto cioè giovi moltiplicare il numero dei catechisti, siano essi scelti tra gli europei o, meglio ancora, tra gli indigeni, perché aiutino i Missionari istruendo i catecumeni e preparandoli al Battesimo. Non occorre dire di quali doti essi debbano essere forniti per poter trarre a Cristo gl’infedeli più con l’esempio che con le parole; e voi, Venerabili Fratelli e Figli Diletti, proponetevi fermamente di educarli con ogni cura affinché apprendano bene la dottrina cattolica, e nel trattarla e spiegarla sappiano adattarsi all’ingegno e all’intelligenza degli uditori; a ciò riusciranno tanto più agevolmente quanto più intimamente conosceranno l’indole degli indigeni.
Abbiamo fin qui parlato della scelta e dell’arruolamento dei vostri compagni di fatica. Su questo argomento però Ci rimane ancora da esporre al vostro zelo una proposta, la quale, ove venga effettuata, crediamo gioverà non poco a una più celere diffusione della fede. Di quanta stima Noi nutriamo per la vita contemplativa fa abbondantemente fede la Costituzione Apostolica con la quale ben volentieri, due anni fa, confermammo con la Nostra autorità apostolica la riforma onde si adattò al Codice di Diritto Canonico la regola dei Certosini, regola già fin dagli inizi dell’Ordine approvata dall’autorità pontificia. Orbene, come Noi stessi esortiamo vivamente i superiori maggiori di simili Ordini contemplativi, così voi pure induceteli con ripetute istanze a che, mediante fondazioni di Cenobî, importino nel territorio delle Missioni e diffondano tale forma austera di vita contemplativa; giacché questi uomini impetreranno dal Cielo una mirabile pioggia di grazie su voi e sulle vostre opere. Né è da temere che questi monaci non trovino da voi terreno propizio, mentre gli abitanti, specialmente di alcune regioni, benché pagani la maggior parte, di natura loro tendono alla solitudine, all’orazione e alla contemplazione. A questo proposito, ricordiamo il Cenobio eretto nel Vicariato Apostolico di Pechino dai Cistercensi Riformati della Trappa, dove quasi cento monaci, in maggioranza cinesi, con l’esercizio delle virtù più perfette, con la preghiera continua, con il rigore della vita, col lavoro manuale, come placano la divina Maestà e la rendono propizia a sé e agli infedeli, così con l’efficacia dell’esempio guadagnano questi stessi a Cristo. È dunque evidente che i nostri anacoreti, pur mantenendo intatto lo spirito del loro Fondatore e senza darsi alla vita attiva, possono ognora riuscire di grande utilità al prospero successo delle Missioni. Se i Superiori di questi Ordini accoglieranno le vostre preghiere e stabiliranno case di loro sudditi dove di comune accordo si crederà meglio, faranno un’opera sommamente benefica a favore di tante moltitudini di pagani e a Noi gradita sopra ogni dire.
Ed ora, Venerabili Fratelli e Figli Diletti, passiamo a un argomento che riguarda un migliore assestamento delle Missioni. Se in tale materia l’immediato Nostro predecessore diede già simili avvisi e insegnamenti, desideriamo ripeterli, perché li crediamo giustamente di grande vantaggio per un fruttuoso esercizio dell’apostolato.
Dunque, giacché in gran parte dipende da voi l’esito dell’apostolato cattolico tra i pagani, vogliamo da voi un’organizzazione migliore che renda d’ora innanzi più facile la via alla propagazione della dottrina cristiana e l’aumento del numero di quanti sono già da essa illuminati. Procurate quindi di distribuire i Missionari in modo che nessuna parte del territorio resti senza predicazione, che di nessuna si rinvii l’evangelizzazione ad altro tempo. Perciò spingetevi più innanzi, a tappe, lasciando Missionari in qualche luogo centrale, intorno a cui stabilirete residenze minori, affidate almeno ad un catechista e dotate di una cappella, che i Missionari, di quando in quando, in dati giorni, andranno a visitare per motivi di ministero.
Ricordino inoltre i predicatori del Vangelo che agli indigeni bisogna accostarsi imitando il metodo tenuto dal divino Maestro quando trattava col popolo. Egli, prima d’insegnare alle turbe, era solito sanare gl’infermi: «Curò tutti gli ammalati [13]; Molti lo seguirono ed egli guarì tutti [14]; Ne sentì compassione e guarì i loro malati [15]». Il che ordinò pure di fare agli Apostoli, dandone loro il potere: « Ed in qualunque città entrerete … curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio [16]; Usciti, giravano per i borghi evangelizzando e curando dappertutto [17])». I Missionari non dimentichino neppure come Gesù si mostrasse benigno ed amabile verso i pargoli e i fanciulli; e quando i discepoli li sgridarono, ordinò loro di non impedirli di andare a lui [18]. E qui viene a proposito rammentare ciò che altra volta dicemmo: che cioè i Missionari che predicano agli infedeli sanno benissimo quanta benevolenza ed affetto si concili anche in quelle regioni chiunque provvede alla salute pubblica e cura gl’infermi, e mostra amore per i bambini e per i fanciulli: tanto può l’esercizio della carità nel conquistare il cuore degli uomini.
Ma per tornare al punto or ora toccato, se va bene che in quei luoghi, dove voi, Venerabili Fratelli e Figli Diletti, avete stabilito la vostra sede e il domicilio, e così pure nelle residenze più importanti per numero di anime, le chiese e gli altri edifici della Missione siano più capaci, bisogna tuttavia schivare la costruzione di templi o di edifici troppo sontuosi e dispendiosi, quasi si trattasse di allestire cattedrali ed episcopî per le diocesi future. Questo si farà a suo tempo, e con maggior vantaggio. Non è forse noto che in certe diocesi, già da tempo canonicamente erette, simili templi e palazzi si sono appena ora costruiti, se pure non sono anche adesso in costruzione? Parimenti non sarebbe giusto né utile riunire e quasi ammucchiare le istituzioni e le opere destinate al vantaggio spirituale e corporale del prossimo in qualche residenza principale o nel luogo dove voi stessi risiedete: perché se sono di grande importanza, richiederanno la presenza vostra e quella dei Missionari e ne assorbiranno talmente l’attenzione da causare il rallentamento e anche la cessazione delle visite nel resto del territorio per la propagazione del Vangelo. E giacché si è fatta menzione di tali opere, oltre gli ospedali e le sale per la cura degli infermi e la distribuzione delle medicine, oltre alle scuole elementari, che dovete aprire dappertutto, è bene che con la fondazione di altre scuole per i giovani che non si diano all’agricoltura, apriate loro la strada dell’insegnamento superiore e specialmente di arti e mestieri. E qui vi esortiamo di non lasciar da parte i maggiorenti del luogo e i loro figliuoli. È verissimo che la parola di Dio e i suoi predicatori più facilmente vengono accolti dai più umili plebei; è vero pure che Gesù affermò di se stesso: « Lo Spirito del Signore … mi ha inviato ad evangelizzare i poveri » [19]; ma oltre che dobbiamo tener presente anche il detto di San Paolo: « Sono debitore ai saggi e agli stolti » [20], la pratica e l’esperienza c’insegnano che una volta condotti alla religione di Cristo i capi del popolo, facilmente le classi più umili tengono loro dietro.
Infine, Venerabili Fratelli e Figli Diletti, per l’esemplare zelo che vi anima per la religione e la salvezza delle anime, accogliete docilmente e con cuore disposto a pronta ubbidienza un’ultima e importantissima raccomandazione. I territori dalla Santa Sede affidati alla cura vostra operosa perché voi li rechiate alla legge di Cristo, sono per lo più di grande estensione. Può dunque accadere che il numero dei Missionari appartenenti al vostro particolare Istituto sia di gran lunga inferiore al bisogno. In tal caso, come nelle diocesi bene stabilite sogliono venire in aiuto ai Vescovi operai appartenenti a diverse famiglie religiose, o di sacerdoti o di laici, e Suore di diverse Congregazioni, così voi, trattandosi della propagazione della fede, della educazione della gioventù indigena e di altre simili utilissime imprese, non dovete esitare ad invitare ed accogliere come compagni di lavoro religiosi e missionari, benché di altro Istituto, siano essi sacerdoti o membri di Congregazioni laicali. Va bene che gli Ordini e le Congregazioni religiose si glorino e della missione tra i pagani loro affidata e delle conquiste finora procurate al regno di Cristo; ma si ricordino che i territori delle Missioni non sono da essi posseduti in forza di un diritto esclusivo e perpetuo, ma che li posseggono a beneplacito della Santa Sede, la quale ha perciò il diritto e il dovere di provvedere che vengano rettamente e pienamente coltivati. Né il Romano Pontefice adempirebbe tale dovere se si restringesse unicamente a distribuire territori di maggiore o minore estensione a questo o a quell’altro Istituto; ma, ciò che più conta, sempre e con ogni diligenza deve procurare che questi Istituti inviino nelle regioni loro affidate tanti e soprattutto tali Missionari, che possano bastare a un lavoro efficace per illuminarle bene in tutta la loro ampiezza con la luce della verità. E poiché il Pastore divino ricercherà il suo gregge dalla Nostra mano, Noi senza esitazioni, quando apparirà necessario o più opportuno ed utile alla maggiore espansione della Chiesa Cattolica, trasferiremo i territori delle Missioni da un Istituto ad un altro, o lo divideremo e suddivideremo, e affideremo al clero indigeno o ad altre Congregazioni i nuovi Vicariati e Prefetture Apostoliche.
Altro non resta che tornare ad esortarvi, Venerabili Fratelli, quanti nel mondo cattolico partecipate con Noi delle sollecitudini e delle gioie dell’ufficio pastorale, di venire in aiuto delle Missioni, con le industrie e coi mezzi che vi abbiamo suggeriti, affinché esse, quasi animate da novello vigore, rendano per l’avvenire più copiosa raccolta. Ai comuni nostri desideri arrida con favore materno la Regina degli Apostoli Maria, la quale, avendo accolto nel suo cuore di Madre tutti gli uomini affidatile sul Calvario, ama e protegge non meno quelli che ignorano di essere stati redenti da Gesù Cristo, che quelli che della redenzione godono felicemente i frutti.
Intanto, come auspicio dei doni celesti e in segno della Nostra benevolenza paterna, a voi, Venerabili Fratelli, al vostro clero e al vostro popolo impartiamo con ogni affetto l’Apostolica Benedizione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 28 febbraio 1926, anno quinto del Nostro Pontificato.
PIUS PP. XI
PER SCARICARE LA LETTERE ENCICLICA "RERUM ECCLESIAE" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

EVANGELII PRAECONES(1)
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO XII
AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI,
PRIMATI,
ARCIVESCOVI,
VESCOVI E AGLI ALTRI ORDINARI .LOCALI
CHE HANNO PACE
E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA:
PER UN RINNOVATO IMPULSO DELLE MISSIONI
Gli araldi dell'evangelo, che s'affaticano in campi sconfinati di lavoro «perché la divina parola si diffonda e risplenda» (2 Ts 3, 1), sono in particolar modo presenti nel Nostro animo oggi, mentre si compie il venticinquesimo anniversario da quando il Nostro predecessore d'immortale memoria Pio XI, inviando l'enciclica Rerum Ecclesiae (2) e dando in essa sapientissime norme, cercò di promuovere sempre più le missioni cattoliche. E il Nostro animo s'inonda di non poca gioia considerando quanto questa causa santissima abbia progredito in questo spazio di tempo, poiché, come già abbiamo avuto occasione di affermare il 24 giugno 1944, parlando ai dirigenti delle Pontificie opere missionarie ammessi alla Nostra presenza: «L'opera missionaria, così nei paesi già illuminati dalla luce dell'evangelo, come nel campo stesso delle missioni, ha ottenuto un tale impulso, una tale ampiezza esteriore, una tale vigoria interna, quali forse non si sono mai riscontrati con eguale intensità nella storia delle missioni» (3).
Oggi tuttavia, mentre corrono tempi torbidi e minacciosi e non pochi popoli vengono divisi da contrastanti interessi, Ci sembra quanto mai opportuno tornare a raccomandare ancora una volta questa causa, poiché i missionari invitano tutti alla bontà umana e cristiana ed esortano a quella fraterna solidarietà che supera i contrasti tra le genti e i confini delle nazioni.
A questo riguardo, nella stessa udienza ai dirigenti di queste Opere, dicemmo tra l'altro: «Il vostro carattere internazionale e la vostra fraternità di lavoro rendono evidente e quasi palpabile quel segno distintivo della chiesa cattolica, che è la negazione e il contrapposto vivente della discordia, da cui le nazioni sono turbate e sconvolte: vogliamo dire l'universalità della fede e dell'amore, al di là di tutti i campi di battaglia e di tutte le frontiere degli stati, di tutti i continenti e di tutti gli oceani, universalità che vi stimola e sprona verso la meta cui tendete, di far coincidere i confini del regno di Dio con quelli del mondo» (4).
Perciò cogliendo volentieri l'occasione del venticinquennio della pubblicazione della lettera enciclicaRerum Ecclesiae, con profonda soddisfazione dell'animo lodiamo il fecondo lavoro già compiuto ed esortiamo tutti a progredire sempre con la massima alacrità; tutti, diciamo, i venerabili confratelli nell'episcopato, i missionari, il clero, i singoli fedeli, sia che lavorino in territori ancora da aprire alle verità cristiane, sia che per ogni dove aiutino questa importantissima causa, con supplici preghiere a Dio, o cooperando alla formazione dei futuri missionari o anche raccogliendo offerte.
1. Progressi
Per prima cosa conviene qui soffermarci brevemente sui progressi felicemente ottenuti a tal riguardo. Nel 1926 le missioni erano quattrocento, oggi sono circa seicento; i fedeli delle missioni non superavano allora i 15 milioni, mentre oggi quasi raggiungono i 28 milioni. Nello stesso anno i missionari, computando insieme quelli esteri e quelli del clero indigeno, erano circa 14.800, oggi sono più di 26.800. Allora le missioni erano quasi tutte rette da sacri pastori provenienti dall'estero; ora, in venticinque anni, 88 missioni sono passate al clero indigeno; e in molti luoghi, essendo stata legittimamente costituita la gerarchia con i vescovi scelti dalla propria gente, ancor più chiaramente si fa manifesto che la religione di Cristo è veramente cattolica, e che non si deve ritenere straniera rispetto a nessuna parte della terra.
Così, per esempio, nella Cina e in alcune parti dell'Africa è stata eretta la gerarchia ecclesiastica, secondo le norme dei sacri canoni; sono stati celebrati tre concili plenari di grandissima importanza, il primo in Indocina nell'anno 1934, il secondo in Australia nel 1937, il terzo in India nel 1950. Sono cresciuti molto in numero e importanza i seminari minori per l'insegnamento delle prime discipline; e i seminaristi dei seminari maggiori, che venticinque anni fa erano soltanto 1770, ascendono al presente a 4300; inoltre sono stati fondati molti seminari regionali. A Roma, presso il Collegio Urbano, è stato eretto l'«Institutum missionale»; pure a Roma e altrove sono state istituite facoltà e cattedre di missionologia. Parimenti è sorto, sempre in quest'alma città, il Collegio di San Pietro, dove i sacerdoti indigeni ricevono una più profonda e completa formazione nello studio, nella virtù, nell'apostolato. Sono poi state fondate due università; i collegi di cultura media o superiore da circa 1.600 sono saliti a più di 5.000; le scuole elementari e le medie sono state quasi raddoppiate e altrettanto si può dire dei dispensari, degli ospedali per la cura di ogni genere di malati, di infermi, non esclusi i lebbrosi. A tutto ciò bisogna aggiungere ancora l'Unione missionaria del clero che in questi anni ha avuto un grande incremento; è stata fondata l'Agenzia Fides, che ha come scopo la ricerca, l'esame e la divulgazione di notizie di carattere religioso; quasi dappertutto è in aumento e si diffonde largamente la stampa missionaria; sono stati celebrati vari Congressi missionari, tra i quali è da ricordare in particolar modo quello tenuto in Roma nello scorso anno santo, che ha chiaramente documentato l'estensione abbracciata dalle attività missionarie; e recentemente è stato celebrato il congresso eucaristico di Kumasi, nella Costa d'Oro in Africa, davvero straordinario per il concorso di gente e per la profonda pietà; infine è stata da Noi stabilita una giornata particolare da celebrarsi ogni anno, allo scopo di promuovere con preghiere e offerte la Pontificia Opera della Santa Infanzia (5). Da ciò risulta chiaro che le iniziative di apostolato hanno opportunamente corrisposto, con metodi nuovi e più adatti, alle mutate condizioni e alle accresciute necessità dei nostri tempi.
Non si deve nemmeno passar sotto silenzio che in questi venticinque anni sono state erette canonicamente altre cinque delegazioni apostoliche, in vari territori soggetti alla giurisdizione della Sacra Congregazione «De propaganda fide»; vi sono poi territori ai quali si estende la competenza di nunzi e internunzi apostolici. A questo proposito ci è gradito affermare che la presenza e l'attività svolta da questi presuli ha già date abbondantissimi frutti, ottenendo principalmente che le fatiche apostoliche dei missionari, meglio coordinate e mediante un aiuto scambievole, contribuissero al raggiungimento delle mete prefisse; alle quali hanno contribuito, inoltre, non poco, anche i Nostri rappresentanti con le frequenti visite e la partecipazione in nome Nostro alle frequenti conferenze episcopali nelle quali la preziosa esperienza dei singoli ordinari viene utilizzata a vantaggio di tutti e vengono elaborati in comune più spediti e facili programmi di apostolato. Inoltre una maggiore considerazione da parte delle autorità civili e dei non cattolici nei confronti della religione cristiana è un altro vantaggio di questa fraterna unione di fede e di opere.
Quanto abbiamo sin qui scritto con la massima brevità sullo sviluppo delle missioni nel periodo di venticinque anni e che abbiamo potuto vedere durante l'anno giubilare - quando tante schiere di pellegrini vennero a Roma dalle lontane regioni evangelizzate dai missionari per implorare i favori celesti e la Nostra benedizione - Ci muovono fortemente a ripetere gli ardentissimi voti dell'apostolo delle genti nella lettera ai Romani: «... per comunicarvi un po' di grazia spirituale sì da esserne fortificati, o meglio, per essere, in mezzo a voi, insieme confortati per la reciproca fede vostra e mia» (Rm 1, 11-12).
Ci sembra che il divino Maestro ripeta a tutti quelle parole piene di consolazione e di esortazione: «Alzate gli occhi e mirate i campi che già biondeggiano per la messe» (Gv 4, 35). Ma poiché il numero dei missionari è impari al bisogno dei nostri giorni, a tali parole risponde in qualche modo l'invito dello stesso divin Redentore: «La messe è veramente abbondante, ma gli operai sono pochi. Pregate, dunque, il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe» (Mt 9, 37-38).
Non senza profonda consolazione sappiamo anche che al presente si è felicemente accresciuto, con grande speranza della chiesa, il numero di coloro che per divina ispirazione si sentono chiamati all'alta funzione di propagare in ogni angolo del mondo la buona novella. Moltissimo tuttavia resta da fare e molto ancora rimane da impetrare da Dio, con supplichevoli preghiere. Ripensando alle innumerevoli genti che sono da condurre all'unico ovile e all'unico porto di salvezza per opera di questi missionari, rivolgiamo al divin Pastore la preghiera dell'Ecclesiastico: «Come al loro cospetto ti mostrasti santo verso di noi, così al cospetto nostro mostrati grande verso di loro. Affinché conoscano, come noi pure abbiam conosciuto, che non c'è Dio fuori di te, o Signore» (Eccli 36, 4-5).
2. Persecuzioni
Questi salutari sviluppi della causa missionaria sono costati non soltanto sacrifici e fatiche ai seminatori della divina parola, ma anche il martirio cruento eroicamente sofferto. Nel corso di questi anni infatti non mancarono in alcune nazioni persecuzioni crudelissime che infierirono contro la chiesa ivi nascente; e anche ai nostri giorni in certe regioni dell'estremo oriente non mancano cristiani che per questo motivo imporporano santamente quelle terre col loro sangue. Ci è giunta infatti notizia che non pochi fedeli, appunto perché furono e sono tuttora fortemente attaccati alla loro fede, come pure suore, missionari, sacerdoti indigeni e anche alcuni vescovi, sono stati espulsi dalla loro sede e privati dei loro beni, e ora o languiscono esiliati nell'indigenza o si trovano in stato di arresto, in carcere o in campi di concentramento, oppure sono stati qualche volta barbaramente trucidati.
Il Nostro animo è pieno di somma tristezza quando pensiamo alle sofferenze, ai dolori e alla morte di questi figli prediletti; e Noi non solo li ricordiamo tutti con paterno affetto, ma anche con patema venerazione, ben sapendo che la sublime vocazione missionaria spesso conduce anche alla dignità del martirio. Gesù Cristo, primo tra i martiri, disse: «Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (Gv 15, 20); «Nel mondo avrete tribolazione, ma confidate; io ho vinto il mondo» (Gv 16, 33); «Se il grano di frumento caduto in terra non muore, resta infecondo; ma se muore produce molto frutto» (Gv 12, 24-25).
Gli araldi e i propagatori della verità e della virtù cristiana, che incontrano la morte lontani dalla patria nell'esercizio della loro eccelsa missione, sono i semi dai quali a suo tempo, al cenno divino, germineranno i più abbondanti frutti. Perciò san Paolo diceva: «Ci gloriamo nelle tribolazioni» (Rm 5, 3); e san Cipriano, vescovo e martire, così confortava ed esortava i cristiani dei suoi tempi: «Volle il Signore che noi godessimo ed esultassimo nelle persecuzioni, perché durante le persecuzioni si distribuiscono le corone della fede, si vede il valore dei soldati di Dio, i cieli si dischiudono per i martiri. Non abbiamo infatti dato il nome ad una milizia per pensare alla pace soltanto e ricusare il combattimento, dal momento che nello stesso esercito per primo marciò il Signore, maestro nell'umiliazione, nel sopportare, nel soffrire, per essere il primo a praticare ciò che propose e per soffrire anticipatamente per noi ciò che esorta a soffrire» (6).
Anche quei seminatori dell'evangelo che oggi si affaticano nelle lontane regioni sviluppano un'azione non dissimile da quella della chiesa primitiva. Essi sono quasi nelle stesse condizioni in cui a Roma erano quelli che insieme con i prìncipi degli apostoli Pietro e Paolo portavano la verità evangelica nel cuore dell'impero romano. Chiunque rifletta come a quel tempo la chiesa nascente non era soccorsa da nessun appoggio umano, ma travagliata dalle angustie, dalle tribolazioni.e dalle persecuzioni, non può non sentirsi colpito da un'intensa ammirazione, vedendo quella piccola schiera inerme di cristiani, vittoriosa su una potenza della quale non sarebbe esistita, forse, alcuna più grande. Ciò che allora avvenne, senza dubbio si rinnoverà più volte. Come il giovanetto David, confidando nell'aiuto divino più che nella sua fionda, abbatté il gigante Golia, rivestito di ferrea armatura, così quella divina società fondata da Cristo non potrà mai esser vinta da un potere terreno, ma con sereno animo supererà sempre ogni persecuzione. Benché Noi sappiamo con certezza che tutto ciò scaturisce dalle divine infallibili promesse, tuttavia non possiamo fare a meno di manifestare il Nostro animo riconoscente a tutti coloro che hanno dato una testimonianza di fede coraggiosa e invitta a Cristo e alla chiesa, colonna e fondamento di verità (cf. 1 Tm 3, 15), esortandoli in pari tempo a procedere sempre con la stessa perseveranza nella via intrapresa.
Molto spesso Ci giungono, con grande Nostra consolazione, notizie di quest'invincibile fede e strenua fortezza. E se non mancarono tentativi di separare i figli della chiesa cattolica dall'unione con Roma e con questa apostolica sede, quasi che ciò fosse richiesto dall'amore e dalla fedeltà dovuta verso la propria nazione, costoro con assoluta franchezza hanno potuto e possono rispondere che nell'amor di patria essi non sono da meno di nessun altro cittadino; desiderano però con somma sincerità di poter usufruire di una giusta libertà.
3. Il lavoro da compiere
Ma è necessario aver presente quanto già sopra abbiamo accennato: che cioè quanto ancora resta da fare in questo campo richiede, senza dubbio, un lavoro immenso e un gran numero di operai. Ricordiamo che i nostri fratelli che «siedono nelle tenebre e all'ombra della morte» (Sal 106, 10) sono una moltitudine immensa che s'aggira sul miliardo. Perciò sembra che ancora risuoni il gemito inenarrabile del cuore amantissimo di Gesù Cristo: «E ho altre pecore, che non sono di questo ovile; anche quelle bisogna che io conduca; e daranno ascolto alla mia voce e si farà un solo ovile e un solo pastore» (Gv 10, 16).
Ben sapete, venerabili fratelli, che vi sono pastori che si sforzano di strappare le pecore da quest'unico ovile, da quest'unico porto di salvezza; e vi è pur noto quanto un tale pericolo in qualche luogo si faccia sempre più grave. Perciò Noi, meditando davanti a Dio su questa sterminata moltitudine di uomini che non conosce ancora la verità dell'evangelo, e insieme considerando, com'è giusto, quel grave pericolo verso cui tanti sono sospinti o per la diffusione del materialismo ateo, o per una certa dottrina che usurpa il nome cristiano e che realmente risente degli errori e delle dottrine del comunismo, Ci sentiamo spinti con impellente urgenza e con ansia promuovere in ogni dove e con ogni sforzo le opere dell'apostolato, riconoscendo come rivolta direttamente a Noi l'esortazione del profeta: «Grida, non darti posa, alza la tua voce come una tromba» (Is 58, 1).
Raccomandiamo a Dio; con supplichevoli preghiere, in modo particolare gli apostoli che faticano nelle sacre missioni nell'interno dell'America Latina, sapendo da quali pericoli e insidie essi siano minacciati, più o meno palesemente, da parte delle sètte non cattoliche.
4. Il missionario
Affinché l'opera dei missionari riesca sempre più efficace e neppure una stilla del loro sudore e del loro sangue vada perduta, torna opportuno spiegare qui brevemente i principi e le norme direttive che devono reggere la diligente opera dei missionari.
Per prima cosa è da considerare che chi per un'ispirazione celeste sente di essere chiamato a educare nella verità dell'evangelo e delle virtù cristiane le lontane regioni pagane, è destinato a un compito assolutamente grande e sublime. Egli infatti consacra a Dio la vita, perché il suo regno si propaghi sino agli ultimi confini della terra. Egli non cerca le cose proprie ma quelle di Cristo (cf. Fil 2 21). Egli infine riferisce a sé in modo del tutto speciale quel bellissimo pensiero dell'apostolo delle genti: «Noi facciamo le veci di ambasciatori di Cristo» (2 Cor 5, 20). «Pur vivendo nella carne non militiamo però secondo la carne» (2 Cor 10,3). «Mi sono fatto debole coi deboli, per guadagnare i deboli» (l Cor 9, 22). Deve pertanto considerare quasi una seconda patria e amare con debito amore quella regione nella quale si reca per portare la luce dell'evangelo, e quindi non cerchi compensi terreni, né vantaggi per la sua nazione o per il suo istituto religioso, ma piuttosto la salvezza delle anime. Egli deve certamente amare con intenso amore la propria stirpe e la propria famiglia religiosa, ma con ardore ancora più grande la chiesa, memore che niente cosa potrà giovare al suo istituto se contrasta col bene della chiesa.
È necessario inoltre che i chiamati all'apostolato missionario mentre ancora sono in patria non solo attendano a una formazione completa nel campo della virtù e delle scienze ecclesiastiche, ma anche apprendano quelle cognizioni di ordine culturale e tecnico che in seguito potranno essere loro di grandissima utilità, una volta divenuti messaggeri dell'evangelo nelle missioni. Bisogna perciò che conoscano bene le lingue, specialmente quelle che sul posto saranno loro necessarie, e che abbiano sufficiente pratica e nozioni scientifiche in medicina, in agricoltura, in etnografia, in storia, in geografia e scienze affini.
5. Lo scopo delle missioni
Lo scopo principale di ogni missione, come ognuno sa, è quello di far più chiaramente risplendere in mezzo a nuovi popoli la luce della verità cristiana, in modo che si abbiano nuovi seguaci di Cristo. Per raggiungere questo fine supremo è necessario - e non deve mai esser perso di vista - che la chiesa si stabilisca su solide fondamenta presso gli altri popoli e venga costituita con propria gerarchia formata di clero indigeno.
Nella lettera del 9 agosto 1950 indirizzata al diletto figlio Nostro Pietro Fumasoni Biondi, cardinale presbitero di santa romana chiesa, prefetto della Sacra Congregazione «De propaganda fide» affermavamo tra l'altro che «la chiesa non ha alcun proposito di dominio sui popoli, o di voler comandare in cose meramente temporali, mentre è infiammata dall'unica ansia di portare la suprema luce della fede a tutte le genti, di promuovere la civiltà umana e la fraterna concordia dei popoli» (7).
Nella lettera apostolica Maximum illud (8) del 1919 di Benedetto XV, Nostro predecessore di immortale memoria, e parimente nell'enciclica Rerum Ecclesiae (9) di Pio XI, immediato Nostro predecessore di felice memoria, si annunciava che le sacre missioni, quasi come a scopo supremo dovessero mirare alla costituzione della chiesa nelle nuove terre. E Noi stessi, nella ricordata udienza alle Opere missionarie del 1944, dicemmo: «Il grande scopo delle missioni è di stabilire la chiesa nelle nuove terre e di farle ivi mettere salde radici, tanto da poter un giorno vivere e svilupparsi senza il sostegno dell'Opera delle missioni. L'Opera delle missioni non è scopo a sé medesima: essa tende con ardore a quell'alto fine, ma si ritira quando questo è stato raggiunto» (10). «L'opera missionaria non si accontenta di assicurare e proteggere le sue posizioni. Il suo scopo è di fare di tutto il mondo una terra santa. Essa mira a portare il regno del Redentore risorto, a cui è stata data ogni potestà in cielo e in terra (cf. Mt 28,18), il suo impero sui cuori attraverso tutte le regioni sino all'ultima capanna e all'ultimo uomo, che abita il nostro pianeta» (11).
6. Il clero indigeno
Naturalmente non è possibile dare una congrua e opportuna stabilità alla chiesa in nuove regioni, se non vi sia pure una sufficiente e proporzionata organizzazione di opere e principalmente se non si dispone del necessario clero indigeno, debitamente preparato e formato. Per questa ragione vogliamo ripetere di nuovo e far Nostre le gravi e profonde espressioni dell'enciclica Rerum Ecclesiae: «Se ciascuno di voi deve procurarsi il maggior numero possibile di chierici indigeni, dovete inoltre studiarvi di indirizzarli e formarli alla santità che si addice al grado sacerdotale e a quello spirito di apostolato congiunto allo zelo della salute dei propri fratelli, che li renda pronti a dare persino la vita per i membri della propria tribù e nazione» (12).
«Supponiamo che per una guerra o per altri avvenimenti politici nel territorio di una missione si soppianti un governo con un altro e si chieda o si decreti l'allontanamento dei missionari stranieri di una determinata nazione; supponiamo inoltre - cosa certo più difficile ad avverarsi - che gli indigeni, raggiunto un grado più alto di civiltà e maturità civile, vogliano, per rendersi indipendenti, cacciare dal loro territorio governatori, soldati e missionari della nazione straniera da cui dipendono, e che non possano farlo se non ricorrendo alla violenza. Quale rovina, domandiamo, sovrasterebbe allora in quei paesi alla chiesa se non si fosse provveduto pienamente alle necessità della popolazione convertita a Cristo, disponendo come una rete di sacerdoti indigeni per tutto quel territorio?» (13).
Noi siamo profondamente addolorati nel rilevare, purtroppo, come quelle cose che il Nostro immediato predecessore scriveva con animo quasi presago, siano ora divenute una realtà in non poche regioni dell'estremo oriente. Là infatti missioni fiorentissime, già biondeggianti per la mietitura (cf. Gv 4, 35), gemono ora, purtroppo, nelle più dure tribolazioni. Oh, potessimo Noi sperare che il popolo coreano e quello cinese, tanto ricchi d'innata nobiltà e gentilezza d'animo e celebri per lo splendore della loro antica civiltà, siano al più presto liberati non solo dalle rivoluzioni e da scontri guerreschi, ma ancora da quella perniciosa dottrina che, solo contenta della terra, rinnega le cose celesti; e così apprezzino giustamente la carità e la forza d'animo dei missionari esteri e dei sacerdoti indigeni che, a costo di sacrifici e della loro stessa vita, se occorre, non cercano altro che il vero bene del popolo!
Dobbiamo ringraziare incessantemente il Signore, che in queste due nazioni sia già stato formato a speranza della chiesa un numeroso clero locale, e non poche diocesi vi siano state affidate a vescovi indigeni. Se a tanto si è potuto finalmente arrivare, ciò deve ascriversi a lode dei missionari esteri.
A questo proposito, crediamo opportuno suggerire alcune norme, che giova tener presenti quando qualche sacra missione già retta da missionari esteri passa sotto la cura e il regime del clero e dell'episcopato locale. Quegli istituti religiosi, i cui membri col proprio sudore hanno dissodato il campo del Signore, non è necessario che lo abbandonino completamente quando, ormai ricco di frutti, la Sacra Congregazione «de propaganda fide» credesse conveniente affidarlo ad altri lavoratori; faranno invece cosa utile e conveniente se vorranno rimanere a collaborare con il nuovo vescovo locale. Come infatti nelle altre diocesi del mondo cattolico i religiosi coadiuvano per lo più gli ordinari del luogo, così nelle missioni i religiosi esteri come milizia ausiliaria non si stancheranno di combattere la santa battaglia e in tal maniera ben attueranno le parole del divino Maestro presso il pozzo di Sichar: «Chi miete già riceve la mercede e raccoglie frutto per la vita eterna, onde si rallegra parimenti chi miete e chi semina» (Gv 4, 36).
7. L'azione cattolica nelle missioni
Desideriamo inoltre con la presente enciclica rivolgere la Nostra parola e la Nostra esortazione non solo ai missionari, ma anche a quei laici che «con cuore grande e animo volenteroso» (2 Mac 1, 3), militando nelle file dell'Azione cattolica si adoperano ad aiutare i missionari.
Possiamo senz'altro affermare che la collaborazione dei laici, che oggi si chiama Azione cattolica, non è mai mancata fin dai primordi della chiesa, ma ha sempre apportato un prezioso aiuto agli apostoli e agli altri propagatori dell'evangelo e un valido contributo allo sviluppo della religione cristiana. A questo riguardo, l'apostolo delle genti ricorda Apollo, Lidia, Aquila, Priscilla, Filemone; egli stesso scrive ai Filippesi: «Prego anche te, compagno fedele, porgi aiuto a queste, che hanno combattuto con me per l'evangelo insieme con Clemente e con gli altri miei collaboratori, i nomi dei quali sono nel libro della vita» (Fil 4, 3).
Del pari a tutti è noto che l'idea cristiana si propagò per le vie consolari non solo per lo zelo dei vescovi e dei sacerdoti, ma anche per l'opera dei magistrati civili, dei soldati e dei privati cittadini. Molte migliaia di credenti, di recente venuti alla fede, dei quali oggi si ignorano i nomi, animati dal desiderio ardentissimo di diffondere la nuova religione da essi abbracciata, cercarono di prepararle la strada, di modo che dopo circa cento anni il nome e le virtù cristiane avevano già raggiunto tutti i centri più importanti dell'impero romano.
San Giustino, Minucio Felice, Aristide, il console Acilio Glabrione, il patrizio Flavio Clemente, san Tarcisio e quasi innumerevoli altri santi e sante martiri, avendo consolidato e fecondato la chiesa primitiva con le proprie fatiche e col proprio sangue, possono in certo modo chiamarsi gli antesignani e i precursori dell'Azione cattolica. Ci piace qui riferire quella bellissima espressione dell'autore della Lettera a Diogneto, che sembra conservare un ammonimento anche per i nostri giorni: «I cristiani ... sono nella loro patria come inquilini; ... ogni terra straniera per loro è patria, e ogni patria per loro è straniera» (14).
Nel medioevo, con l'invasione dei barbari, sono prìncipi e principesse, oppure umili artigiani e forti popolane, che si consacrano per convertire i loro popoli alla religione di Gesù Cristo, per conformare ad essa i loro costumi e per difendere la religione e la patria nel momento del pericolo. Come ci tramanda la storia, accanto al Nostro immortale predecessore san Leone Magno, il quale coraggiosamente fermò Attila, che invadeva l'Italia, c'erano due consolari romani. A Parigi, mentre la città viene assediata dalle orde terribili degli Unni, una vergine, santa Genoveffa, che vive di continue preghiere e di aspra penitenza, con ammirabile carità si sacrifica tutta alla cura dei corpi e delle anime dei suoi concittadini. Teodolinda, regina dei Longobardi, prepara con zelo la via alla conversione della sua gente. In Spagna, il re Recaredo cerca di ricondurre il suo popolo dall'eresia ariana alla vera fede. In Francia, accanto ai grandi vescovi, come Remigio di Reims, Cesario di Arles, Gregorio di Tours, Eligio di Noyon e tanti altri celebri per la loro virtù e il loro zelo, vediamo in quei tempi anche regine insegnare la dottrina cristiana al popolo e agli ignoranti, nutrire, sollevare e confortare gli infermi, gli affamati e i miseri d'ogni specie; e, per citare qualche esempio, Clotilde attira e sollecita l'animo di Clodoveo verso la religione cattolica sì da condurlo a ricevere con entusiasmo il santo battesimo; Radegonda e Batilde si dedicano con somma carità all'assistenza degli ammalati e anche alla cura dei lebbrosi. In Inghilterra, la regina Berta accoglie sant'Agostino, apostolo di quella terra, e con diligenza dispone suo marito Etelberto ad accogliere la morale evangelica. Appena convertiti, gli anglosassoni nobili e plebei, uomini e donne, giovani e vecchi, come spinti da un impulso divino, costituiscono un'unione strettissima con la sede apostolica, fatta di pietà, di fedeltà e di obbedienza.
Uno spettacolo ugualmente meraviglioso ci viene offerto in Germania, quando san Bonifacio e i suoi collaboratori percorrono nei loro apostolici viaggi quelle terre, fecondandole generosamente con i loro sudori. Uomini e donne di quel popolo nobile e forte con generoso entusiasmo collaborano intensamente con i monaci, con i sacerdoti e con i vescovi, per diffondere sempre più estesamente la luce dell'evangelo in quelle regioni vastissime, e per promuovere sempre più la pratica della morale e della santità cristiana non senza ubertosi frutti di salvezza.
In ogni tempo, quindi, la chiesa cattolica non solo per lo zelo indefesso del clero, ma anche per la collaborazione del laicato chiamato in aiuto, ha potuto dare nuovi incrementi alla religione e condurre i popoli a una maggiore prosperità anche nel campo sociale. Tutti conoscono quanto in ciò operarono, in Germania santa Elisabetta Landgravia di Turingia, il re san Ferdinando nella Castiglia e infine san Luigi IX nella Francia; essi mediante la loro santità e la loro operosa attività esercitarono un salutare influsso in ogni ceto sociale, con benefiche iniziative, con la più vasta propagazione della fede, con la strenua difesa della chiesa e soprattutto facendosi esempio a tutti. Né è sconosciuto tutto il cumulo di meriti guadagnati dalle associazioni laiche nel medioevo. Esse comprendevano artigiani e operai d'ambo i sessi che, pur rimanendo nel mondo, miravano a una vita conforme all'ideale altissimo della perfezione evangelica, cercando di tradurlo in pratica essi stessi, e col clero, contribuendo all'elevazione spirituale di tutti gli altri.
Ebbene, le condizioni della chiesa primitiva si riflettono ancora oggi in molte parti in terra di missione; o per lo meno quei popoli si trovano a dover far fronte alle medesime necessità cui dovevano provvedere i cristiani nei secoli che seguirono. Perciò è assolutamente necessario che nelle missioni i laici, affluendo numerosissimi nelle file dell'Azione cattolica, collaborino con generosità, diligenza e infaticabile operosità con l'apostolato gerarchico del clero. Certamente l'opera dei catechisti è necessaria, e ad essi desideriamo dare la meritata lode ma non meno necessaria è l'azione gratuita prestata con diligenza da quei cristiani che, animati unicamente dalla carità divina, si offrono ad aiutare i sacerdoti nel loro ministero.
Perciò raccomandiamo vivamente che per quanto è possibile si stabiliscano dappertutto associazioni cattoliche di uomini e di donne, associazioni di studenti, di operai, di artigiani, ginniche e sportive, nonché tutti quegli altri sodalizi e pie unioni che possono chiamarsi quasi forze ausiliarie dei missionari. Nel costituirle e nel promuoverle, però, si tenga conto e stima dell'onestà, della virtù e dello zelo dei loro membri più che del numero.
È da notare inoltre che i missionaria per guadagnare la fiducia dei genitori, non hanno miglior mezzo che quello di aver cura diligentissima dei loro figli. Questi, crescendo nello spirito e nella pratica cristiana della vita saranno la forza, il decoro e l'ornamento non solo della propria famiglia, ma pure di tutta la comunità; riusciranno anzi spesso a riaccendere felicemente il primitivo fervore di qualche cristianità, se per caso esso si sia affievolito.
Sebbene poi, come tutti sanno, l'attività dell'Azione cattolica debba adoperare le sue forze specialmente nel campo dell'apostolato, ciò non toglie che gli stessi soggetti possano far parte anche di associazioni che hanno lo scopo di conformare la vita sociale e politica ai principi e alle norme dell'evangelo; anzi a ciò sono chiamati dai loro diritti e dai loro doveri non solo di cittadini ma anche di cattolici.
8. Scuole e stampa
Inoltre, poiché i giovani, soprattutto coloro che si dedicano allo studio delle lettere, delle scienze e delle arti, saranno un giorno la parte dirigente della generazione futura e della società, è facile comprendere la grandissima cura che si deve avere nel moltiplicare le scuole e i collegi. Perciò con animo paterno raccomandiamo ai superiori delle missioni di non risparmiare mezzi, cure e fatiche a questo scopo.
Le scuole infatti offrono ai missionari il grande vantaggio di stabilire utili contatti con tutto il mondo pagano, e soprattutto di attrarre più facilmente la gioventù, malleabile come cera, a comprendere, stimare e abbracciare la dottrina cattolica. Questi giovani in tal maniera educati saranno i futuri reggitori della cosa pubblica, e la massa del popolo li seguirà come guide e maestri. L'apostolo delle genti predicò l'altissima sapienza dell'evangelo anche davanti ai più dotti, come quando nell'areopàgo di Atene parlò agli astanti del Dio ignoto. E se anche in questa maniera non saranno frequenti le conversioni alla pratica della morale del divin Redentore, molti tuttavia saranno soavemente commossi nel considerare la celestiale bellezza di questa religione e la carità dei suoi seguaci.
Le scuole poi e i collegi sono utilissimi per confutare tutti quegli errori che vengono diffusi ogni giorno più, soprattutto per opera degli acattolici e dei comunisti, e vengono istillati più o meno apertamente specialmente nelle anime giovanili.
Non meno utile è la produzione e la diffusione della buona stampa. Non crediamo tuttavia necessario soffermarci molto intorno a questo argomento, poiché a tutti è noto quanto sia grande l'influenza della stampa quotidiana e periodica, sia per mettere convenientemente in luce la verità e inculcare negli animi la virtù cristiana, sia per scoprire gli errori che si presentano sotto mentite apparenze di verità, sia ancora per confutare quelle false esposizioni che contrastano con la religione ovvero propongono inopportunamente, con grave danno delle anime, accese dispute su argomenti sociali. Perciò caldamente lodiamo i pastori di anime che si preoccupano di diffondere il più largamente possibile tali scritti, ben composti e bene stampati. In questo campo molto si è operato, molto però resta ancora da fare.
9. Assistenza sanitaria
Ci piace ancora raccomandare qui assai vivamente le iniziative e le opere sanitarie e assistenziali d'ogni genere, quali gli ospedali, i lebbrosari, i dispensari, i ricoveri dei vecchi e i luoghi destinati alle opere di assistenza per la maternità e infanzia e per tutti i bisognosi di qualsiasi aiuto. Queste opere Ci sembrano i fiori più belli del giardino della carità missionaria, e richiamano alla mente lo stesso divin Redentore che «passò beneficando e sanando tutti» (At 10, 38).
Senza dubbio tutte queste opere insigni di carità hanno un'efficacia somma per preparare gli animi degli infedeli e disporli a ricevere la fede cristiana, e a praticarne gli insegnamenti; Gesù infatti disse agli apostoli: «Entrando in una città, se vi accolgono ... guarite gli infermi che ci sono, e dite loro: Sta per venire a voi il regno di Dio» (Lc 10, 8-9).
È necessario tuttavia che i missionari e le suore, che si sentono chiamati a prestare un giorno efficacemente questi soccorsi, si procurino, mentre sono ancora in patria, quella preparazione tecnica e culturale richiesta oggi in questi campi. Sappiamo che non mancano suore diplomate, le quali meritano una particolare lode per essersi applicate allo studio specifico di orribili morbi, quali la lebbra, e per averne trovato convenienti rimedi. Ad esse, come pure a tutti quei missionari che prestano generosamente la loro opera nei lebbrosari, vadano la Nostra paterna benedizione e la Nostra profonda ammirazione per la loro sublime carità.
Per l'esercizio poi della medicina e della chirurgia, gioverà cercare anche ausiliari laici, che non solo siano provvisti dei necessari diplomi e disposti a lasciare la patria per aiutare i missionari, ma che per la loro condotta e la capacità professionale corrispondano al loro ufficio.
10. Assistenza sociale
Passiamo ora a un'altra questione non meno grave e importante: vogliamo cioè precisare alcune norme che riguardano l'ordinamento cristiano della società secondo i principi della giustizia e della carità. Mentre l'ideologia comunista, oggi dappertutto diffusa, facilmente inganna l'animo semplice e incolto del popolo, a Noi sembra di udire le parole di Gesù: «Mi fa compassione questo popolo» (Mc 8, 2). È assolutamente necessario mettere in pratica con somma diligenza e zelo i santi principi della sociologia insegnati dalla chiesa. Bisogna senz'altro preservare i popoli, o guarirli se ne fossero contaminati, da quelle perniciose dottrine che assegnano agli uomini come unico scopo di questa vita il godimento dei piaceri terreni e, affidando al potere arbitrario dello stato l'acquisto e l'uso d'ogni proprietà, deprimono talmente la dignità della persona umana da distruggerla quasi completamente. Occorre insomma inculcare a tutti in pubblico e in privato che noi siamo esuli in cammino verso una patria immortale, e siamo destinati a una vita eterna e a un'eterna felicità che, dietro la guida della verità e mettendo in pratica la virtù, dobbiamo un giorno conseguire. Solo Cristo è vindice della giustizia umana e consolatore dolcissimo degli inevitabili dolori della vita presente; egli solo ci mostra il porto della pace, della giustizia, del gaudio eterno, al quale tutti, redenti dal suo sangue, dobbiamo arrivare dopo questa vita terrena.
Però è dovere per tutti ridurre, lenire e alleviare per quanto è possibile le angustie, le miserie e i dolori dei fratelli anche in questa vita terrena.
La carità potrà portare certamente un qualche rimedio a molte ingiustizie sociali, ma non basta; anzitutto bisogna che fiorisca, domini e sia realmente applicata la virtù della giustizia.
A questo proposito, Ci piace riportare le parole da Noi pronunciate davanti al sacro collegio cardinalizio e ai vescovi e prelati nel messaggio natalizio del 1942: «... La chiesa condannò i vari sistemi del socialismo marxista, e li condanna anche oggi, com'è suo dovere e diritto permanente di preservare gli uomini da correnti e influssi, che ne mettono a repentaglio la salvezza eterna. Ma la chiesa non può ignorare o non vedere, che l'operaio, nello sforzo di migliorare la sua condizione, si urta spesso contro qualcosa, che, lungi dall'essere conforme alla natura, contrasta con l'ordine di Dio e con lo scopo, che egli ha assegnato per i beni terreni. Per quanto fossero e siano false, condannabili e pericolose le vie che si seguirono, chi, e soprattutto quale sacerdote o cristiano potrebbe restar sordo al grido, che si solleva dal profondo, e che, nella condizione comune, invoca da un Dio giusto giustizia e spirito di fratellanza? Ciò sarebbe un silenzio colpevole e ingiustificabile davanti a Dio, e contrario al senso illuminato dell'apostolo, il quale, come inculca che bisogna essere risoluti contro l'errore, sa pure che si vuol essere pieni di riguardo verso gli erranti e con l'animo aperto per intenderne aspirazioni, speranze e motivi... La dignità della persona umana esige dunque normalmente come fondamento naturale per vivere il diritto all'uso dei beni della terra; a cui risponde l'obbligo fondamentale di accordare una proprietà privata, possibilmente a tutti. Le norme giuridiche positive, che regolano la proprietà privata, possono mutare e accordare un uso più o meno circoscritto; ma se vogliono contribuire alla pacificazione della comunità, dovranno impedire che l'operaio, che è o sarà padre di famiglia, venga condannato a una dipendenza e servitù economica, inconciliabile con i suoi diritti di persona.
Che questa servitù derivi dal prepotere del capitale privato o dal potere dello stato, l'effetto non muta; anzi, sotto la pressione di uno stato che tutto domina e regola l'intera vita pubblica e privata, penetrando fin nel campo delle concezioni e persuasioni e della coscienza, questa mancanza di libertà può avere conseguenze ancora più gravose, come l'esperienza manifesta e testimonia» (15).
Sta ora a voi, venerabili fratelli, che vi affaticate nei territori di missione, far di tutto perché questi principi e queste norme vengano tradotti nella pratica. Tenendo conto delle varie circostanze locali, voi, consultandovi nelle conferenze episcopali, nei sinodi e in altre riunioni, siate solleciti di dar vita secondo le vostre possibilità a tutte quelle associazioni, unioni e istituzioni di carattere sociale ed economico che venissero richieste dai tempi e dalla particolare indole dei popoli a voi affidati. Ciò, senza dubbio, è una esigenza del vostro pastorale ministero, affinché il vostro gregge, travolto da nuove concezioni che si presentano sotto le apparenze della giustizia e della verità, e sospinto da cattivi impulsi, non venga traviato dal retto cammino. I propagatori della fede che vi accompagnano nel vostro illuminato lavoro devono essere modelli e maestri a tutti anche nell'azione sociale: «I figli di questo secolo sono più prudenti di quelli della luce» (Lc 16, 8). Sarà opportuno però che i missionari si servano, per quanto è possibile, dell'opera dei laici cattolici particolarmente onesti e competenti, per intraprendere e promuovere iniziative di tal genere.
11. Contro l'esclusivismo territoriale e giurisdizionale
Nei secoli passati il campo vastissimo dell'apostolato missionario non era confinato entro particolari circoscrizioni ecclesiastiche, né veniva posto sotto le cure dei vari ordini o congregazioni religiose e del crescente clero indigeno. E così avviene per lo più tuttora, come a tutti è noto; ma talvolta accade pure che alcune regioni vengano affidate ai religiosi di una particolare provincia del medesimo istituto. Vediamo senza dubbio l'utilità di tutto ciò, poiché in questa maniera l'organizzazione missionaria acquista più ordine e agilità. Può accadere, tuttavia, che da questo modo di procedere sorgano inconvenienti e danni non lievi, ai quali, per quanto è possibile, è opportuno rimediare. Già i Nostri predecessori si occuparono di questo argomento nelle lettere citate (16) e in tal materia stabilirono norme sapientissime, che Ci piace ripetere e confermare, paternamente esortandovi affinché «per l'esemplare zelo che vi anima, per la religione e la salvezza delle anime», accogliate «docilmente e con cuore disposto a pronta ubbidienza un'ultima e importantissima raccomandazione. I territori della Santa Sede affidati alla cura vostra operosa perché voi li rechiate alla legge di Cristo, sono per lo più di grande estensione. Può dunque accadere che il numero dei missionari appartenenti al vostro particolare istituto sia di gran lunga inferiore al bisogno. In tal caso, come nelle diocesi bene stabilite sogliono venire in aiuto ai vescovi operai appartenenti a diverse famiglie religiose, o di sacerdoti o di laici, suore di diverse congregazioni, così voi, trattandosi della propagazione della fede, dell'educazione della gioventù indigena e di altre simili imprese, non dovete esitare a invitare e accogliere come compagni di lavoro religiosi e missionari, benché di altro istituto, siano essi sacerdoti, siano membri di congregazioni laicali. Sta bene che gli ordini e le congregazioni religiose si glorino e della missione tra i pagani loro affidata e delle conquiste finora procurate al regno di Cristo; ma si ricordino, che i territori delle missioni non sono da essi posseduti in forza di un diritto esclusivo e perpetuo, ma che li posseggono a beneplacito della Santa Sede, la quale ha perciò il diritto e il dovere di provvedere che vengano rettamente e pienamente coltivati. Né il romano pontefice adempirebbe tale dovere se si restringesse unicamente a distribuire territori di maggiore o minore estensione a questo o a quell'altro istituto; ma, ciò che più conta, sempre e con ogni diligenza deve procurare che questi istituti inviino nelle regioni loro affidate tanti e soprattutto tali missionari, che possano bastare a un lavoro efficace per illuminarle bene in tutta la loro ampiezza con la luce della verità» (17).
12. Rispetto per ciò che c'è di buono nella civiltà e nei costumi dei diversi popoli
Vi è un altro punto ancora che è Nostro vivo desiderio di presentare a tutti nella luce più chiara. È stata norma sapientissima, costantemente seguita dalla chiesa, dalle origini ai nostri giorni, che l'evangelo non dovesse distruggere né soffocare ciò che vi fosse di buono, di onesto e di bello nell'indole e nei costumi dei vari popoli che lo avevano abbracciato. La chiesa nel condurre i popoli a una civiltà più elevata sotto l'influsso della religione cristiana, non si comporta come chi senza alcuna distinzione taglia, abbatte e distrugge una selva lussureggiante, ma piuttosto come chi innesta nuovi sani virgulti sui vecchi ceppi, affinché possano a loro tempo produrre e maturare frutti più squisiti e delicati.
La natura umana, sebbene viziata dalla tara ereditaria del triste peccato di Adamo, conserva ancora un fondo naturalmente cristiano (18), che illuminato dalla luce divina e plasmato dalla grazia può essere elevato ad atti di virtù vera, e un giorno alla vita eterna.
Perciò la chiesa cattolica non disprezzò o rigettò completamente il pensiero pagano, ma piuttosto, dopo averlo purificato da ogni scoria di errore, lo completò e lo perfezionò con la sapienza cristiana. Così pure accolse benevolmente il progresso nel campo delle scienze e delle arti, che in alcuni luoghi raggiunse altezze veramente sublimi, e lo perfezionò diligentemente innalzandolo a fastigi di bellezza forse prima mai raggiunti. E neppure soppresse del tutto i costumi e le antiche istituzioni dei popoli, ma in qualche maniera li consacrò; le stesse feste pagane, trasformate nel significato e nel rito, piegò a celebrare le memorie dei martiri e i divini misteri. A questo riguardo molto egregiamente si esprime san Basilio: «Come i tintori preparano prima con cura ciò che si deve tingere, e poi lo colorano di porpora o di qualche altra tinta, nella stessa maniera anche noi, se vogliamo conservare per sempre indelebile la gloria dell'onestà, prima iniziati allo studio di queste dottrine profane, apprenderemo poi i segreti delle scienze sacre: e abituati a contemplare il sole riflesso nell'acqua, alzeremo in tal maniera lo sguardo al sole raggiante. ... Certamente, com'è essenziale per l'albero produrre frutti a suo tempo, e tuttavia anche le foglie che si muovono intorno ai rami gli offrono un qualche ornamento; così anche per l'anima il frutto essenziale è la verità, ma non si deve disprezzare la veste della dottrina profana che rassomiglia a quelle foglie che dànno al frutto ombra e aspetto piacevole. Perciò si dice che anche il grande Mosè, celeberrimo sopra tutti per la sua sapienza, si esercitò in tutte le scienze degli egiziani, prima d'innalzarsi alla contemplazione di "Colui che è". Così pure anche nei tempi posteriori si dice che il saggio Daniele fosse istruito in Babilonia nella sapienza dei Caldei e poi si dedicasse allo studio delle scienze sacre» (19).
Noi stessi nella prima enciclica Summi pontificatus scrivevamo: «Innumerevoli ricerche e indagini di pionieri, compiute con sacrificio, dedizione e amore dai missionari di ogni tempo, si sono proposte di agevolare l'intima comprensione e il rispetto per le civiltà più svariate, e di intenderne i valori spirituali fecondi per una viva e vitale predicazione dell'evangelo di Cristo. Tutto ciò che in tali usi e costumi non è indissolubilmente legato con errori religiosi troverà sempre benevolo esame e, quando riesce possibile, verrà tutelato e promosso» (20).
E nel discorso che abbiamo rivolto ai dirigenti delle Pontificie opere missionarie nell'anno 1944, questo tra l'altro dicevamo: «Il missionario è apostolo di Gesù Cristo. Egli non ha l'ufficio di trapiantare la civiltà specificamente europea nelle terre di missione, bensì di rendere quei popoli, che vantano talora culture millenarie, pronti e atti ad accogliere e ad assimilare gli elementi di vita e di costumanza cristiana, che facilmente e naturalmente si accordano con ogni sana civiltà e conferiscono a questa la piena capacità e forza di assicurare e garantire la dignità e la felicità umana. I cattolici indigeni debbono essere veramente membri della famiglia di Dio e cittadini del suo regno (cf. Ef 2, 19), senza però cessare di rimanere cittadini anche della loro patria terrena» (21).
13. Esposizione missionaria degli anni santi 1925 e 1950
Il Nostro predecessore Pio XI, di felice memoria, volle che nell'anno santo 1925 fosse allestita una grandiosa Mostra missionaria di cui egli stesso così delineò l'esito favorevolissimo: «Un divino successo, quello di una nuova e pratica dimostrazione dell'universalità, dell'unità del vivente organismo della chiesa di Dio... L'esposizione è stata e rimane in realtà come un grande, immenso libro» (22).
Noi pure, come sapete, spinti dal proposito di rendere note a quanti più possibile le alte benemerenze missionarie, soprattutto quelle che riguardano in modo particolare il campo della cultura, abbiamo voluto che nel decorso anno santo venisse esposta pubblicamente in una mostra, non lungi dal Vaticano, una ricca documentazione che illustrasse chiaramente il rinnovamento cristiano dell'arte indigena, operato dai missionari sia presso i popoli di antica civiltà, sia in quelli più primitivi.
E la mostra rivelò il valido contributo apportato dagli araldi dell'evangelo al progresso delle arti e degli studi universitari in questo campo; dimostrò ancora come la chiesa non ostacola, ma rispetta e perfeziona al massimo il genio di ciascun popolo.
Dobbiamo alla bontà somma di Dio, se tale avvenimento fu accolto da tutti con singolare favore, costituendo esso un'aperta testimonianza del rinnovato vigore e dei maggiori sviluppi dell'attività missionaria. Per opera dei missionari infatti il sentimento cristiano in mezzo a popoli infedeli, tra loro lontani e diversi per costumi, ha potuto tanto profondamente penetrare negli animi, da dare sì chiare testimonianze di rifioritura di belle arti. Dalla mostra è apparso ancora una volta come solo la fede sinceramente sentita e vissuta sappia innalzare il genio artistico a quelle creazioni, che sono senza dubbio un'ininterrotta tradizione della chiesa cattolica e un magnifico ornamento offerto al culto cristiano.
14. L'Unione missionaria del clero e le Pontificie opere di cooperazione missionaria
Ben ricordate come l'enciclica Rerum Ecclesiae raccomandi vivamente l'Unione missionaria del clero, che mobilita sacerdoti e chierici, sia secolari sia regolari, a unire le forze per aiutare con ogni mezzo la causa missionaria. Noi che, come abbiamo detto sopra, Ci siamo vivamente rallegrati dei notevoli progressi di questa Unione, molto desideriamo che essa si diffonda sempre più e propaghi il senso e il dovere missionario tra i sacerdoti e tra i fedeli affidati alle loro cure. Questa Unione è come una sorgente d'acqua che irriga i campi fioriti delle altre Opere pontificie: della Propagazione della fede, di San Pietro apostolo per il clero indigeno e della Santa Infanzia. Non occorre spendere parole per illustrare l'importanza, la necessità e i meriti di queste Opere, a cui vennero concesse numerose e ricchissime indulgenze dai Nostri predecessori. Noi amiamo molto che, specialmente nella giornata missionaria, si raccolga l'obolo dei fedeli; ma desideriamo ancor più che essi preghino Dio onnipotente, che aiutino i futuri missionari e promuovano il più possibile, con la loro iscrizione, le pontificie opere da noi ricordate. Vi è noto, o venerabili fratelli, che recentemente abbiamo istituito una festa da celebrarsi in modo particolare dai fanciulli, per dare incremento con la preghiera e con le offerte all'Opera della Santa Infanzia. Possano così abituarsi questi nostri figlioletti a pregare vivamente Dio per la salvezza degli infedeli, e voglia il Cielo che possa germogliare il seme dell'apostolato missionario felicemente ricevuto nelle loro anime ancora profumate di innocenza.
Ci piace inoltre segnalare tante e sì belle iniziative che allo stesso fine con zelo così intenso promuovono gli istituti religiosi, per sostenere in ogni maniera le Pontificie opere missionarie; e ugualmente ci piace esprimere la Nostra paterna compiacenza per tutti quei circoli femminili che utilmente si adoperano per confezionare biancheria e vesti liturgiche. Infine, solennemente affermiamo a tutti i ministri della chiesa, a Noi dilettissimi, che quanto si compie dal popolo cristiano per procurare la salvezza degli infedeli ridonda in frutti preziosissimi di più viva fede, e quanto più cresce l'amore per le missioni, tanto più aumenta il fervore della vita cristiana.
15. Appello a tutto il mondo cattolico
Infine non vogliamo porre termine a questa enciclica senza rivolgere con affetto il Nostro pensiero al clero e a tutti i fedeli e manifestare loro anzitutto la Nostra vivissima gratitudine. Anche quest'anno infatti gli aiuti per le missioni hanno segnato un sensibile aumento. Certo, non c'è carità più utile di questa, destinata a estendere il regno di Dio e a procurare la salvezza di tante anime infedeli, poiché il Signore «comandò a ciascuno.., di aver pensiero del suo prossimo» (Eccli 17, 12).
A questo proposito crediamo ora opportuno ripetere con rinnovata ansia e insistenza quanto già abbiamo detto nella lettera indirizzata al Nostro diletto figlio il signor cardinale Pietro Fumasoni Biondi, prefetto della S. C. «De propaganda fide» il 9 agosto 1950: «I fedeli tutti perseverino nel proposito di sostenere le missioni, moltiplichino le loro iniziative a vantaggio di queste, innalzino incessantemente a Dio fervorose preghiere, prestino aiuto a quanti sono chiamati all'apostolato missionario, procurando loro i necessari mezzi secondo le possibilità.
La chiesa, infatti, è il corpo mistico di Cristo, nel quale "se un membro patisce, patiscono insieme tutte le membra" (1 Cor 12, 26). Perciò, essendo oggi molte di tali membra tormentate da acerbe sofferenze e ferite, tutti i cristiani sono vincolati dal sacro dovere di unirsi a loro con solidarietà e simpatia. In alcune terre di missione il furore della guerra ha devastato e distrutto in una maniera orribile non poche chiese e residenze, scuole e ospedali dei missionari. Tutto il mondo cattolico, che certamente è animato da speciale sollecitudine e carità verso le missioni, darà generosamente gli aiuti atti a riparare tali danni e a ricostruire tanti edifici» (23).
Vi è ben noto, venerabili fratelli, che oggi quasi tutta l'umanità va rapidamente dividendosi in due schiere opposte, con Cristo o contro Cristo. Il genere umano al presente attraversa una formidabile crisi che si risolverà in salvezza con Cristo o in funestissime rovine. L'alacre opera dei predicatori dell'evangelo s'adopera, sì, a diffondere il regno di Cristo; ma vi sono altri banditori, che predicano il materialismo e, rigettando ogni speranza di un'eternità beata, cercano di ridurre gli uomini a una condizione di vita quanto mai indegna.
A più forte ragione quindi la chiesa cattolica, madre amorosissima di tutti gli uomini, chiama a raccolta tutti i suoi figli sparsi in ogni parte del mondo, perché cerchino secondo le possibilità di collaborare con gli araldi dell'evangelo, per mezzo delle elemosine, della preghiera e dell'aiuto prestato alle vocazioni missionarie. Maternamente inoltre li esorta a rivestire viscere di misericordia (cf. Col 3, 12), a prendere parte al lavoro missionario col desiderio, se non possono con l'opera, e finalmente a non lasciar inappagato il voto del benignissimo cuore di Gesù, che «venne ... a cercare e a salvare ciò che era stato perduto» (Lc 19, 10). Se riusciranno in qualche maniera ad accendere o a ridestare la fiamma della fede anche in una sola famiglia, sappiano essi che ivi sarà creato un moto di grazia che andrà sempre più allargandosi nei secoli; se contribuiranno alla formazione anche di un solo sacerdote, essi parteciperanno abbondantissimamente ai frutti di tanti suoi sacrifici eucaristici, del suo sacro ministero, della sua santità. Tutti i fedeli infatti compongono un'unica immensa famiglia, i membri della quale partecipano scambievolmente ai beni della chiesa militante, purgante e trionfante. Niente perciò sembra più adatto del dogma della comunione dei santi per ben inculcare nella mente e nel cuore del popolo cristiano l'utilità e l'importanza delle missioni.
Con questi voti paterni e con queste opportune direttive, confidiamo che il venticinquesimo anniversario della pubblicazione dell'enciclica Rerum Ecclesiae sia per tutti i cattolici il punto di partenza per nuovi e sempre più importanti progressi nel campo missionario.
Frattanto, animati da questa dolcissima speranza, a voi singolarmente, o venerabili fratelli, al clero, a tutti i fedeli, a quelli specialmente che o in patria con le loro preghiere e offerte, o nei paesi missionari con la loro attività collaborano a questa santissima causa, con effusione di cuore impartiamo l'apostolica benedizione, in auspicio dei celesti favori e quale segno della Nostra paterna benevolenza.
Roma, presso San Pietro, il 2 giugno, festa di sant'Eugenio I, nell'anno 1951, XIII del Nostro pontificato.
PIUS XII
PER SCARICARE LA LETTERA ENCICLICA "EVANGELII PRAECONES" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

FIDEI DONUM
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO XII
AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI,
PRIMATI,
ARCIVESCOVI,
VESCOVI E AGLI ALTRI ORDINARI .LOCALI
CHE HANNO PACE
E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA
SULLO STATO DELLE MISSIONI CATTOLICHE IN AFRICA
Venerabili Fratelli, salute e Apostolica Benedizione.
Il dono della fede, cui, per divina elargizione, va congiunta nelle anime dei fedeli un’incomparabile abbondanza di beni, domanda apertamente la nostra perenne gratitudine al suo divino autore. La fede, infatti, ci introduce nei segreti misteri della vita divina; in essa si fondano tutte le nostre speranze; essa fin da questa vita terrena rafforza e rinsalda il vincolo della comunità cristiana, secondo il detto dell’Apostolo: « Un unico Signore, una fede, un battesimo » [1].
Essa è per eccellenza il dono che pone sul nostro labbro l’inno della riconoscenza: « Che renderò io al Signore per tutti i Suoi benefici? » [2]. Che cosa offriremo al Signore in cambio di questo dono divino, oltre l’ossequio della mente, se non il nostro zelo per diffondere tra gli uomini lo splendore della divina verità? Lo spirito missionario, animato dal fuoco della carità, è in qualche modo la prima risposta della nostra gratitudine verso Dio, nel comunicare ai nostri fratelli la fede che noi abbiamo ricevuta.
Considerando da un lato le schiere innumerevoli dei Nostri figli che, soprattutto nei paesi di antica tradizione cristiana, sono partecipi del bene della fede, e dall’altro la massa ancor più numerosa di coloro che tuttora attendono il messaggio della salvezza, sentiamo l’ardente desiderio di esortarvi, Venerabili Fratelli, a sostenere con il vostro zelo la causa santa della espansione della Chiesa nel mondo. Voglia Iddio che in seguito al nostro appello lo spirito missionario penetri più a fondo nel cuore di tutti i sacerdoti, e, attraverso il loro ministero, infiammi tutti i fedeli!
Non è certo la prima volta, voi ben lo sapete, che i Nostri Predecessori e Noi stessi vi intratteniamo su questo grave argomento, particolarmente adatto a nutrire il fervore apostolico dei cristiani, resi più consapevoli dei doveri che esige la fede ricevuta da Dio [3]. Si orienti questo fervore verso le regioni scristianizzate d’Europa e verso le vaste contrade dell’America del Sud, dove sappiamo che le necessità sono grandi; si metta a servizio di tante importanti Missioni di Asia e d’Oceania, là soprattutto dove vi è un difficile campo di lotta; sostenga fraternamente le migliaia di cristiani, particolarmente cari al Nostro cuore, che sono l’onore della Chiesa perché sanno la beatitudine evangelica di coloro che « soffrono persecuzione per la giustizia » [4]. Abbia pietà della miseria spirituale delle innumerevoli vittime dell’ateismo moderno, dei giovani soprattutto che crescono nell’ignoranza e talora anche nell’odio di Dio. Tutti còmpiti necessari, urgenti, che esigono da ognuno un risveglio di energia apostolica suscitatore « di immense falangi di apostoli, simili a quelle che conobbe la Chiesa ai suoi albori » [5]. Ma, pur tenendo presenti al Nostro pensiero ed alla Nostra preghiera questi còmpiti indispensabili, pur raccomandandoli al vostro zelo, Ci è sembrato opportuno orientare oggi i vostri sguardi verso l’Africa, nell’ora in cui essa si apre alla vita del mondo moderno ed attraversa gli anni forse più gravi del suo destino millenario.
I
L’espansione della Chiesa in Africa dorante gli ultimi decenni ha da essere senza dubbio, per i cristiani, motivo di gioia e di fierezza. Appena elevati alla Cattedra di Pietro, abbiamo solennemente affermato « di non risparmiare fatica alcuna affinché… la Croce, in cui sono la salvezza e la vita, stenda la sua ombra fino alle più remote plaghe del mondo » [6]; abbiamo favorito con ogni Nostro potere il progresso del Vangelo su quel continente. Le circoscrizioni ecclesiastiche vi si sono moltiplicate; il numero dei cattolici è considerevolmente aumentato e continua ad accrescersi a rapido ritmo. Abbiamo avuto la gioia di istituire in molti paesi la gerarchia ecclesiastica e di elevare già numerosi sacerdoti africani alla dignità episcopale conformemente al « fine ultimo » del lavoro missionario che è di « stabilire saldamente e definitivamente la Chiesa presso nuovi popoli » [7]. In tal modo, nella grande famiglia cattolica, le giovani Chiese Africane prendono oggi il posto che loro spetta, salutate con cuore fraterno dalle più antiche diocesi, che le hanno precedute nella fede.
Legioni di apostoli, sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, collaboratori laici hanno ottenuto sì confortanti risultati mercé un lavoro di cui Dio solo conosce i sacrifici nascosti. Con tutti e con ciascuno di essi, Ci congratuliamo di cuore ed esprimiamo in questa occasione la Nostra gratitudine, poiché la Chiesa può essere giustamente fiera dell’opera dei suoi missionari; i quali sia in Africa sia dovunque lo possano, compiono il proprio dovere. Eppure l’ampiezza dell’opera compiuta non induca alcuno a dimenticare che « il lavoro che resta da fare richiede uno sforzo immenso ed innumerevoli operai » [8]. Al momento in cui l’instaurazione della gerarchia potrebbe erroneamente far credere che l’attività missionaria è sul punto di terminare, più che mai la sollecitudine di tutte le chiese del vasto continente africano riempie il Nostro animo di angoscia. Come dunque non Ci si stringerebbe il cuore nel considerare, da questa Sede Apostolica, i gravi problemi ivi imposti dall’estensione e dall’approfondimento della vita cristiana, quando mettiamo a confronto l’ampiezza e l’urgenza dei compiti da un lato, e dall’altro il numero infimo di operai apostolici e la loro mancanza di mezzi? Questa sofferenza confidiamo a voi, Venerabili Fratelli, e Ci piace pensare che la prontezza e la generosità della vostra risposta faranno di nuovo balenare la speranza nel cuore di tanti generosi apostoli.
Le condizioni generali in cui si svolge in Africa l’opera della Chiesa vi sono note. Esse sono difficili. La maggior parte di quei territori sta attraversando una fase di evoluzione sociale, economica e politica, che è gravida di conseguenze per il loro avvenire; bisogna pur riconoscere che le numerose incidenze della vita internazionale sulle situazioni locali non sempre permettono anche ai governanti più saggi di graduare le tappe che sarebbero necessarie per il vero bene di quei popoli. La Chiesa che, nel corso dei secoli, ha già visto nascere e ingrandirsi tante nazioni, non può oggi non rivolgere particolare attenzione a quei popoli che operano per assicurarsi i diritti delle libertà civili. Già più volte Noi abbiamo esortato le nazioni interessate a procedere per questa via in uno spirito di pace e di comprensione reciproca. «Che una giusta e progressiva libertà politica non sia a quei popoli negata ed ostacolata », dicevamo agli uni; ed avvertivamo gli altri a « riconoscere all’Europa il merito del loro avanzamento; all’Europa, senza il cui influsso, esteso in tutti i campi, essi potrebbero essere trascinati da un cieco nazionalismo a precipitare nel caos o nella schiavitù » [9]. Nel rinnovare qui tale duplice esortazione, formuliamo voti perché si prosegua in Africa un’opera di collaborazione costruttiva, libera da pregiudizi e offese reciproche, preservata dalle seduzioni e dalle strettoie del falso nazionalismo, e capace di estendere a quelle popolazioni, ricche di risorse e di avvenire, i veri valori della civiltà cristiana, che hanno già portato tanti buoni frutti in altri continenti.
Non ignoriamo, infatti, che in molte regioni dell’Africa vengono diffusi i germi di turbolenze dai seguaci del « materialismo » ateo, i quali attizzano le passioni, eccitano l’odio d’un popolo contro l’altro, sfruttano alcune tristi condizioni per sedurre gli spiriti con fallaci miraggi o per seminare la ribellione nei cuori. Nella Nostra sollecitudine per un autentico progresso umano e cristiano delle popolazioni africane, vogliamo qui rinnovare, a loro riguardo, i gravi e solenni moniti che già più volte abbiamo rivolto su questo punto ai cattolici del mondo intero; e Ci piace congratularCi con i loro Presuli per avere già, in più di una circostanza, denunziato fermamente ai loro fedeli il pericolo cui li espongono quei falsi pastori.
Ma mentre i nemici del nome di Dio esplicano su quel continente i loro sforzi insidiosi e violenti, bisogna denunciare altri gravi ostacoli che contrastano in certe regioni i progressi dell’evangelizzazione. Conoscete in particolare la facile attrattiva esercitata su gran numero di spiriti da una concezione religiosa della vita che, pur appellandosi con forza alla Divinità, trascina nondimeno i suoi seguaci in una via che non è quella di Gesù Cristo, unico Salvatore di tutti i popoli. Il Nostro cuore di Padre è aperto a tutti gli uomini di buona volontà; ma, Vicario di Colui che è la Via, la Verità e la Vita, Noi non possiamo considerare un simile stato di cose senza vivo dolore. Varie in realtà sono le cause di ciò; spesso sono cause storiche recenti, e non sempre vi è stato estraneo l’atteggiamento di nazioni che pur si onorano del loro passato cristiano. Vi è in questo, per l’avvenire cattolico dell’Africa, causa di seria sollecitudine. E v’è motivo perché i figli della Chiesa comprendano l’obbligo di aiutare più efficacemente ed in tempo utile i missionari del Vangelo ad annunziare la verità salvatrice ai circa 85 milioni di africani di razza nera ancora attaccati alle credenze pagane.
Quest’ordine di considerazioni diviene ancor più grave per il generale precipitare degli avvenimenti, di cui i Vescovi e gli elementi scelti fra i cattolici d’Africa hanno viva coscienza. Nel momento in cui si cercano nuove strutture, mentre taluni popoli corrono il rischio di abbandonarsi alle più fallaci seduzioni di una civilizzazione tecnica, la Chiesa ha il dovere di offrir loro, nella massima misura possibile, le sostanziali ricchezze della sua dottrina e della sua vita, animatrici di un ordine sociale cristiano. Qualsiasi ritardo sarebbe gravido di conseguenze. Gli Africani, che percorrono in pochi decenni le tappe di un’evoluzione che l'Occidente ha compiuto nel corso di più secoli, sono più facilmente sconvolti e sedotti dall’insegnamento scientifico e tecnico che si dà loro, come pure dagli influssi materialisti che subiscono. Per questo motivo possono prodursi qua o là situazioni difficilmente riparabili, sì da nuocere in seguito alla penetrazione del cattolicesimo nelle anime e nella società. Bisogna, fin da oggi, dare ai Pastori di anime possibilità di azione in proporzione all’importanza ed all’urgenza della presente congiuntura.
Orbene, salvo rare eccezioni, queste possibilità di azione missionaria sono ancora inferiori senza paragone all’opera da compiere; e, sebbene siffatta penuria purtroppo non sia della sola Africa, qui però è più vivamente sentita a motivo delle particolarissime condizioni in cui si trova oggi questo continente. Perciò crediamo molto opportuno, Venerabili Fratelli, parlarvi un po’ più diffusamente su siffatta materia. Nelle missioni recenti, per esempio, fondate magari solo una decina d’anni fa, non si può sperare prima di un lungo tempo un notevole aiuto del clero locale, ed i troppo rari missionari, sparsi su territori immensi, dove lavorano inoltre altre confessioni non cattoliche, non possono più rispondere a tutte le esigenze. In un territorio sono 40 sacerdoti per quasi un milione di anime, tra cui solo 25 mila convertiti; in un altro si contano 50 sacerdoti per una popolazione di due milioni di abitanti, mentre i 60 mila fedeli basterebbero già ad assorbire il tempo dei missionari. A leggere queste cifre, un cuore cristiano non può rimanere insensibile. Venti sacerdoti di più in una determinata regione permetterebbero oggi d’impiantarvi la Croce, mentre domani quella stessa terra, lavorata da altri operai che non quelli del Signore, sarà divenuta forse impenetrabile alla vera fede. Inoltre, non basta annunciare il Vangelo: nella crisi sociale e politica che l’Africa attraversa, bisogna formare quanto prima un gruppo scelto di cristiani in mezzo a un popolo ancor neofito; ma in quale maggior proporzione dovrà moltiplicarsi il numero dei missionari per permetter loro di compiere quest’opera di formazione personale delle coscienze! A questa penuria di uomini si aggiunge inoltre quasi sempre una mancanza di mezzi che rasenta talora la miseria. Chi darà a queste nuove Missioni, situate in genere in regioni povere ma importanti per l’avvenire dell’evangelizzazione, l’aiuto generoso di cui hanno un si urgente bisogno? L’apostolo soffre al vedersi talmente privo di mezzi di fronte alle moltissime opere che gl’incombono. Non ammirazione egli domanda, bensì aiuti coi quali, dov’è ancora possibile, stabilire nuovi centri di lavoro missionario.
Nelle Missioni più antiche, in cui la proporzione già considerevole dei cattolici e il loro fervore sono per il Nostro cuore motivo d’intensa gioia, le condizioni dell’apostolato, benché diverse, non muovono meno a profonda ansietà. Anche li, soprattutto la mancanza di sacerdoti si fa duramente sentire. Quelle Diocesi o Vicariati Apostolici devono infatti sviluppare senza indugio le opere indispensabili all’espansione ed irradiazione del cattolicesimo: occorre fondare collegi e diffondere l’insegnamento cristiano nei suoi vari gradi; occorre dar vita ad organismi di azione sociale che animino il lavoro dei gruppi scelti di cristiani a servizio del civile consorzio; occorre moltiplicare la stampa cattolica in tutte le sue forme e preoccuparsi delle tecniche moderne di diffusione e di cultura, poiché è nota l’importanza, ai nostri giorni, di una pubblica opinione formata ed illuminata; bisogna soprattutto dare un crescente sviluppo all’Azione Cattolica e soddisfare i bisogni religiosi e culturali di una generazione che, priva di sufficiente alimento, sarebbe esposta al pericolo di andar a cercare fuori della Chiesa il suo nutrimento. Orbene, per far fronte a queste diverse esigenze, i Pastori d’anime hanno bisogno, non solo di più grandi mezzi, ma anche e specialmente di collaboratori preparati a questi ministeri che si presentano tanto più difficili quanto più debbono adattarsi alle varie categorie sociali. Siffatti apostoli non si possono improvvisare; sovente essi mancano, eppure l’impegno è urgente, se non si vuol perdere la fiducia di gruppi scelti in ascesa. Perciò vogliamo dire qui tutta la nostra gratitudine alle Congregazioni Religiose, ai sacerdoti e ai militanti laici i quali, compresi della gravità dell’ora, sono andati, anche spontaneamente, incontro a tali bisogni. Iniziative di questo genere hanno dato già frutti e, unite alla dedizione di tutti, lasciano adito a grandissime speranze; ma è Nostro debito di verità affermare che in questo campo rimane da fare un lavoro immenso.
Perfino lo stesso progresso delle Missioni pone alla Chiesa, in certi territori, una nuova difficoltà, giacché il successo dell’evangelizzazione esige un proporzionato aumento del numero degli apostoli, se non si vuol comprometterne il magnifico sviluppo. Ora le Congregazioni Missionarie sono sollecitate da ogni parte e sempre più spesso, e l’insufficienza delle vocazioni non permette loro di venir incontro a tante richieste simultanee. Ben sapete, Venerabili Fratelli, che il numero dei sacerdoti, a paragone di quello dei fedeli, in Africa è in diminuzione. Il clero africano aumenta, senza dubbio; ma solamente tra molti anni esso potrà, nelle proprie Diocesi, prenderne completamente in mano il governo, pur con l’aiuto di quei missionari che vi portano la fede. Quelle giovani cristianità di Africa non possono al presente, con le loro attuali risorse, bastare al loro compito nelle odierne gravissime circostanze.
Varranno le difficoltà di una situazione siffatta a richiamare al loro dovere missionario tanti Nostri figli, che non ringraziano abbastanza Dio del dono della fede ricevuto nella loro famiglia cristiana e dei mezzi di salvezza messi loro a disposizione?
II
Venerabili Fratelli, queste condizioni di apostolato, che abbiamo tracciato a grandi linee, mostrano chiaramente che non si tratta più in Africa di uno di quei problemi ristretti e locali che si possono risolvere a proprio agio a poco a poco e indipendentemente dalla vita generale del mondo cristiano. Se in altri tempi « la vita ecclesiastica, in quanto è visibile, si svolgeva rigogliosa di preferenza nei paesi della vecchia Europa, donde si diffondeva… a quella che poteva dirsi la periferia del mondo; oggi appare invece come uno scambio di vita e di energia fra tutti i membri del Corpo mistico di Cristo sulla terra » [10]. La vita della Chiesa Cattolica in Africa non si restringe a questo continente, ma si ripercuote anche su altri popoli, ed occorre che da tutta la Chiesa, sotto l’impulso di questa Sede Apostolica, venga la risposta fraterna a tanti bisogni.
Non senza motivo dunque, in un’ora importante dell’espansione della Chiesa, Noi Ci rivolgiamo a voi, Venerabili Fratelli. «E a quella guisa che nel nostro mortale organismo, quando un membro soffre, tutti gli altri risentono del suo dolore e vengono in suo aiuto, parimenti nella Chiesa i singoli membri non vivono unicamente per sé, ma porgono aiuto anche agli altri per loro mutua consolazione e per un migliore sviluppo di tutto il Corpo » [11]. Ora non sono i Vescovi, in verità, « i membri più eminenti della Chiesa universale, quelli che sono collegati al capo divino di tutto il Corpo con un legame veramente singolare, onde con diritto sono chiamati “ le principali parti delle membra del Signore ”? » [12]. Di essi più che d’ogni altro si deve dire che Cristo, Capo del Corpo mistico, « ha bisogno delle sue membra: anzitutto perché la persona di Gesù Cristo e rappresentata dal Sommo Pontefice il quale per non essere aggravato dal peso dell’ufficio pastorale, deve rendere anche altri in molte cose partecipi della sua sollecitudine » [13]. Uniti con più stretto legame sia a Cristo sia al Vicario, voi avrete caro, Venerabili Fratelli, di prendere, in ispirito di viva carità, la vostra parte di questa sollecitudine di tutte le chiese [14], che pesa sulle nostre spalle [15]. Voi, stimolati dalla carità di Cristo, sarete contenti di sentire a fondo con Noi l’imperioso dovere di propagare il Vangelo e di fondare la Chiesa nel mondo intero; sarete lieti di effondere tra il vostro clero ed il vostro popolo uno spirito di preghiera e di scambievole aiuto, esteso nelle dimensioni del Cuore di Cristo. « Se vuoi amare Cristo, diceva sant’Agostino, effondi la carità su tutta la terra, perché i membri di Cristo sono sull’intero mondo » [16].
Senza alcun dubbio, al solo Apostolo Pietro ed ai suoi successori, i Romani Pontefici, Gesù ha affidato la totalità del suo gregge: « Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore » [17]; ma, se ogni Vescovo è pastore proprio soltanto della porzione del gregge affidata alle sue cure, la sua qualità di legittimo successore degli Apostoli per istituzione divina lo rende solidalmente responsabile della missione apostolica della Chiesa, secondo la parola di Cristo ai suoi Apostoli: «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi » [18]. Questa missione, che « deve abbracciare tutte le nazioni e tutti i tempi » [19], non è cessata alla morte degli Apostoli; essa dura nella persona di tutti i Vescovi in comunione con il Vicario di Gesù Cristo. In essi, che sono per eccellenza gli inviati, i missionari del Signore, risiede nella sua pienezza « la dignità dell’Apostolato, che è la prima nella Chiesa », come attesta San Tommaso d’Aquino [20].
Dal loro cuore questo fuoco apostolico, portato da Gesù sulla terra, deve comunicarsi al cuore di tutti i Nostri figli e suscitarvi un nuovo ardore per l’azione missionaria della Chiesa nel mondo.
Inoltre, questo interessamento ai bisogni universali della Chiesa manifesta veramente in modo vivo e vero la cattolicità della Chiesa. « Lo spirito missionario e lo spirito cattolico, dicevamo tempo fa, sono una sola e stessa cosa. La cattolicità è una nota essenziale della vera Chiesa: a tal punto che un cristiano non è veramente affezionato e devoto alla Chiesa, se non è ugualmente attaccato e devoto alla sua universalità, desiderando che essa metta radici e fiorisca in tutti i luoghi della terra » [21]. Nulla dunque è più estraneo alla Chiesa di Gesù Cristo che la divisione; nulla è più nocivo alla sua vita dell’isolamento, del ripiegarsi su di sé, e di tutte le forme di egoismo collettivo che inducono una comunità cristiana particolare, qualunque essa sia, a chiudersi in sé. «Madre di tutte le nazioni e di tutti i popoli, non meno che di tutti i singoli uomini », la Chiesa,Sancta Mater Ecclesia, « non è né può essere straniera in alcun luogo; essa vive, o almeno per la sua natura deve vivere, in tutti i popoli » [22]. Al contrario, è necessario affermarlo, nulla di ciò che riguarda la Chiesa, Nostra Madre, è o può essere estraneo ad un cristiano: come la sua fede è la fede di tutta la Chiesa, la sua vita soprannaturale è la vita di tutta la Chiesa, così le gioie e le angosce della Chiesa saranno le sue gioie e le sue angosce; le prospettive universali della Chiesa saranno le prospettive normali della sua vita cristiana; spontaneamente, allora, gli appelli dei Romani Pontefici per i grandi impegni apostolici nel mondo avranno eco nel suo cuore, pienamente cattolico, come gli appelli più cari, più gravi e più urgenti.
III
Missionaria fin dalle sue origini, la santa Chiesa non ha cessato, per compiere l’opera cui non può venir meno, di indirizzare ai suoi figli un triplice invito: alla preghiera, alla generosità, e, per alcuni, al dono di se stessi. Oggi ancora le missioni, soprattutto quelle d’Africa, attendono dal mondo cattolico questa triplice assistenza.
Pertanto, Venerabili Fratelli, Noi desideriamo in primo luogo che per questa intenzione si preghi di più e con un più illuminato fervore. È vostro dovere sostenere, tra i vostri sacerdoti e fedeli, una supplica incessante e istante per sì santa causa; nutrire questa preghiera con un insegnamento adatto e regolari informazioni sulla vita della Chiesa; stimolarla infine in certi periodi dell’anno liturgico, più adatti a ricordare il dovere missionario dei cristiani. Soprattutto pensiamo al tempo di Avvento, che è quello dell’attesa dell’umanità e delle vie provvidenziali di preparazione alla salvezza, alla festa dell’Epifania, che manifesta questa salvezza al mondo, ed a quello della Pentecoste, che celebra la fondazione della Chiesa per il soffio dello Spirito Santo.
La forma più eccellente di preghiera è quella che Cristo, Sommo Sacerdote, rivolge Egli stesso al Padre sugli altari su cui rinnova il suo sacrificio redentore.
In questi anni specialmente, che sono forse decisivi per l’avvenire del cattolicesimo in molti paesi, moltiplichiamo le Messe celebrate per le Missioni; ciò risponde ai desideri del Signore, che ama la sua Chiesa e la vuole estesa e fiorente in ogni luogo della terra. Se le suppliche personali dei fedeli sono senza dubbio legittime, conviene tuttavia rammentare loro a che cosa soprattutto e necessariamente miri il Sacrificio dell’altare; cioè secondo il Canone della Messa di rito latino: « in primis… pro Ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe terrarum ». Queste intenzioni più alte saranno d’altronde meglio comprese quando si tenga presente allo spirito, secondo l’insegnamento della Nostra enciclica «Mediator Dei», che ogni Messa celebrata è essenzialmente un’azione compiuta a nome della Chiesa, poiché « il ministro dell’altare vi rappresenta Cristo offerente, in quanto Capo, in nome di tutti i suoi membri » [23]; è dunque la Chiesa tutta che, mediante Cristo, presenta al Padre l’offerta santa «pro totius mundi salute ». Come dunque non vi si dovrebbe elevare la preghiera dei fedeli, in unione col Papa, i Vescovi e tutta la Chiesa, per implorare da Dio una nuova effusione dello Spirito Santo, grazie a cui, « profusis gaudiis, totus in orbe terrarum mundus exsultat? ».
Pregate dunque, Venerabili Fratelli, pregate di più. Ricordatevi degli immensi bisogni spirituali di tanti popoli ancora così lontani dalla vera fede oppure così privi di soccorsi per perseverarvi. Rivolgetevi al Padre celeste e, con Gesù, ripetete la preghiera che fu quella dei primi Apostoli e rimane quella degli operai apostolici di ogni tempo: « sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra ». Per l’onore di Dio e lo splendore della sua gloria, vogliamo che il suo regno di giustizia, di amore e di pace venga alfine stabilito in ogni luogo. Questo zelo per la gloria di Dio, in un cuore ardente di amore per i propri fratelli, non è forse da ritenersi un vero e proprio zelo missionario? Così infatti si aiutano gli operai apostolici che sono anzitutto araldi di Dio.
Ma sarebbe sincera una preghiera per la Chiesa Missionaria, se non fosse accompagnata, nella misura delle proprie possibilità, da un gesto di generosità?
Noi, certo più di tutti, conosciamo la inestinguibile carità dei Nostri figli, Noi, che ne riceviamo incessantemente splendide e molteplici testimonianze. Noi sappiamo che, grazie alla loro generosità, hanno potuto aver luogo i meravigliosi progressi dell’evangelizzazione dall’inizio di questo secolo. Noi intendiamo qui ringraziare i Nostri diletti figli e dilette figlie che si dedicano al servizio delle missioni in svariate opere, ispirate da una carità industriosa. Vogliamo poi rendere speciale omaggio a coloro che, nelle Pontificie Opere Missionarie, si consacrano all’ufficio — talvolta ingrato ma nobilissimo — di stendere la mano a nome della Chiesa in favore delle nuove cristianità, sua fierezza e sua speranza. Di gran cuore li ringraziamo, come pure esprimiamo la Nostra gratitudine a tutti i membri della Sacra Congregazione de Propaganda Fide, ai quali, sotto la guida del Nostro diletto figlio il Cardinale Prefetto, è stata affidata la grande opera di servire al progresso della Chiesa in vasti continenti.
Il Nostro apostolico ufficio Ci impone tuttavia un dovere, Venerabili Fratelli: di dirvi che questi doni, che riceviamo con tanta gratitudine, sono lungi purtroppo dal bastare ai crescenti bisogni dell’apostolato missionario. Ci giungono continuamente angosciosi appelli di pastori, che vedono il bene da fare, il male da rimuovere, edifici indispensabili da costruire, opere da fondare; per cui siamo profondamente addolorati, per non poter rispondere nella misura necessaria, ma solo in parte e imperfettamente, a queste legittime richieste. Ciò accade, per esempio, per la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo: i sussidi che essa distribuisce ai seminari dei paesi di missione sono considerevoli, ma le vocazioni vi sono, grazie a Dio, ogni anno più numerose ed esigerebbero fondi ancor più cospicui. Bisognerà dunque limitare queste provvidenziali vocazioni nella misura delle somme a disposizione? Bisognerà chiudere, per mancanza di denaro, le porte del seminario a giovani generosi e di ottime speranze, come si dice sia talora accaduto? N, non vogliamo credere che il mondo cristiano, messo davanti alle sue responsabilità, non sarà capace del particolare sforzo che s’impone per far fronte a tali necessità.
Non ignoriamo la durezza dei tempi attuali e le difficoltà delle diocesi antiche di Europa o d’America. Ma, se si citassero cifre, si vedrebbe subito che la povertà degli uni appare un relativo benessere di fronte alla miseria degli altri. Vano paragone, peraltro, perché non tanto si tratta qui di fare dei calcoli, quanto di esortare tutti i fedeli, come abbiamo già fatto in una circostanza solenne, « ad arruolarsi sotto il vessillo della rinuncia cristiana e del dono di sé, che va al di là di ciò che è comandato e fa combattere la buona battaglia generosamente, secondo le forze di ciascuno, secondo l’invito della grazia e la propria condizione … Ciò che si toglierà alla vanità, aggiungevamo, si darà alla carità, si darà con misericordia alla Chiesa ed ai poveri » [24]. Con il denaro che il cristiano spende talora per gusti passeggeri, quanto non farebbe un missionario, paralizzato nel suo apostolato, per mancanza di mezzi! È necessario, dunque, che ogni figlio della Chiesa, ogni famiglia, ogni comunità cristiana facciano a questo riguardo un diligente esame di coscienza. Ricordandovi della « generosità di Gesù Cristo Nostro Signore, che da ricco si è fatto povero per voi, per arricchirvi con la sua povertà » [25] date del vostro superfluo, perfino talvolta del vostro necessario! E ricordate pure che dalla vostra liberalità dipende lo sviluppo dell’apostolato missionario, e che la faccia del mondo sarebbe rinnovata se trionfasse la carità.
La Chiesa in Africa, come negli altri territori di Missione, manca di apostoli. Pertanto Ci rivolgiamo di nuovo a voi, Venerabili Fratelli, per chiedervi di favorire in tutti i modi la cura delle vocazioni missionarie: sacerdoti, religiosi, religiose. Spetta a voi, in primo luogo, come testé dicevamo, rinvigorire i sentimenti dei fedeli e accendere in essi un tale zelo da renderli partecipi delle sollecitudini della Chiesa e atti a dare più volentieri ascolto al comando di Dio, già risonato e poi ripetuto di età in età: « Lascia il tuo paese, la tua famiglia e la casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò » [26].
Una generazione formata a questi ideali veramente cattolici, sia nella famiglia, sia a scuola, nella parrocchia, nell’Azione Cattolica e nelle opere di pietà, darà alla Chiesa gli apostoli di cui essa ha bisogno per annunciare il Vangelo a tutti i popoli. Questo soffio missionario, inoltre, animando le vostre diocesi, sarà per esse un pegno di rinnovamento spirituale. Una comunità cristiana che dona i suoi figli e le sue figlie alla Chiesa non può morire. E se è vero che la vita soprannaturale viene dalla carità e si accresce con il dono di sé, si può affermare che la vitalità cattolica di una nazione si misura con i sacrifici di cui è capace per la causa missionaria.
Non basta tuttavia formare un’atmosfera favorevole a questa causa; bisogna fare di più. Esistono, grazie a Dio, numerose diocesi così largamente provviste di sacerdoti da consentire senza loro danno il sacrificio di alcune vocazioni. Ad esse soprattutto Ci rivolgiamo con paterna insistenza con le parole del Vangelo: « Date ai poveri quello che vi avanza » [27].
Ma Noi pensiamo altresì a coloro, tra i Nostri Fratelli nell’Episcopato, che sono angosciati da un doloroso diradarsi delle vocazioni sacerdotali e religiose e che non possono ormai far fronte alle necessità spirituali nelle loro pecorelle. Facciamo Nostre le loro ansietà e ad essi diciamo come San Paolo ai Corinti: « Non si tratta, per soccorrere gli altri, di ridurvi alla penuria, ma di applicare il principio di uguaglianza » [28].
Tuttavia, anche queste diocesi così provate non siano sorde all’appello delle missioni lontane. L’obolo della vedova fu citato in esempio da Nostro Signore, e la generosità di una diocesi povera verso altre più povere non potrebbe impoverirla, perché Dio non si lascia vincere in generosità.
Per risolvere efficacemente i problemi molteplici della ricerca e della scelta delle vocazioni missionarie, non possono tuttavia bastare gli sforzi isolati. Richiamateli dunque, Venerabili Fratelli, questi problemi nelle vostre adunanze e nel quadro delle organizzazioni nazionali, dove queste esistono: in tal modo, sarà più facile moltiplicare le vie per stimolare più efficacemente gli animi dei giovani già inclini per divina ispirazione alla vocazione missionaria, e così riusciranno più leggere le responsabilità che vi legano solidalmente nel promuovere il bene comune della Chiesa. Favorite largamente nelle vostre diocesi l’Unione Missionaria del Clero, così spesso raccomandata dai Nostri Predecessori e da Noi medesimi, che già l’abbiamo elevata or ora a dignità di Opera Pontificia, sicché nessuno porrà in dubbio la stima che nutriamo per essa e l’importanza che diamo al suo sviluppo. Si stabilisca infine, dappertutto, uno stretto coordinamento degli sforzi, fattore indispensabile di successo, tra i pastori di anime e coloro che lavorano più immediatamente per le Missioni: abbiamo in mente soprattutto i presidenti nazionali delle Opere Pontificie Missionarie, dei quali faciliterete l’opera sostenendo con la vostra autorità e il vostro zelo le direzioni diocesane di queste stesse Opere; ed ancora i superiori delle così benemerite Congregazioni, cui la Santa Sede non cessa di fare appello per rispondere ai bisogni più urgenti delle Missioni e che non possono aumentare il numero delle vocazioni senza la benevola comprensione degli Ordinari locali. Studiate di comune accordo il modo migliore di conciliare gli interessi reali degli uni e degli altri; se talora questi interessi sembrano momentaneamente divergere, non è forse perché si cessa di considerarli con fede sufficiente nella visione soprannaturale dell’unità e della cattolicità della Chiesa?
Nel medesimo spirito di collaborazione fraterna e disinteressata, avrete cura, Venerabili Fratelli, di esser solleciti per l’assistenza spirituale dei giovani africani ed asiatici, che il proseguimento degli studi conduce a dimorare temporaneamente nelle vostre diocesi. Fuori dell’ambiente del loro paese, essi rimangono spesso, e per motivi vari, senza contatti sufficienti con i centri di vita cattolica delle nazioni che li ospitano. Per questo, la loro vita cristiana può trovarsi in pericolo, perché restano tuttora loro nascosti i valori della nuova civiltà alla cui ricerca essi vanno, mentre sono sottoposti alla violenta attrazione dei princìpi del materialismo e all’intenso proselitismo di associazioni atee che si sforzano di guadagnarne la fiducia. Non potrebbe sfuggirvi la gravità di questo stato di cose per il presente e per il futuro. Perciò, venendo incontro alle preoccupazioni dei Vescovi delle Missioni, non esiterete a destinare a questo apostolato qualche sacerdote sperimentato e zelante delle vostre diocesi.
Un’altra forma di aiuto scambievole, certo di più grave incomodo, è adottata da alcuni Vescovi, che autorizzano qualcuno dei loro sacerdoti, sia pure a prezzo di sacrifici, a partire per mettersi, per un certo limite di tempo, a disposizione degli Ordinari d’Africa. Così facendo, rendono loro un impareggiabile servizio, sia per assicurare l’introduzione, saggia e discreta, di forme nuove e più specializzate del ministero sacerdotale, sia per sostituire il clero di dette diocesi nelle mansioni dell’insegnamento, ecclesiastico e profano, cui quello non può far fronte. Volentieri incoraggiamo siffatte iniziative opportune e feconde; preparate e messe in atto con prudenza, esse possono portare una soluzione preziosa in un periodo difficile, ma pieno di speranza, del cattolicesimo africano.
L’aiuto alle diocesi missionarie assume infine al presente una forma che allieta il Nostro cuore e che vi vorremmo proporre prima di finire. Si tratta dell’opera efficace che militanti laici, i quali agiscono per lo più nei movimenti cattolici nazionali o internazionali, accettano di svolgere a servizio delle giovani cristianità. La loro cooperazione esige dedizione, modestia e prudenza, ma assai vantaggiosa riuscirà alle diocesi premute dall’esigenza di nuove opere apostoliche.
Con piena sottomissione al Vescovo del luogo, responsabile dell’apostolato, in perfetta collaborazione altresì con i cattolici africani, che comprendono il beneficio di tale sostegno fraterno, questi militanti laici offrono a diocesi recenti il vantaggio di una lunga esperienza dell’Azione Cattolica e dell’azione sociale, come pure di altre forme particolari di apostolato. Rendono inoltre — e non è il minor vantaggio — più rapida e più facile l’unione delle Organizzazioni cattoliche del proprio paese con le altre innumerevoli d’indole internazionale. Di cuore Ci felicitiamo con loro per lo zelo posto a servizio della Chiesa.
IV
Nell’indirizzarvi questo grave ed urgente appello in favore delle Missioni d’Africa, il Nostro pensiero — voi l’avete ben compreso, Venerabili Fratelli — non si è punto distaccato da tutti quei Nostri figli che si consacrano al progresso della Chiesa in altri continenti. Tutti Ci sono ugualmente cari, quelli soprattutto che più soffrono nelle Missioni dell’Estremo Oriente. Se le peculiari circostanze dell’Africa sono state l’occasione di questa Lettera Enciclica, non vogliamo porvi termine senza rivolgere ancora una volta il Nostro sguardo a tutte le Missioni Cattoliche.
A voi, Venerabili Fratelli, pastori responsabili delle terre di recente evangelizzate, che piantate la Chiesa o la consolidate a prezzo di tante fatiche, vorremmo che la presente Lettera apportasse non solo la testimonianza della Nostra paterna sollecitudine, ma anche l’assicurazione che tutta la comunità cristiana, messa di nuovo sull’avviso circa l’ampiezza e le difficoltà del vostro compito, vi è più che mai vicina per sostenervi con le sue preghiere, i suoi aiuti e l’opera dei migliori tra i suoi figli. Che cosa importa la distanza materiale che vi separa dal Centro della cristianità? Nella Chiesa, i più valorosi ed i più esposti tra i suoi figli, non sono forse i più vicini al suo cuore? A voi ancora, missionari, sacerdoti del clero locale, religiosi e religiose, seminaristi, catechisti, militanti laici, a voi tutti, apostoli di Gesù Cristo, in qualsiasi posto lontano e ignorato voi siate, Noi rinnoviamo l’espressione della Nostra gratitudine e della Nostra speranza; perseverate con fiducia nell’opera intrapresa, fieri di servire la Chiesa, attenti alla sua voce, sempre più penetrati del suo spirito, uniti nei vincoli di una carità fraterna. Qual fonte di consolazione per voi, diletti figli, e quale certezza di vittoria, nel pensiero che l’oscura e pacifica lotta che voi conducete a servizio della Chiesa non è soltanto vostra, e neppure della vostra generazione o del vostro popolo: è in verità la lotta perenne dell’intera Chiesa, cui tutti i suoi figli hanno da partecipare più attivamente, debitori come sono a Dio e ai loro fratelli del dono della fede ricevuto col battesimo.
« Predicare il Vangelo non è per me un titolo di gloria, è una necessità che m’incombe; e guai a me se non predicassi il Vangelo » [29]. Questo energico monito, Noi, Vicario di Gesù Cristo, come non lo applicheremmo a Noi stessi, che, per il Nostro mandato apostolico, siamo costituiti «predicatore e apostolo… dottore delle genti nella fede e nella verità »? [30]. Invocando dunque sulle missioni cattoliche il duplice patrocinio di San Francesco Saverio e di Santa Teresa del Bambino Gesù, la protezione di tutti i Santi martiri e soprattutto la potente e materna intercessione di Maria, Regina degli Apostoli, rivolgiamo nuovamente alla Chiesa quelle parole di vittoria del suo divino Fondatore: « Conduci in alto! » [31].
Fiduciosi che tutti i cattolici risponderanno al Nostro appello con generosità tanto ardente che, per la grazia di Dio, le Missioni potranno finalmente portare fino ai confini della terra la luce del cristianesimo e il progresso della civiltà, accordiamo di gran cuore, quale pegno della Nostra paterna benevolenza e dei celesti favori, a voi, Venerabili Fratelli, ai vostri fedeli, a tutti e a ciascuno degli araldi del Vangelo, a Noi tanto cari, la Nostra Benedizione Apostolica.
Dato a Roma, presso San Pietro, nella festa della Risurrezione di Nostro Signore, il giorno 21 aprile dell’anno 1957, decimonono del Nostro Pontificato.
PIUS PP. XII
PER SCARICARE LA LETTERA ENCICLICA "FIDEI DONUM" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

PRINCEPS PASTORUM
DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PP. XXIII
AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI
PRIMATI ARCIVESCOVI VESCOVI
E AGLI ALTRI ORDINARI LOCALI
CHE SONO IN PACE E COMUNIONE
CON LA SEDE APOSTOLICA,
SULLE MISSIONI CATTOLICHE (1)
Fin da quando, rispondendo con consapevole umiltà all'invito d'amore del «Principe dei pastori» (1 Pt 5,4), ma fiduciosi nel suo potentissimo aiuto, abbiamo assunto il governo e la custodia degli «agnelli» e delle «pecorelle» del gregge di Dio (Gv 21,15-17) sparso su tutta la terra, sempre fu presente al Nostro animo «il problema missionario in tutta la sua vastità, bellezza e importanza».(2) Non abbiamo perciò mai cessato di rivolgere ad esso le Nostre più vive sollecitudini. E nell'omelia del primo anniversario della Nostra incoronazione, abbiamo voluto ascrivere tra i giorni più fausti del Nostro pontificato l'11 ottobre scorso, quando quattrocento e più missionari convennero nella sacrosanta Basilica Vaticana per ricevere dalle Nostre mani il crocifisso, prima di spargersi in tutto il mondo a servizio dell'evangelo.
In questo campo la divina Provvidenza, nei suoi adorabili e amorosi disegni, ha voluto ben presto indirizzare il Nostro ministero sacerdotale. Infatti, all'indomani della prima guerra mondiale, il Nostro predecessore Benedetto XV di v.m. volle chiamarCi dalla Nostra diocesi nativa a Roma, affinché Ci dedicassimo all'«Opera della propagazione della fede», cui attendemmo durante quattro felicissimi anni della Nostra vita sacerdotale. Ed è ancora vivo nella Nostra mente il ricordo di quella memoranda pentecoste dell'anno 1922, allorché Ci fu dato di partecipare con profonda gioia, qui in Roma, alla celebrazione del terzo centenario della fondazione della Sacra Congregazione «de Propaganda Fide», alla quale è appunto affidato il compito di far rifulgere la verità e la grazia dell'evangelo fino agli estremi confini della terra.
In quegli anni, anche il Nostro predecessore di v.m. Pio XI Ci confortò con la sua parola e col suo esempio nell'apostolato missionario, e dalle sue labbra apprendemmo, nell'imminenza del conclave nel quale lo Spirito Santo lo avrebbe designato a successore di Pietro, che «niente di più grandioso poteva attendersi da un vicario di Cristo, qualunque fosse stato l'eletto, di quanto è contenuto in questo duplice ideale: irradiazione straordinaria della dottrina evangelica sul mondo e spirito di pacificazione».(3)
Con la mente piena di questi e altri soavi ricordi e consci dei gravi doveri che incombono al pastore supremo del gregge di Dio, desideriamo, venerabili fratelli, prendere occasione dal 40° anniversario della memorabile lettera apostolica Maximum illud,(4) con la quale il Nostro venerato predecessoreBenedetto XV dava nuovo e decisivo impulso all'azione missionaria nella chiesa, per intrattenervi sulle necessità e le speranze della dilatazione del regno di Dio in quella considerevole parte del mondo, dove si svolge il prezioso e faticoso lavoro dei missionari, affinché sorgano nuove comunità cristiane e apportino salutari frutti.
Su questo argomento anche i Nostri predecessori Pio XI e Pio XII di v.m. hanno impartito opportune norme ed esortazioni per mezzo di encicliche(5) che Noi stessi abbiamo voluto «confermare con l'autorità Nostra e con pari carità» nella Nostra prima enciclica Ad Petri cathedram.(6) Ma non si farà certamente mai abbastanza per portare a compimento il desiderio del divin Redentore, affinché tutte le pecorelle facciano parte di un solo gregge sotto la guida di unico pastore (Gv 10,16).
Nel rivolgere la Nostra particolare attenzione ai soprannaturali interessi della chiesa nelle terre di missione, ai Nostri occhi si offrono regioni rigogliose di messi, regioni nelle quali il lavoro degli operai della vigna di Dio è particolarmente arduo, e regioni ancora dove la violenza della persecuzione e regimi ostili al nome di Dio e di Cristo tentano di soffocare il seme della parola del Signore (Mt13,19). Ma dovunque è grande il bisogno delle anime, e da ogni parte Ci giunge l'invocazione: «Aiutaci» (At 16,9). In tutte queste zone, perciò, che sono state fecondate dal sangue e dal sudore apostolico di eroici araldi dell'evangelo provenienti «da tutte le nazioni che sono sotto il cielo» (At2,5), e dove ora germinano come fioritura e fruttificazione di grazia apostoli nativi, desideriamo far giungere la Nostra affettuosa parola di lode e di incoraggiamento, e insieme anche di ammaestramento, alimentata da una grande speranza che non teme di essere confusa, perché è fondata sulla infallibile promessa del divino Maestro: «Ecco, io sono con voi per tutti i giorni sino alla consumazione dei secoli» (Mt 28,20); «Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo» (Gv 16,33).
I
All'indomani del primo conflitto mondiale, che a tanta parte dell'umanità aveva procurato lutti, devastazioni e sconforti, l'epistola apostolica Maximum illud di Benedetto XV (7) risuonò come un grido di spirituale riscossa per le nuove, pacifiche conquiste del regno di Dio: il solo che possa assicurare a tutti gli uomini figli del Padre celeste una pace duratura e una prosperità vera. Da allora, in un attivissimo e fecondissimo quarantennio di attività missionaria, un fatto della più grande importanza è venuto ad arricchire i già felici progressi delle missioni: lo sviluppo della gerarchia e del clero locale.
Conformemente al «fine ultimo» del lavoro missionario, «che è quello di costituire in modo stabile la chiesa presso gli altri popoli e di affidarla ad una gerarchia propria scelta fra i cristiani del luogo»,(8) questa sede apostolica ha sempre opportunamente e maturamente provveduto, e in questi ultimi tempi con significativa larghezza, a stabilire o ristabilire la gerarchia ecclesiastica in quelle regioni in cui le circostanze permettevano e consigliavano di addivenire alla costituzione di sedi episcopali, affidandole quando era possibile a prelati nativi del luogo. Nessuno, del resto, ignora che questo è stato costantemente il programma d'azione della S. Congregazione «de Propaganda Fide». Fu tuttavia l'epistola apostolica Maximum illud a mettere in piena evidenza, come mai prima d'allora, tutta l'importanza e l'urgenza del problema, richiamando ancora una volta, con accenti accorati e pressanti, l'impegno urgente da parte di chi presiedeva alle missioni, di curare le vocazioni e l'educazione di quello che allora si diceva clero indigeno, senza che questo appellativo abbia mai rivestito alcun significato di discriminazione o di menomazione, che si deve sempre escludere dal linguaggio dei romani pontefici e dei documenti ecclesiastici.
Questo appello di Benedetto XV, rinnovato dai successori Pio XI e Pio XII di v.m., ha già avuto i suoi provvidenziali e visibili frutti, e di ciò vi invitiamo a ringraziare con Noi il Signore, il quale ha suscitato nelle terre di missione una schiera numerosa ed eletta di vescovi e di sacerdoti, fratelli e figli Nostri dilettissimi, aprendo così il Nostro cuore alle più liete speranze. Un rapido sguardo, infatti, alle sole statistiche dei territori affidati alla Sacra Congregazione «de Propaganda Fide», non compresi quelli attualmente soggetti alle persecuzioni, ci mostra che il primo vescovo di stirpe asiatica fu consacrato nel 1923 e i primi vicari apostolici di stirpe africana furono nominati nel 1939. Fino al 1959, si contano 68 vescovi di stirpe asiatica e 25 di stirpe africana. Il clero nativo è passato da 919 membri nel 1918 a 5553 nel 1957 per l'Asia, e da 90 membri a 1811 nello stesso spazio di tempo per l'Africa. In tal modo il Signore delle messi (Mt 9,58) ha voluto premiare le fatiche e i meriti di quanti, con l'azione diretta e con molteplice collaborazione, si sono dedicati al lavoro delle missioni secondo i ripetuti insegnamenti di questa sede apostolica. A ragione, perciò, il nostro predecessorePio XII di v.m. poteva, con legittima soddisfazione, affermare: «Un tempo la vita ecclesiastica, per quello che appare, si svolgeva rigogliosa a preferenza nei paesi della vecchia Europa, donde si diffondeva, come fiume maestoso, a quella che poteva dirsi la periferia del mondo; oggi appare invece come uno scambio di vita e di energie fra tutti i membri del corpo mistico di Cristo sulla terra. Non poche regioni in altri continenti hanno da molto tempo superato il periodo della forma missionaria della loro organizzazione ecclesiastica, sono rette da propria gerarchia e danno a tutta la chiesa dei beni spirituali e materiali, mentre prima soltanto ricevevano».(9) All'episcopato e al clero delle nuove chiese desideriamo rivolgere la Nostra paterna esortazione a pregare e agire in modo tutto particolare, affinché il loro sacerdozio diventi fecondo con l'impegno di parlare spessissimo, nelle istruzioni catechistiche e nella predicazione, della dignità, della bellezza, della necessità e dell'alto merito dello stato sacerdotale, sì da invogliare tutti coloro che Dio volesse chiamare a così eccelso onore, a corrispondere senza indugi e con animo grande alla vocazione divina. Facciamo pregare altresì le anime loro affidate, mentre la chiesa tutta secondo l'esortazione del divino Redentore non cessa di elevare suppliche al cielo per le stesse intenzioni, affinché il Signore «mandi operai per la sua messe» (Lc 10,2), specialmente in questi tempi in cui «la messe è molta e gli operai sono pochi (Lc10,2).
Le chiese locali dei territori di missione, anche fondate e stabilite con la propria gerarchia, sia per la vastità di territorio, sia per il numero crescente dei fedeli e l'ingente moltitudine di quelli che aspettano la luce dell'evangelo, continuano ad aver ancora bisogno dell'opera dei missionari venuti da altri paesi. Di essi, peraltro, si può ben dire: «Essi non sono affatto stranieri, poiché ogni sacerdote cattolico nello svolgimento delle sue mansioni si trova come nella sua patria, dovunque il regno di Dio fiorisce o è ai suoi inizi».(10) Lavorino, dunque, tutti insieme, nell'armonia di una fraterna, sincera e delicata carità, sicuro riflesso dell'amore che essi hanno per il Signore e per la sua chiesa, in perfetta, festosa e filiale obbedienza ai vescovi «che lo Spirito Santo ha posto a reggere la chiesa di Dio» (At 20,28), ognuno grato all'altro per la collaborazione offerta, «un cuore solo e un'anima sola» (At 4,32), affinché dal modo come essi si amano rifulga agli occhi di tutti che sono veramente discepoli di colui che agli uomini ha dato come primo e più grande precetto, come comandamento «nuovo» e suo, quello del mutuo amore (Gv 13,34; 15,12).
II
Il Nostro predecessore nella Maximum illud ebbe a cuore di inculcare ai reggitori di missioni che le loro più assidue premure dovevano essere rivolte alla «completa e perfetta»(11) formazione del clero locale, come quello che «avendo comuni con i suoi connazionali l'origine, l'indole, la mentalità e le aspirazioni, è meravigliosamente adatto a istillare nei loro cuori la fede, perché più di ogni altro sa le vie della persuasione».(12)
È appena necessario ricordare che un'educazione sacerdotale perfetta deve essere innanzitutto rivolta all'acquisto delle virtù proprie del santo stato, essendo questo il primo dovere del sacerdote, «il dovere cioè di attendere alla propria santificazione».(13) Il nuovo clero nativo deve entrare in una santa gara col clero delle più antiche diocesi, che ha dato al mondo sacerdoti i quali, per l'eroicità delle loro specchiate virtù e l'eloquenza viva del loro esempio, hanno meritato di essere proposti a modello del clero di tutta la chiesa. È specialmente con la santità, infatti, che il clero può dimostrare di essere luce e sale della terra (Mt 5,13-14), cioè della propria nazione e di tutto il mondo, può convincere della bellezza e potenza dell'evangelo, può efficacemente insegnare ai fedeli che la perfezione della vita cristiana è una mèta alla quale possono e devono tendere con ogni sforzo e con perseveranza tutti i figli di Dio, qualunque sia la loro origine, il loro ambiente, la loro cultura e la loro civiltà.
Nel Nostro animo paterno vagheggiamo il giorno in cui il clero locale potrà ovunque dare soggetti capaci di educare alla santità gli alunni stessi del santuario come loro guide spirituali. Ai vescovi e ai reggitori di missioni, Noi rivolgiamo anzi l'invito di non esitare a scegliere fin d'ora, tra il clero locale, sacerdoti i quali per la loro virtù e la loro prudenza diano affidamento di essere per i seminaristi loro connazionali sicuri maestri nella formazione spirituale.
La chiesa, inoltre, come voi ben sapete, venerabili fratelli, ha sempre richiesto che i suoi sacerdoti siano resi adatti al loro ministero mediante un'educazione intellettuale solida e compiuta. Che di tanto siano capaci i giovani di ogni stirpe e provenienti da ogni parte del mondo, non vale più la pena nemmeno di ricordarlo, tanto i fatti e l'esperienza lo hanno dimostrato con evidenza. Ovviamente, la formazione del clero locale deve tenere nel debito conto i fattori ambientali propri delle varie regioni. Per tutti i candidati al sacerdozio vale la sapientissima norma secondo la quale essi non devono essere formati «in un ambiente troppo avulso dal mondo»,(14) poiché in tal modo «quando andranno in mezzo alla società troveranno poi serie difficoltà nelle relazioni col popolo e con la classe colta, e quindi succederà spesso o che prendano un atteggiamento errato e falso verso i fedeli, o che considerino sfavorevolmente la formazione ricevuta».(15) Essi dovranno essere sacerdoti spiritualmente perfetti, ma anche «gradualmente e prudentemente inseriti in quella parte del mondo»(16) che è toccata loro in sorte, perché la illuminino con la verità e la santifichino con la grazia di Cristo. A tale scopo, anche per quel che riguarda il regime di vita del seminario, conviene insistere sulla maniera di vivere locale, non senza, però, mettere a frutto tutte quelle facilitazioni di ordine tecnico o materiale che ormai sono bene e patrimonio di tutte le civiltà, in quanto rappresentano un reale progresso per un tenore di vita più elevato e una più adatta salvaguardia delle forze fisiche.
La formazione del clero autoctono, diceva il Nostro venerato predecessore Benedetto XV, deve mirare a renderlo capace di prendere nelle mani, appena ciò è possibile, il governo delle nuove chiese e di guidare, con l'insegnamento e il ministero, i propri connazionali nella via della salvezza.(17) A tale scopo, Ci sembra sommamente opportuno che tutti coloro i quali, sia allogeni che nativi, curano detta formazione, si impegnino coscienziosamente a sviluppare nei loro alunni il senso di responsabilità e lo spirito di iniziativa,(18) in modo che questi siano in grado di assumere ben presto e progressivamente tutte le mansioni, anche le più importanti, inerenti al loro ministero, in perfetta concordia col clero allogeno, ma anche in eguale misura. Questa, infatti, sarà la prova della reale efficacia dell'educazione ad essi impartita e costituirà il coronamento e il premio migliore di quanti vi hanno contribuito.
In vista appunto di una formazione intellettuale che tenga conto delle necessità reali e della mentalità di ciascun popolo, questa sede apostolica ha sempre raccomandato gli studi speciali di missionologia non soltanto per il clero allogeno, ma anche per il clero nativo. Così il Nostro predecessoreBenedetto XV decretava l'istituzione degli insegnamenti di materie missionarie nel Pontificio ateneo Urbaniano «de Propaganda Fide»,(19) e Pio XII rilevava con soddisfazione l'erezione dell'Istituto missionario scientifico nello stesso ateneo Urbaniano «e l'istituzione, sia a Roma che altrove, di facoltà e cattedre di missionologia».(20) Perciò i programmi dei seminari locali in terra di missione non mancheranno di assicurare corsi di studio nei vari rami della missionologia e l'insegnamento delle diverse conoscenze e tecniche specialmente utili per il ministero futuro del clero di quelle regioni. Si provvederà a tale scopo ad un insegnamento che, nello spirito della più pura e salda tradizione ecclesiastica, sappia formare accuratamente il giudizio dei sacerdoti sui valori culturali locali, specialmente filosofici e religiosi, nella loro relazione con l'insegnamento e la religione cristiana. «La chiesa cattolica - ha detto il Nostro immortale predecessore Pio XII - non disprezza o rigetta completamente il pensiero pagano, ma piuttosto, dopo averlo purificato da ogni scoria di errore, lo completa e lo perfeziona con sapienza cristiana. Così parimenti ha accolto il progresso nel campo delle scienze e delle arti... e in qualche maniera consacrò i particolari costumi e le antiche tradizioni dei popoli; le stesse feste pagane, trasformate, servirono per celebrare le memorie dei martiri e i divini misteri».(21) Noi stessi abbiamo già avuto modo di manifestare su questo argomento il Nostro pensiero: «Dappertutto... dove autentici valori d'arte e di pensiero sono suscettibili di arricchire la famiglia umana, la chiesa è pronta a favorire tali fatiche dello spirito. Essa medesima, come sapete, non si identifica con nessuna cultura, nemmeno con la cultura occidentale, alla quale la sua storia è strettamente legata. Perché la sua missione appartiene a un altro ordine, all'ordine della salute religiosa dell'uomo. Però la chiesa, così ricca di giovinezza che incessantemente si rinnova al soffio dello Spirito, resta sempre disposta a riconoscere, ad accogliere anzi, anche ad animare tutto quello che è di onore all'intelligenza e al cuore umano nelle altre parti del mondo, diverso da questo bacino mediterraneo, che fu culla provvidenziale del cristianesimo».(22)
I sacerdoti nativi ben preparati e addestrati in questo campo così difficile e importante, nel quale essi sono in grado di dare contributi assai preziosi, potranno dar vita, sotto la direzione dei loro vescovi, a movimenti di penetrazione anche fra le classi colte, specialmente nelle nazioni di antica e alta cultura, sull'esempio di famosi missionari dei quali basti citare per tutti il p. Matteo Ricci. Anche al clero nativo, infatti, spetta il compito di «ridurre ogni intelletto all'ossequio di Cristo» (2 Cor 10,5), come diceva quell'incomparabile missionario che fu san Paolo, e così «attirarsi in patria la stima anche delle personalità e dei dotti».(23) A loro giudizio, i vescovi provvedano tempestivamente a costituire, per i bisogni di una o più regioni, dei centri di cultura, nei quali missionari allogeni e sacerdoti nativi avranno modo di mettere a frutto la loro preparazione intellettuale e la loro esperienza a beneficio della società in cui vivono per elezione o per nascita. In questo campo è necessario anche ricordare ciò che ha suggerito il Nostro immediato predecessore Pio XII, che cioè è dovere dei fedeli «moltiplicare e diffondere la stampa cattolica in tutte le sue forme»(24) e preoccuparsi altresì «delle tecniche moderne di diffusione e di cultura, poiché è nota l'importanza di una pubblica opinione formata e illuminata».(25) Non tutto si potrà fare dovunque, ma non bisogna lasciarsi sfuggire nessuna buona occasione per provvedere a queste reali e urgenti necessità, anche se talvolta «chi semina non è lo stesso che raccoglie» (Gv 4,37).
La diffusione della verità e della carità di Gesù Cristo è la vera missione della chiesa, che ha il dovere di offrire ai popoli «nella massima misura possibile, le sostanziali ricchezze della sua dottrina e della sua vita, animatrice di un nuovo ordine sociale cristiano».(26) Essa perciò, nei territori di missione, provvede con tutta la larghezza possibile anche a iniziative di carattere sociale e assistenziale che sono di sommo giovamento alle comunità cristiane e ai popoli in mezzo ai quali esse vivono. Si badi tuttavia a non ingombrare l'apostolato missionario con un complesso di istituzioni di ordine puramente profano. Ci si limiti a quei servizi indispensabili di agevole mantenimento e di facile uso, il cui funzionamento potrà essere messo al più presto nelle mani del personale locale, e si dispongano le cose in modo che al personale propriamente missionario venga offerta la possibilità di dedicare le migliori energie al ministero di insegnamento, di santificazione e di salvezza.
Se è vero che, per un apostolato il più ampiamente fruttuoso, è di primaria importanza che il sacerdote nativo conosca e sappia con ogni intelligenza e prudenza stimare i valori locali, resterà ancora a maggior ragione vero che per esso vale ciò che il Nostro immediato predecessore diceva di tutti i fedeli: «Le prospettive universali della chiesa saranno le prospettive normali della loro vita cristiana».(27) A tal fine, il clero locale dovrà essere non solo informato degli interessi e delle vicende della chiesa universale, ma dovrà essere educato a un intimo, universale respiro di carità. San Giovanni Crisostomo diceva delle celebrazioni liturgiche cristiane: «Quando noi siamo all'altare, preghiamo innanzi tutto per il mondo intero e per gli interessi collettivi»;(28) e sant'Agostino bellamente affermava: «Se vuoi amare Cristo, effondi la carità su tutta la terra, perché i membri di Cristo sono nel mondo intero».(29)
Nel desiderio appunto di salvaguardare in tutta la sua purezza questo spirito cattolico che deve animare l'opera dei missionari, il Nostro predecessore Benedetto XV non esitò a denunciare con espressioni severe un pericolo che poteva far perdere di vista le altissime finalità dell'apostolato missionario e comprometterne così l'efficacia: «Sarebbe cosa ben triste - così scriveva nell'epistolaMaximum illud - se qualche missionario si rivelasse talmente noncurante della sua dignità da pensare più alla patria terrena che alla celeste, e preoccuparsi eccessivamente di dilatare la sua potenza ed estendere la sua gloria. Questo modo di agire costituirebbe un danno funestissimo per l'apostolato, e nel missionario spegnerebbe ogni slancio di carità verso le anime e ne diminuirebbe il prestigio nell'opinione del popolo».(30)
Il medesimo pericolo potrebbe oggi ripetersi sotto altre forme, per il fatto che in molti territori di missione si va facendo generale l'aspirazione dei popoli all'autogoverno e all'indipendenza, e la conquista delle libertà civili può sfortunatamente accompagnarsi ad eccessi che non sono affatto in armonia con gli autentici e profondi interessi spirituali dell'umanità.
Noi siamo pienamente fiduciosi che il clero nativo, mosso da sentimenti e da propositi superiori in conformità con le esigenze universalistiche della religione cristiana, contribuirà altresì al bene reale della propria nazione.
«La chiesa di Dio è cattolica e non è straniera presso nessun popolo o nazione»,(31) diceva lo stesso Nostro predecessore, e nessuna chiesa locale potrà esprimere la sua vitale unione con la chiesa universale, se il suo clero e il suo popolo si faranno suggestionare dallo spirito particolaristico, da sentimenti di malevolenza verso gli altri popoli, da un malinteso nazionalismo che distruggerebbe la realtà di quella universale carità che edifica la chiesa di Dio, che sola è veramente «cattolica».
III
Insistendo sulla necessità di preparare col più grande zelo l'avvento del clero autoctono e di formarlo adeguatamente allo scopo, il Nostro venerato predecessore Benedetto XV non intendeva certamente escludere l'importanza, anch'essa fondamentale, di un laicato nativo all'altezza della propria vocazione cristiana e impegnato nell'apostolato. Ciò fece espressamente e con tutto il rilievo l'immediato Nostro predecessore Pio XII,(32) il quale ritornò più volte su questo vitale argomento che, oggi più che mai, si impone alla considerazione e richiede di essere risolto dovunque nella massima misura possibile.
Lo stesso Pio XII - e ciò torna a suo singolare merito e lode - con copiosa dottrina e rinnovati incitamenti ha ammonito e incoraggiato i laici a prendere sollecitamente il loro posto attivo nel campo dell'apostolato in collaborazione con la gerarchia ecclesiastica; infatti, fin dai primordi della storia cristiana e in tutte le epoche successive, questa collaborazione dei fedeli ha fatto sì che i vescovi e il clero potessero efficacemente sviluppare la loro opera tra i popoli, sia nel campo propriamente religioso che in quello sociale. Ciò può e deve verificarsi anche nei nostri tempi, i quali, anzi, rivelano maggiori bisogni, proporzionati a un'umanità numericamente più vasta e con esigenze spirituali moltiplicate e complesse. Del resto, dovunque viene fondata la chiesa, essa deve essere sempre presente e attiva con tutta la sua struttura organica, e quindi non soltanto con la gerarchia nei vari suoi ordini, ma anche col laicato; ed è quindi per mezzo del clero e dei laici che essa necessariamente deve svolgere la sua opera di salvezza.(33)
Nelle nuove cristianità, non si tratta soltanto di procurare, con le conversioni e i battesimi, un gran numero di cittadini al regno di Dio, ma di renderli anche adatti, con un'adeguata educazione e formazione cristiana, ad assumere ognuno secondo la propria condizione e le proprie possibilità le loro responsabilità nella vita e nell'avvenire della chiesa. Il numero dei cristiani significherebbe poco se difettasse la qualità, se venisse meno la saldezza dei fedeli stessi nella professione cristiana e se mancasse l'approfondimento della loro vita spirituale; se, dopo esser nati alla fede e alla grazia, essi non fossero aiutati a progredire nella giovinezza e nella maturità dello spirito, che dona slancio e prontezza per il bene. La professione di fede cristiana, infatti, non può essere ridotta a un dato anagrafico, ma deve investire e modificare l'uomo nel profondo (Ef 4,24), dare significato e valore a tutte le sue manifestazioni.
A tale mèta di maturità i laici non potranno giungere se il clero, sia allogeno che nativo, non si proporrà tempestivamente il programma suggerito già nelle linee essenziali dal primo papa: «Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, gente santa, popolo tratto in salvo perché facciate conoscere i prodigi di colui che dalle tenebre vi chiamò all'ammirabile sua luce» (1 Pt 2,9).
Un'istruzione ed educazione cristiana che si ritenesse paga di aver insegnato e fatto apprendere le formule del catechismo e i precetti fondamentali della morale cristiana con una sommaria casistica, senza impegnare la condotta pratica, si esporrebbe al rischio di procurare alla chiesa di Dio un gregge per dir così passivo. Il gregge di Cristo, invece, è formato di pecorelle che non solo ascoltano il loro pastore, ma sono in grado di riconoscerne la voce (cf. Gv 10,4-14), di seguirlo fedelmente e con piena consapevolezza sui pascoli della vita eterna (Gv 10,9-10) per poter meritare un giorno dal Principe dei pastori «la corona immarcescibile della gloria» (1Pt 5,4), pecorelle che, conoscendo e seguendo il Pastore che ha dato la vita per esse (cf. Gv 10,11), siano pronte a dedicare la loro vita a lui e adempierne la volontà di condurre a far parte dell'unico ovile le altre pecorelle che non lo seguono, ma vagano lontane da lui, che è via, verità e vita (cf. Gv 14,6).
Lo slancio apostolico appartiene essenzialmente alla professione di fede cristiana: infatti «ognuno è tenuto a diffondere in mezzo agli altri la sua fede, sia per istruire o confermare gli altri fedeli, sia ancora per respingere gli attacchi degli infedeli»,(34) specialmente nei tempi, come i nostri, in cui l'apostolato è un impegno urgente per le difficili circostanze in cui versano l'umanità e la chiesa.
Affinché sia possibile una completa e intensa educazione cristiana, si richiede che gli educatori siano capaci di trovare le vie e i mezzi più adatti per penetrare nelle varie psicologie, onde facilitare al massimo nei nuovi cristiani l'assimilazione profonda della verità con tutte le sue esigenze. Il nostro Salvatore, infatti, ha imposto a ognuno di noi la realizzazione di questo supremo comandamento: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente» (Mt22,37). Agli occhi dei fedeli deve ben presto brillare in tutto il suo splendore la sublimità della vocazione cristiana, affinché efficacemente si accenda nel loro cuore il desiderio e il proposito di una vita virtuosa e attiva, modellata sulla vita stessa del Signore Gesù, che avendo assunto la umana natura ci ha comandato di seguire i suoi esempi (cf. 1 Pt 2,21; Mt 11,29; Gv 13,15).
Ogni cristiano deve essere convinto del suo fondamentale e primordiale dovere di essere testimone della verità in cui crede e della grazia che lo ha trasformato. «Il Cristo - diceva un grande padre della chiesa - ci ha lasciati sulla terra affinché adempissimo il nostro compito di fermento, affinché ci comportassimo come angeli, come annunziatori tra gli uomini, affinché fossimo adulti tra i minori, uomini spirituali tra i carnali al fine di guadagnarli, affinché fossimo semente e portassimo frutti numerosi. Non sarebbe neppur necessario esporre la dottrina, se la nostra vita fosse a tal punto irradiante; non sarebbe necessario ricorrere alle parole, se le nostre opere dessero una tale testimonianza. Non ci sarebbe più alcun pagano, se ci comportassimo da veri cristiani».(35)
Questo, come è facile comprendere, è il dovere di tutti i cristiani di tutto il mondo. Ma è facile capire che nei paesi di missione esso potrebbe portare frutti speciali e particolarmente preziosi ai fini della dilatazione del regno di Dio anche presso coloro che non conoscono la bellezza della nostra fede e la soprannaturale potenza della grazia, come già ci esortava Gesù: «Così risplenda la vostra luce dinanzi agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone, e glorifichino il vostro Padre che è nei cieli» (Mt5,16), e san Pietro ammoniva amorosamente i fedeli: «O cari, io vi esorto... ad astenervi dalle brame carnali, che fanno guerra all'anima, e a tener fra i gentili buona condotta affinché mentre ora vi calunniano quali malfattori, per effetto delle vostre buone opere, osservando meglio, diano gloria a Dio quando piacerà visitarli» (1 Pt 2,12).
La testimonianza dei singoli ha bisogno di essere confermata e ampliata da quella di tutta intera la comunità cristiana, a somiglianza di quanto avveniva nella stagione primaverile della chiesa, quando l'unione compatta e perseverante di tutti i fedeli «nell'insegnamento degli apostoli e nella comune frazione del pane e nelle orazioni» (At 2,42) e nell'esercizio della più generosa carità era motivo di soddisfazione profonda e di mutua edificazione; infatti essi «lodavano Dio ed erano ben visti da tutto il popolo. E il Signore poi aumentava ogni giorno quelli che venivano a salvezza» (At 2,47).
L'unione nelle preghiere e nella partecipazione attiva alla celebrazione dei divini misteri nella liturgia della chiesa contribuisce in maniera particolarmente efficace alla pienezza e ricchezza della vita cristiana dei singoli e della comunità, ed è un mezzo mirabile per educare a quella carità che è il segno distintivo del cristiano; una carità che rifugge da ogni discriminazione sociale linguistica e razziale, che allarga le braccia e il cuore a tutti, fratelli e nemici. Su questo argomento Ci piace fare Nostre le parole del Nostro predecessore san Clemente Romano: «Quando [i gentili] odono da noi che Dio dice: "Non c'è merito per voi se amate quelli che vi amano, ma c'è merito se amate i nemici e coloro che vi odiano" (Lc 6,32-35), all'udire queste parole essi ammirano l'altissimo grado di carità. Ma quando vedono che noi non solo non amiamo quelli che ci odiano, ma neppure quelli che ci amano, essi ridono di noi e il nome [di Dio] è bestemmiato».(36) Il più grande dei missionari, san Paolo apostolo, scrivendo ai Romani nel momento in cui si accingeva ad evangelizzare l'estremo occidente, esortava alla «carità senza finzione» (Rm 12,9ss), dopo aver elevato un inno sublime a questa virtù, «senza la quale il cristiano è nulla» (1 Cor 13,2).
La carità diventa visibile altresì nel soccorso materiale, come affermava il Nostro immortale predecessore Pio XII: «Il corpo esige anche una moltitudine di membra, tra di loro congiunte per darsi vicendevole aiuto. Che se, nel nostro organismo mortale, quando un membro soffre, tutti gli altri soffrono con lui, fornendo i membri sani il proprio aiuto a quelli malati, parimenti nella chiesa ogni membro non vive unicamente per sé, ma aiuta altresì gli altri per loro mutua consolazione, come pure per un migliore sviluppo di tutto il corpo mistico».(37)
Le necessità materiali dei fedeli includono anche quella dell'organismo ecclesiastico, ed è bene perciò che i fedeli nativi si abituino a sostenere spontaneamente, nella misura delle loro possibilità, le loro chiese, le loro istituzioni e il clero che si è tutto dedicato ad essi. Non importa se questo contributo non potrà essere notevole; l'importante è che sia testimonianza sensibile di viva coscienza cristiana.
IV
I fedeli cristiani, membra di un organismo vivo, non possono restar chiusi in se stessi e credere che basti aver pensato e provveduto ai propri bisogni spirituali per compiere tutto il loro dovere. Ognuno, invece, per la propria parte deve contribuire all'incremento e alla diffusione del regno di Dio sulla terra. Il Nostro predecessore Pio XII ha richiamato a tutti questo universale dovere: «La cattolicità è una nota essenziale della vera chiesa: a tal punto che un cristiano non è veramente affezionato e devoto alla chiesa, se non è ugualmente attaccato e devoto alla sua universalità, desiderando che essa metta radici e fiorisca in tutti i luoghi della terra».(38)
Tutti devono entrare in una gara di santa emulazione e dare assidue testimonianze di zelo per il bene spirituale del prossimo, per la difesa della propria fede, per farla conoscere a chi la ignora del tutto o a chi malamente la conosce e perciò malamente la giudica. Fin dall'infanzia e dall'adolescenza, anche nelle più giovani comunità cristiane, è necessario che il clero, le famiglie e le varie organizzazioni locali di apostolato inculchino questo santo dovere. Ci sono poi alcune occasioni particolarmente felici, in cui tale educazione all'apostolato può trovare il posto più adatto e la più convincente espressione. Tale, per esempio, è la preparazione dei giovanetti o dei neo-battezzati al sacramento della confermazione, con cui «viene infusa una nuova forza nei credenti per difendere la santa madre chiesa e la fede che hanno da essa ricevuto»;(39) preparazione, questa, sommamente opportuna, là specialmente dove esistono nei costumi locali apposite cerimonie di iniziazione per preparare i giovani all'ingresso ufficiale nel loro gruppo sociale.
Non possiamo qui fare a meno di dare il giusto rilievo all'opera dei catechisti, che nella lunga storia delle missioni cattoliche si sono dimostrati di insostituibile ausilio. Essi sono sempre stati il braccio destro degli operai del Signore, e ne hanno partecipato e alleviato le fatiche al punto che i Nostri predecessori potevano considerare il loro reclutamento e la loro formazione accuratissima tra i «punti importantissimi per la diffusione dell'evangelo»(40) e definirli «il caso forse più classico dell'apostolato laico».(41) Ad essi Noi rinnoviamo i più ampi elogi e li esortiamo a meditare sempre più sulla spirituale felicità della loro condizione e a non desistere mai da ogni sforzo per arricchire e approfondire, sotto la guida della gerarchia, la loro istruzione e formazione morale. I catecumeni devono imparare da essi non soltanto i rudimenti della fede, ma anche la pratica della virtù, l'amore grande e sincero a Cristo e alla sua chiesa. Ogni cura dedicata all'aumento del numero di questi validissimi aiuti della gerarchia e alla loro adeguata formazione, e ogni sacrificio dei catechisti per adempiere nel modo più adatto e perfetto il loro compito, sarà un contributo di immediata efficacia per la fondazione e il progresso delle nuove comunità cristiane.
Nella Nostra prima enciclica abbiamo già richiamato i molteplici gravi motivi che impongono oggi, in tutti i paesi del mondo, di reclutare i laici «nel pacifico esercito dell'Azione cattolica, con l'intento di averli collaboratori nell'apostolato della gerarchia ecclesiastica».(42) Abbiamo anche manifestato il Nostro compiacimento per «quanto si è fatto nel passato, anche in terre di missione, da questi preziosi collaboratori dei vescovi e dei sacerdoti»,(43) e vogliamo qui rinnovare, con tutta l'urgenza della carità che Ci sospinge (2 Cor 5,14), l'ammonimento e l'appello del Nostro predecessore Pio XII «sulla necessità che i laici tutti nelle missioni, affluendo numerosissimi nelle file dell'Azione cattolica, collaborino attivamente con la gerarchia ecclesiastica nell'apostolato».(44) I vescovi dei paesi di missione, il clero secolare e regolare, i fedeli più generosi e preparati, hanno compiuto i più lodevoli sforzi per tradurre in atto questa volontà del sommo pontefice, e si può dire che dovunque ormai è una fioritura di iniziative e di opere. Non si insisterà mai abbastanza, però, sulla necessità di adattare convenientemente questa forma di apostolato alle condizioni ed esigenze locali. Non basta trasferire in un paese ciò che è stato fatto altrove, ma sotto la guida della gerarchia e nello spirito della più lieta obbedienza ai sacri pastori, bisogna fare in modo che l'organizzazione non risulti un sovraccarico che imbrigli o disperda preziose energie, con movimenti frammentari e di eccessiva specializzazione che, necessari altrove, potrebbero risultare meno utili in ambienti, dove le circostanze e i bisogni sono del tutto diversi. Nella Nostra prima enciclica abbiamo anche promesso di ritornare con maggiore ampiezza sopra questo argomento dell'Azione cattolica e a suo tempo anche i paesi di missione potranno trarne giovamento e impulso nuovo. Nel frattempo, tutti lavorino in piena concordia e con spirito soprannaturale, nella convinzione che soltanto così potranno gloriarsi di mettere le loro forze al servizio della causa di Dio, della spirituale elevazione e del miglior progresso dei loro popoli.
L'Azione cattolica è una organizzazione di laici «con proprie e responsabili funzioni esecutive»;(45) i laici quindi ne compongono i quadri direttivi. Ciò comporta la formazione di uomini capaci di imprimere alle varie associazioni lo slancio apostolico e di assicurarne il miglior funzionamento; uomini e donne, quindi, per essere degni di vedersi affidare dalla gerarchia la direzione centrale o periferica delle associazioni, devono fornire le più ampie garanzie di una formazione cristiana intellettuale e morale solidissima, in virtù della quale possano «trasfondere negli altri ciò che essi già, con l'aiuto della divina grazia, posseggono».(46)
Si può ben dire che la sede naturale di questa formazione dei dirigenti laici di Azione cattolica sia la scuola. E la scuola cristiana giustificherà la sua ragion d'essere nella misura in cui i suoi maestri, sacerdoti e laici, religiosi e secolari, riusciranno a formare dei solidi cristiani.
Nessuno ignora l'importanza che ha sempre avuto e avrà la scuola nei paesi di missione e quanta energia la chiesa ha impiegato nell'istituzione di scuole di ogni ordine e grado, e nella difesa della loro esistenza e prosperità. Ma un programma di formazione di dirigenti di Azione cattolica, come è ovvio, difficilmente può trovare il suo posto nei corsi scolastici, per cui sarà il più spesso necessario affidarsi a iniziative extrascolastiche che raccolgano i giovani di migliori speranze per istruirli e formarli all'apostolato. Gli ordinari, perciò, procureranno di studiare la forma migliore per dar vita a scuole di apostolato, i cui metodi educativi sono ovviamente differenti dai metodi scolastici veri e propri. A volte si tratterà anche di preservare da false dottrine fanciulli e giovani che sono costretti a frequentare scuole non cattoliche; in ogni caso sarà necessario bilanciare l'educazione umanistica e tecnica ricevuta nelle scuole pubbliche con un'educazione spirituale particolarmente intelligente e intensa, affinché non accada che l'istruzione produca individui falsamente evoluti, pieni di pretese e piuttosto nocivi che utili alla chiesa e ai popoli. La loro formazione spirituale deve essere contemperata al grado di sviluppo intellettuale, intesa a prepararli a vivere cattolicamente nel loro ambiente sociale e professionale e ad assumere, a suo tempo, il loro posto nella vita cattolica organizzata. A tale scopo, nel caso in cui i giovani cristiani siano costretti a lasciare la loro comunità per frequentare in altre città le scuole pubbliche, sarà opportuno pensare all'istituzione di «pensionati» e luoghi di ritrovo che assicurino ad essi un ambiente religiosamente e moralmente sano, congeniale e adatto a indirizzare le loro capacità ed energie verso gli ideali apostolici. Attribuendo alle scuole un compito speciale e particolarmente efficace nella formazione dei dirigenti di Azione cattolica, non vogliamo certo sottrarre alle famiglie la loro parte di responsabilità, né negare il loro influsso, che può essere anche più vigoroso ed efficace di quello della scuola, nell'alimentare nei loro figliuoli la fiamma dell'apostolato e nel curare una formazione cristiana sempre più matura e aperta all'azione. La famiglia, infatti, è una scuola ideale e insostituibile.
La «buona battaglia» (2 Tm 4,7) per la fede si combatte non soltanto nel segreto della coscienza o nell'intimità della casa, ma anche nella vita pubblica in tutte le sue forme. In tutti i paesi del mondo si pongono oggi problemi di varia natura, le cui soluzioni sono procurate facendo il più spesso appello alle sole risorse umane e obbedendo a principi che non sempre sono d'accordo con le esigenze della fede cristiana. Molti territori di missione, inoltre, stanno attraversando «una fase di evoluzione sociale, economica e politica, che è gravida di conseguenze per il loro avvenire».(47) Problemi che in altre nazioni o sono già stati risolti o trovano nella tradizione elementi di soluzione, si impongono ad altri paesi con un'urgenza che non è scevra da pericoli, in quanto potrebbe consigliare soluzioni affrettate e mutuate con deplorevole leggerezza da dottrine che non tengono in nessun conto o addirittura contraddicono gli interessi religiosi degli individui e dei popoli. I cattolici, per il loro bene privato e per il pubblico bene della chiesa, non possono né ignorare tali problemi, né aspettare che ad essi vengano date pregiudizievoli soluzioni che in avvenire esigerebbero uno sforzo ben più grande di raddrizzamento e rappresenterebbero ulteriori ostacoli all'evangelizzazione del mondo.
Nel campo della pubblica attività i laici dei paesi di missione hanno la loro più diretta e preponderante azione, ed è necessario provvedere con la massima tempestività e urgenza affinché le comunità cristiane offrano alle loro patrie terrene, per il loro comune bene, uomini che onorino le varie professioni e attività nello stesso tempo in cui onorano, con la loro solida vita cristiana, la chiesa che li ha rigenerati alla grazia, in modo che i sacri pastori possano ad essi ripetere la lode che leggiamo negli scritti di san Basilio: «Ho ringraziato Dio santissimo del fatto che, pur essendo occupati nei pubblici affari, voi non avete trascurato quelli della chiesa; al contrario, ognuno di voi se ne è preoccupato come se si trattasse di un affare personale, dal quale dipende la sua propria vita».(48)
In particolare, nel campo dei problemi e dell'organizzazione della scuola, dell'assistenza sociale organizzata, del lavoro, della vita politica, la presenza di esperti cattolici nativi potrà avere la più felice e benefica influenza se essi sapranno, come è loro preciso dovere che non potrebbero trascurare senza accusa di tradimento, ispirare le loro intenzioni e la loro azione ai principi cristiani, che una lunghissima storia dimostra efficienti e decisivi per procurare il bene comune.
A tale scopo, come già esortava il Nostro predecessore Pio XII di v.m., non sarà difficile convincersi della preziosità e dell'importanza dell'aiuto fraterno che le Organizzazioni internazionali cattoliche potranno dare all'apostolato laico nei paesi di missione, sia sul piano scientifico, con lo studio della soluzione cristiana da dare ai problemi specialmente sociali delle nuove nazioni, sia sul piano apostolico, soprattutto, per l'organizzazione del laicato cristiano attivo. Ci è noto ciò che è stato fatto e si va facendo da parte dei laici missionari, che hanno scelto di abbandonare temporaneamente o definitivamente la loro patria per contribuire con molteplici attività al bene sociale e religioso dei paesi di missione, e preghiamo ardentemente il Signore che moltiplichi le schiere di questi generosi e li sorregga nelle difficoltà e nelle fatiche che essi affrontano con spirito apostolico. Gli istituti secolari potranno dare ai bisogni del laicato nativo in terra di missione un aiuto incomparabilmente fecondo, se con il loro esempio susciteranno imitatori e se metteranno a disposizione degli ordinari le loro forze per accelerare il processo di maturità delle giovani comunità.
Il Nostro appello va anche a tutti quei laici cattolici che dovunque emergono nelle professioni e nella vita pubblica, affinché considerino seriamente la possibilità di aiutare i loro nuovi fratelli nella fede, anche senza abbandonare la loro patria. Il loro consiglio, la loro esperienza, la loro assistenza tecnica, potranno, senza eccessiva fatica e senza gravi incomodi, portare un contributo a volte risolutivo. Non mancherà ai buoni lo spirito di iniziativa per tradurre in pratica questo Nostro paterno desiderio, facendolo conoscere là dove potrà essere accolto, incoraggiando le buone disposizioni e facendo trovare ad esse il migliore impiego.
Il Nostro immediato predecessore esortò i vescovi affinché, con spirito di collaborazione fraterna e disinteressata, provvedessero all'assistenza spirituale dei giovani cattolici venuti nelle loro diocesi dai paesi di missione, per compiere gli studi e acquistare esperienze che li metteranno in grado di assumere funzioni direttive nel proprio paese.(49) A quali pericoli intellettuali e morali essi siano esposti in una società che non è la loro e che spesso, purtroppo, non è tale da sostenere la loro fede e incoraggiare la virtù, ognuno di voi, venerabili fratelli, se ne renderà conto, e mosso dalla consapevolezza del dovere missionario che incombe a tutti i sacri pastori, vi provvederà con la più sollecita carità e nei modi più adatti. Non sarà difficile a voi rintracciare questi studenti, affidarli a sacerdoti e laici particolarmente dotati per questo ministero, assisterli spiritualmente, far sentire e sperimentare ad essi la fragranza e le risorse della carità cristiana che ci fa tutti fratelli e premurosi l'uno dell'altro. Ai tanti e così tangibili aiuti che voi date alle missioni, si aggiunge questo che fa più immediatamente presente a voi un mondo geograficamente lontano, ma spiritualmente anche vostro.
A questi studenti, poi, Noi vogliamo dire non soltanto tutto il Nostro amore, ma anche rivolgere un pressante, affettuoso monito a portare dovunque alta la fronte segnata dal sangue di Cristo e dall'unzione del sacro crisma, a profittare del loro soggiorno all'estero non soltanto per la loro formazione professionale, ma anche per l'ampliamento e il perfezionamento della loro formazione religiosa. Essi potranno trovarsi esposti a molti danni, ma si trovano anche nella buona occasione di trarre molti vantaggi spirituali dalla loro dimora nelle nazioni cattoliche, mentre ogni cristiano, chiunque esso sia e in qualsiasi parte della terra sia nato, ha sempre il dovere del buon esempio e della scambievole edificazione spirituale.
V
Dopo avervi intrattenuti, venerabili fratelli, sui bisogni attuali più caratteristici della chiesa nelle terre di missione, non possiamo fare a meno di esprimere la Nostra commossa gratitudine verso tutti coloro che si prodigano per la causa della propagazione della fede fino agli estremi confini del mondo. Ai cari missionari del clero secolare e regolare, alle religiose così esemplarmente generose e così preziose per le varie necessità delle missioni, ai laici missionari prontamente accorsi sulle frontiere della fede, Noi assicuriamo le particolarissime e quotidiane Nostre preghiere e ogni altro aiuto che è in Nostro potere di dare. Il successo della loro opera, visibile anche nella fecondità spirituale delle giovani comunità cristiane, è il segno del gradimento e della benedizione di Dio, e nello stesso tempo attestano la solerzia e la saggezza con cui la Sacra Congregazione «de Propaganda Fide» e la Sacra Congregazione per la chiesa orientale assolvono i delicati compiti loro affidati.
A tutti i vescovi, il clero e i fedeli delle diocesi del mondo intero che contribuiscono con le preghiere e con le offerte ai bisogni spirituali e materiali delle missioni, rivolgiamo l'incitamento a intensificare ancora questa necessaria collaborazione. Nonostante la scarsezza di clero che preoccupa i pastori anche delle più antiche diocesi, non si abbia la minima esitazione a incoraggiare le vocazioni missionarie e privarsi di eccellenti soggetti laici per metterli a disposizione delle nuove diocesi. Di questo sacrificio non si tarderà a raccogliere i frutti soprannaturali. La gara di generosità che vede assiduamente impegnati tutti i fedeli del mondo nelle manifestazioni di zelo e di tangibile carità a vantaggio delle Opere che, alle dipendenze della Sacra Congregazione «de Propaganda Fide», convogliano i soccorsi provenienti da ogni parte verso le destinazioni più utili e urgenti, aumenti di quanto incessantemente crescono i bisogni. La carità sollecita e concreta dei fratelli incoraggerà i fedeli delle giovani comunità e farà ad essi sentire il calore di un affetto soprannaturale che la grazia alimenta nel cuore.
Molte diocesi e comunità cristiane delle terre di missione soffrono patimenti e persecuzioni anche sanguinose; ai sacri pastori che danno ai loro figli spirituali l'esempio di una fede che non si lascia piegare e di una fedeltà che non viene mai meno a prezzo anche del sacrificio della vita; ai fedeli così duramente provati ma così cari al cuore di Gesù Cristo che ha promesso la beatitudine e una ricompensa copiosa a coloro che subiranno persecuzioni a causa della giustizia (Mt 5,10-12), rivolgiamo la Nostra esortazione a perseverare nella loro santa battaglia, poiché il Signore, sempre misericordioso nei suoi disegni imperscrutabili, non farà loro mancare il soccorso delle grazie più preziose e dell'intima consolazione. Coi perseguitati è, in comunione di preghiera e di sofferenze, tutta quanta la chiesa di Dio, sicura nella sua attesa di vittoria.
Invochiamo con tutta l'anima sulle missioni cattoliche la valida assistenza dei loro santi patroni e santi martiri, e in modo specialissimo l'intercessione di Maria santissima, madre amorosa di tutti noi e regina delle missioni. A ciascuno di voi, venerabili fratelli, e a tutti coloro che in qualche maniera collaborano alla crescita del regno di Dio, impartiamo con l'affetto più grande l'apostolica benedizione, che sia conciliatrice e auspice delle grazie del Padre celeste rivelatosi nel Figlio suo, Salvatore del mondo, e che in tutti accenda e moltiplichi lo zelo missionario.
Roma, presso San Pietro, il 28 novembre 1959, anno II del Nostro pontificato.
GIOVANNI PP. XXIII
PER SCARICARE LA LETTERA ENCICLICA "PRINCEPS PASTORUM" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

SERVO DEI SERVI DI DIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA
DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA
CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE
NOSTRA AETATE
Introduzione
1. Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce l'interdipendenza tra i vari popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo dovere di promuovere l'unità e la carità tra gli uomini, ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo esamina qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino.
I vari popoli costituiscono infatti una sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l'intero genere umano su tutta la faccia della terra (1) hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la cui Provvidenza, le cui testimonianze di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti (2) finché gli eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti cammineranno nella sua luce (3).
Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura dell'uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l'origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo.
Le diverse religioni
2. Dai tempi più antichi fino ad oggi presso i vari popoli si trova una certa sensibilità a quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, ed anzi talvolta vi riconosce la Divinità suprema o il Padre. Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano la vita in un intimo senso religioso.
Quanto alle religioni legate al progresso della cultura, esse si sforzano di rispondere alle stesse questioni con nozioni più raffinate e con un linguaggio più elaborato. Così, nell'induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita ascetica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza. Nel buddismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di illuminazione suprema per mezzo dei propri sforzi o con l'aiuto venuto dall'alto. Ugualmente anche le altre religioni che si trovano nel mondo intero si sforzano di superare, in vari modi, l'inquietudine del cuore umano proponendo delle vie, cioè dottrine, precetti di vita e riti sacri.
La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini.
Tuttavia essa annuncia, ed è tenuta ad annunciare, il Cristo che è « via, verità e vita » (Gv 14,6), in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le cose (4).
Essa perciò esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e della collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali e socio-culturali che si trovano in essi.
La religione musulmana
3. La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra (5), che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno.
Se, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il sacro Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà.
La religione ebraica
4. Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.
La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti.
Essa confessa che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede (6), sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell'esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell'Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l'Antica Alleanza, e che essa stessa si nutre dalla radice dell'ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell'ulivo selvatico che sono i gentili (7). La Chiesa crede, infatti, che Cristo, nostra pace, ha riconciliato gli Ebrei e i gentili per mezzo della sua croce e dei due ha fatto una sola cosa in se stesso (8). Inoltre la Chiesa ha sempre davanti agli occhi le parole dell'apostolo Paolo riguardo agli uomini della sua stirpe: « ai quali appartiene l'adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo secondo la carne» (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine.
Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo.
Come attesta la sacra Scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata (9); gli Ebrei in gran parte non hanno accettato il Vangelo, ed anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione (10). Tuttavia secondo l'Apostolo, gli Ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza pentimento (11). Con i profeti e con lo stesso Apostolo, la Chiesa attende il giorno, che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce e « lo serviranno sotto uno stesso giogo » (Sof 3,9) (12).
Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani e ad ebrei, questo sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo.
E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo (13), tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione, non può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo.
E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli Ebrei tuttavia non devono essere presentati come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra Scrittura. Curino pertanto tutti che nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio non si insegni alcunché che non sia conforme alla verità del Vangelo e dello Spirito di Cristo.
La Chiesa inoltre, che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli Ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque. In realtà il Cristo, come la Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in virtù del suo immenso amore, si è volontariamente sottomesso alla sua passione e morte a causa dei peccati di tutti gli uomini e affinché tutti gli uomini conseguano la salvezza. Il dovere della Chiesa, nella sua predicazione, è dunque di annunciare la croce di Cristo come segno dell'amore universale di Dio e come fonte di ogni grazia.
Fraternità universale
5. Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio. L'atteggiamento dell'uomo verso Dio Padre e quello dell'uomo verso gli altri uomini suoi fratelli sono talmente connessi che la Scrittura dice: « Chi non ama, non conosce Dio » (1 Gv 4,8).
Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che introduca tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano.
In conseguenza la Chiesa esecra, come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione tra gli uomini e persecuzione perpetrata per motivi di razza e di colore, di condizione sociale o di religione. E quindi il sacro Concilio, seguendo le tracce dei santi apostoli Pietro e Paolo, ardentemente scongiura i cristiani che, « mantenendo tra le genti una condotta impeccabile » (1 Pt 2,12), se è possibile, per quanto da loro dipende, stiano in pace con tutti gli uomini (14), affinché siano realmente figli del Padre che è nei cieli (15).
Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto, sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto stato così sinodalmente deciso, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.
Roma, presso San Pietro, 28 ottobre 1965.
Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica.
SOSPENSIONE DELLA LEGGE PER I DECRETI PROMULGATI NELLA SESSIONE VII
Il Beatissimo Padre ha stabilito la dilazione della legge, quanto alle nuove leggi che sono contenute nei decreti ora promulgati, fino al 29 giugno 1966, cio fino alla festa dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo dell’anno prossimo.
Nel frattempo il Sommo Pontefice emaner le norme per l’applicazione di dette leggi.
† PERICLES FELICI
Arcivescovo tit. di Samosata
Segretario Generale del SS. Concilio
PER SCARICARE LA DICHIARAZIONE "NOSTRA AETATE" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

SERVO DEI SERVI DI DIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA
DECRETO SULL’ATTIVITA MISSIONARIA DELLA CHIESA
AD GENTES
PROEMIO
1. Inviata per mandato divino alle genti per essere « sacramento universale di salvezza » (1) la Chiesa, rispondendo a un tempo alle esigenze più profonde della sua cattolicità ed all'ordine specifico del suo fondatore (2), si sforza di portare l'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini. Ed infatti gli stessi apostoli, sui quali la Chiesa fu fondata, seguendo l'esempio del Cristo, « predicarono la parola della verità e generarono le Chiese» (3). È pertanto compito dei loro successori perpetuare quest'opera, perché « la parola di Dio corra e sia glorificata » (2 Ts 3,1) ed il regno di Dio sia annunciato e stabilito su tutta quanta la terra.
D'altra parte, nella situazione attuale delle cose, in cui va profilandosi una nuova condizione per l'umanità, la Chiesa, sale della terra e luce del mondo (4), avverte in maniera più urgente la propria vocazione di salvare e di rinnovare ogni creatura, affinché tutto sia restaurato in Cristo e gli uomini costituiscano in lui una sola famiglia ed un solo popolo di Dio.
Pertanto questo santo Sinodo, nel rendere grazie a Dio per il lavoro meraviglioso svolto da tutta la Chiesa con zelo e generosità, desidera esporre i principi dell'attività missionaria e raccogliere le forze di tutti i fedeli, perché il popolo di Dio, attraverso la via stretta della croce possa dovunque diffondere il regno di Cristo Signore che abbraccia i secoli col suo sguardo (5), e preparare la strada alla sua venuta.
CAPITOLO I
PRINCIPI DOTTRINALI
Il piano divino di salvezza
2. La Chiesa durante il suo pellegrinaggio sulla terra è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine (6).
Questo piano scaturisce dall'amore nella sua fonte, cioè dalla carità di Dio Padre. Questi essendo il principio senza principio da cui il Figlio è generato e lo Spirito Santo attraverso il Figlio procede, per la sua immensa e misericordiosa benevolenza liberatrice ci crea ed inoltre per grazia ci chiama a partecipa re alla sua vita e alla sua gloria; egli per pura generosità ha effuso e continua ad effondere la sua divina bontà, in modo che, come di tutti è il creatore, così possa essere anche «tutto in tutti» (1 Cor 15,28), procurando insieme la sua gloria e la nostra felicità. Ma piacque a Dio chiamare gli uomini a questa partecipazione della sua stessa vita non tanto in modo individuale e quasi senza alcun legame gli uni con gli altri, ma di riunirli in un popolo, nel quale i suoi figli dispersi si raccogliessero nell'unità (7)
La missione del Figlio
3. Questo piano universale di Dio per la salvezza del genere umano non si attua soltanto in una maniera per così dire segreta nell'animo degli uomini, o mediante quelle iniziative anche religiose, con cui essi variamente cercano Dio, nello sforzo di raggiungerlo magari a tastoni e di trovarlo, quantunque egli non sia lontano da ciascuno di noi (cfr. At 17,27): tali iniziative infatti devono essere illuminate e raddrizzate, anche se per benigna disposizione della divina Provvidenza possono costituire in qualche caso un avviamento pedagogicamente valido verso il vero Dio o una preparazione al Vangelo (8). Ma Dio, al fine di stabilire la pace, cioè la comunione con sé, e di realizzare tra gli uomini stessi - che sono peccatori - una unione fraterna, decise di entrare in maniera nuova e definitiva nella storia umana, inviando il suo Figlio a noi con un corpo simile al nostro, per sottrarre a suo mezzo gli uomini dal potere delle tenebre e del demonio (9) ed in lui riconciliare a sé il mondo (10) . Colui dunque, per opera del quale aveva creato anche l'universo (11) Dio lo costituì erede di tutte quante le cose, per restaurare tutto in lui (12).
Ed in effetti Cristo Gesù fu inviato nel mondo quale autentico mediatore tra Dio e gli uomini. Poiché è Dio, in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità (Col 2,9); nella natura umana, invece, egli è il nuovo Adamo, è riempito di grazia e di verità (cfr. Gv 1,14) ed è costituito capo dell'umanità nuova. Pertanto il Figlio di Dio ha percorso la via di una reale incarnazione per rendere gli uomini partecipi della natura divina; per noi egli si è fatto povero, pur essendo ricco, per arricchire noi con la sua povertà (13). Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in riscatto dei molti, cioè di tutti (14). I santi Padri affermano costantemente che non fu redento quel che da Cristo non fu assunto (15). Ora egli assunse la natura umana completa, quale essa esiste in noi, infelici e poveri, ma una natura che in lui è senza peccato (16) . Di se stesso infatti il Cristo, dal Padre consacrato ed inviato nel mondo (cfr. Gv 10,36), affermò: « Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha consacrato con la sua unzione, mi ha inviato a portare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il cuore contrito, ad annunziare ai prigionieri la libertà ed a restituire ai ciechi la vista » (Lc 4,18); ed ancora: « Il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare quello che era perduto» (Lc 19,10).
Ora tutto quanto il Signore ha una volta predicato o in lui si è compiuto per la salvezza del genere umano, deve essere annunziato e diffuso fino all'estremità della terra (17), a cominciare da Gerusalemme (18). In tal modo quanto una volta è stato operato per la salvezza di tutti, si realizza compiutamente in tutti nel corso dei secoli.
La missione dello Spirito Santo
4. Per il raggiungimento di questo scopo, Cristo inviò da parte del Padre lo Spirito Santo, perché compisse dal di dentro la sua opera di salvezza e stimolasse la Chiesa a estendersi. Indubbiamente lo Spirito Santo operava nel mondo prima ancora che Cristo fosse glorificato (19). Ma fu nel giorno della Pentecoste che esso si effuse sui discepoli, per rimanere con loro in eterno (20); la Chiesa apparve ufficialmente di fronte alla moltitudine ed ebbe inizio attraverso la predicazione la diffusione del Vangelo in mezzo ai pagani; infine fu prefigurata l'unione dei popoli nell'universalità della fede attraverso la Chiesa della Nuova Alleanza, che in tutte le lingue si esprime e tutte le lingue nell'amore intende e abbraccia, vincendo così la dispersione babelica (21). Fu dalla Pentecoste infatti che cominciarono gli « atti degli apostoli », allo stesso modo che per l'opera dello Spirito Santo nella vergine Maria Cristo era stato concepito, e per la discesa ancora dello Spirito Santo sul Cristo che pregava questi era stato spinto a cominciare il suo ministero (22). E lo stesso Signore Gesù, prima di immolare in assoluta libertà la sua vita per il mondo, organizzò il ministero apostolico e promise l'invio dello Spirito Santo, in modo che entrambi collaborassero, sempre e dovunque, nella realizzazione dell'opera della salvezza (23). Ed è ancora lo Spirito Santo che in tutti i tempi « unifica la Chiesa tutta intera nella comunione e nel ministero e la fornisce dei diversi doni gerarchici e carismatici» (24) vivificando - come loro anima - le istituzioni ecclesiastiche (25) ed infondendo nel cuore dei fedeli quello spirito missionario da cui era stato spinto Gesù stesso. Talvolta anzi previene visibilmente l'azione apostolica (26), come incessantemente, sebbene in varia maniera, l'accompagna e la dirige (27).
La missione della Chiesa
5. Il Signore Gesù, fin dall'inizio « chiamò presso di sé quelli che voleva e ne costituì dodici che stessero con lui e li mandò a predicare» (Mc 3,13; cfr. Mt 10,1-42) (28). Gli apostoli furono dunque ad un tempo il seme del nuovo Israele e l'origine della sacra gerarchia. In seguito, una volta completati in se stesso con la sua morte e risurrezione i misteri della nostra salvezza e dell'universale restaurazione, il Signore, a cui competeva ogni potere in cielo ed in terra (29), prima di salire al cielo (30), fondò la sua Chiesa come sacramento di salvezza ed inviò i suoi apostoli nel mondo intero, come egli a sua volta era stato inviato dal Padre (31) e comandò loro: «Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato» (Mt 28,19-20); «Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo; chi invece non crederà, sarà condannato » (Mc 16,15). Da qui deriva alla Chiesa l'impegno di diffondere la fede e la salvezza del Cristo, sia in forza dell'esplicito mandato che l'ordine episcopale, coadiuvato dai sacerdoti ed unito al successore di Pietro, supremo pastore della Chiesa, ha ereditato dagli apostoli, sia in forza di quell'influsso vitale che Cristo comunica alle sue membra: « Da lui infatti tutto quanto il corpo, connesso e compaginato per ogni congiuntura e legame, secondo l'attività propria di ciascuno dei suoi organi cresce e si autocostruisce nella carità» (Ef 4,16).
Pertanto la missione della Chiesa si esplica attraverso un'azione tale, per cui essa, in adesione all'ordine di Cristo e sotto l'influsso della grazia e della carità dello Spirito Santo, si fa pienamente ed attualmente presente a tutti gli uomini e popoli, per condurli con l'esempio della vita, con la predicazione, con i sacramenti e con i mezzi della grazia, alla fede, alla libertà ed alla pace di Cristo, rendendo loro facile e sicura la possibilità di partecipare pienamente al mistero di Cristo.
Questa missione continua, sviluppando nel corso della storia la missione del Cristo, inviato appunto a portare la buona novella ai poveri; per questo è necessario che la Chiesa, sempre sotto l'influsso dello Spirito di Cristo, segua la stessa strada seguita da questi, la strada cioè della povertà, dell'obbedienza, del servizio e del sacrificio di se stesso fino alla morte, da cui poi, risorgendo, egli uscì vincitore. Proprio con questa speranza procedettero tutti gli apostoli, che con le loro molteplici tribolazioni e sofferenze completarono quanto mancava ai patimenti di Cristo a vantaggio del suo corpo, la Chiesa (32). E spesso anche il sangue dei cristiani fu seme fecondo (33).
L'attività missionaria della Chiesa
6. Questo compito, che l'ordine episcopale, a capo del quale si trova il successore di Pietro, deve realizzare con la collaborazione e la preghiera di tutta la Chiesa, è uno ed immutabile in ogni luogo ed in ogni situazione, anche se in base al variare delle circostanze non si esplica allo stesso modo. Le differenze quindi, che pur vanno tenute presenti in questa attività della Chiesa, non nascono dalla natura intrinseca della sua missione, ma solo dalle circostanze in cui la missione stessa si esplica.
Tali condizioni dipendono sia dalla Chiesa, sia dai popoli, dai gruppi umani o dagli uomini, a cui la missione è indirizzata. Difatti la Chiesa, pur possedendo in forma piena e totale i mezzi atti alla salvezza, né sempre né subito agisce o può agire in maniera completa: nella sua azione, tendente alla realizzazione del piano divino, essa conosce inizi e gradi; anzi talvolta, dopo inizi felici, deve registrare dolorosamente un regresso, o almeno si viene a trovare in uno stadio di inadeguatezza e di insufficienza. Per quanto riguarda poi gli uomini, i gruppi e i popoli, solo gradatamente essa può raggiungerli e conquistarli, assumendoli così nella pienezza cattolica. A qualsiasi condizione o stato devono poi corrispondere atti appropriati e strumenti adeguati.
Le iniziative principali con cui i divulgatori del Vangelo, andando nel mondo intero, svolgono il compito di predicarlo e di fondare la Chiesa in mezzo ai popoli ed ai gruppi umani che ancora non credono in Cristo, sono chiamate comunemente « missioni »: esse si realizzano appunto con l'attività missionaria e si svolgono per lo più in determinati territori riconosciuti dalla santa Sede. Fine specifico di questa attività missionaria è la evangelizzazione e la fondazione della Chiesa in seno a quei popoli e gruppi umani in cui ancora non è radicata (34). Così è necessario che dal seme della parola di Dio si sviluppino Chiese particolari autoctone, fondate dovunque nel mondo in numero sufficiente. Chiese che, ricche di forze proprie e di una propria maturità e fornite adeguatamente di una gerarchia propria, unita al popolo fedele, nonché di mezzi consoni al loro genio per viver bene la vita cristiana, portino il loro contributo a vantaggio di tutta quanta la Chiesa. Il mezzo principale per questa fondazione è la predicazione del Vangelo di Gesù Cristo, per il cui annunzio il Signore inviò nel mondo intero i suoi discepoli, affinché gli uomini, rinati mediante la parola di Dio (35), siano con il battesimo aggregati alla Chiesa, la quale, in quanto corpo del Verbo incarnato, riceve nutrimento e vita dalla parola di Dio e dal pane eucaristico (36).
In questa attività missionaria della Chiesa si verificano a volte condizioni diverse e mescolate le une alle altre: prima c'è l'inizio o la fondazione, poi il nuovo sviluppo o periodo giovanile. Ma, anche terminate queste fasi, non cessa l'azione missionaria della Chiesa: tocca anzi alle Chiese particolari già organizzate continuarla, predicando il Vangelo a tutti quelli che sono ancora al di fuori.
Inoltre i gruppi umani in mezzo ai quali si trova la Chiesa spesso per varie ragioni cambiano radicalmente, donde possono scaturire situazioni del tutto nuove. In questo caso la Chiesa deve valutare se esse sono tali da richiedere di nuovo la sua azione missionaria. Ed ancora, si danno a volte delle circostanze che, almeno temporaneamente, rendono impossibile l'annunzio diretto ed immediato del messaggio evangelico. In questo caso i missionari possono e debbono con pazienza e prudenza, e nello stesso tempo con grande fiducia, offrire almeno la testimonianza della carità e della bontà di Cristo, preparando così le vie del Signore e rendendolo in qualche modo presente.
È evidente quindi che l'attività missionaria scaturisce direttamente dalla natura stessa della Chiesa essa ne diffonde la fede salvatrice, ne realizza l'unità cattolica diffondendola, si regge sulla sua apostolicità, mette in opera il senso collegiale della sua gerarchia, testimonia infine, diffonde e promuove la sua santità. Così l'attività missionaria tra i pagani differisce sia dalla attività pastorale che viene svolta in mezzo ai fedeli, sia dalle iniziative da prendere per ristabilire l'unità dei cristiani. Tuttavia queste due forme di attività si ricongiungono saldamente con l'attività missionaria della Chiesa (37) la divisione dei cristiani è infatti di grave pregiudizio alla santa causa della predicazione del Vangelo a tutti gli uomini (38) ed impedisce a molti di abbracciare la fede. Così la necessità della missione chiama tutti i battezzati a radunarsi in un solo gregge ed a rendere testimonianza in modo unanime a Cristo, loro Signore, di fronte alle nazioni. Essi, se ancora non possono testimoniare pienamente l'unità di fede, debbono almeno essere animati da reciproca stima e amore.
Ragioni dell'attività missionaria
7. La ragione dell'attività missionaria discende dalla volontà di Dio, il quale « vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio, ed un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo anche lui, che ha dato se stesso in riscatto per tutti» (1 Tm 2,4-6), «e non esiste in nessun altro salvezza» (At 4,12). È dunque necessario che tutti si convertano al Cristo conosciuto attraverso la predicazione della Chiesa, ed a lui e alla Chiesa, suo corpo, siano incorporati attraverso il battesimo (39). Cristo stesso infatti, « ribadendo espressamente la necessità della fede e del battesimo (cfr. Mc 16,16; Gv 3,5), ha confermato simultaneamente la necessità della Chiesa, nella quale gli uomini entrano, per così dire, attraverso la porta del battesimo. Per questo non possono salvarsi quegli uomini i quali, pur sapendo che la Chiesa cattolica è stata stabilita da Dio per mezzo di Gesù Cristo come istituzione necessaria, tuttavia rifiutano o di entrare o di rimanere in essa » (40). Benché quindi Dio, attraverso vie che lui solo conosce, possa portare gli uomini che senza loro colpa ignorano il Vangelo a quella fede « senza la quale è impossibile piacergli» (41), è tuttavia compito imprescindibile della Chiesa (42), ed insieme suo sacrosanto diritto, diffondere il Vangelo; di conseguenza l'attività missionaria conserva in pieno - oggi come sempre - la sua validità e necessità.
Grazie ad essa il corpo mistico di Cristo raccoglie e dirige ininterrottamente le sue forze per promuovere il proprio sviluppo (43). A svolgere questa attività le membra della Chiesa sono sollecitate da quella carità con cui amano Dio e con cui desiderano condividere con tutti gli uomini i beni spirituali della vita presente e della vita futura.
Grazie a questa attività missionaria, infine, Dio è pienamente glorificato, nel senso che gli uomini accolgono in forma consapevole e completa la sua opera salvatrice, che egli ha compiuto nel Cristo. Sempre grazie ad essa si realizza il piano di Dio, a cui Cristo in spirito di obbedienza e di amore si consacrò per la gloria del Padre che l'aveva mandato (44) che tutto il genere umano costituisca un solo popolo di Dio, si riunisca nell'unico corpo di Cristo, sia edificato in un solo tempio dello Spirito Santo; tutto ciò, mentre favorisce la concordia fraterna, risponde all'intimo desiderio di tutti gli uomini. Così finalmente si compie davvero il disegno del Creatore, che creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, quando tutti quelli che sono partecipi della natura umana, rigenerati in Cristo per mezzo dello Spirito Santo, riflettendo insieme la gloria di Dio, potranno dire: « Padre nostro » (45).
L'attività missionaria nella vita e nella storia
8. L'attività missionaria è anche intimamente congiunta con la natura umana e con le sue aspirazioni. Difatti la Chiesa, per il fatto stesso che annuncia loro il Cristo, rivela agli uomini in maniera genuina la verità intorno alla loro condizione e alla loro vocazione integrale, poiché è Cristo il principio e il modello dell'umanità nuova, cioè di quell'umanità permeata di amore fraterno, di sincerità, di spirito di pace, che tutti vivamente desiderano. Cristo e la Chiesa, che a lui con la sua predicazione evangelica rende testimonianza, superano i particolarismi di razza e di nazionalità, sicché a nessuno e in nessun luogo possono apparire estranei (46). Il Cristo è la verità e la via, che la predicazione evangelica a tutti svela, facendo loro intendere le parole da lui stesso pronunciate: «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15). E poiché chi non crede è già condannato (47), è evidente che le parole di Cristo sono insieme parole di condanna e di grazia, di morte e di vita. Soltanto facendo morire ciò che è vecchio possiamo pervenire al rinnovamento della vita: e questo vale anzitutto per le persone, ma vale anche per i vari beni di questo mondo, contrassegnati insieme dal peccato dell'uomo e dalla benedizione di Dio: «tutti infatti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio» (Rm 3,23). Ora nessuno di per se stesso e con le sue forze riesce a liberarsi dal peccato e ad elevarsi in alto, nessuno è in grado di affrancarsi dalla sua debolezza, dalla sua solitudine o dalla sua schiavitù (48) tutti han bisogno del Cristo come di un esempio, di un maestro, di un liberatore, di un salvatore, come di colui che dona la vita. Ed effettivamente nella storia umana, anche dal punto di vista temporale, il Vangelo ha sempre rappresentato un fermento di libertà e di progresso, e si presenta sempre come fermento di fraternità, di umiltà e di pace. Ben a ragione, dunque, Cristo viene esaltato dai fedeli come «l'atteso delle genti ed il loro salvatore » (49).
Carattere escatologico dell'attività missionaria
9. Pertanto, il periodo dell'attività missionaria si colloca tra la prima e la seconda venuta di Cristo, in cui la Chiesa, qual messe, sarà raccolta dai quattro venti nel regno di Dio (50). Prima appunto della venuta del Signore, il Vangelo deve essere annunziato a tutte le nazioni (51).
L'attività missionaria non è altro che la manifestazione, cioè l'epifania e la realizzazione, del piano divino nel mondo e nella storia: con essa Dio conduce chiaramente a termine la storia della salvezza. Con la parola della predicazione e con la celebrazione dei sacramenti, di cui è centro e vertice la santa eucaristia, essa rende presente il Cristo, autore della salvezza. Purifica dalle scorie del male ogni elemento di verità e di grazia presente e riscontrabile in mezzo ai pagani per una segreta presenza di Dio e lo restituisce al suo autore, cioè a Cristo, che distrugge il regno del demonio e arresta la multiforme malizia del peccato. Perciò ogni elemento di bene presente e riscontrabile nel cuore e nell'anima umana o negli usi e civiltà particolari dei popoli, non solo non va perduto, ma viene sanato, elevato e perfezionato per la gloria di Dio, la confusione del demonio e la felicità dell'uomo (52). Così l'attività missionaria tende alla sua pienezza escatologica (53) grazie ad essa, infatti, secondo il modo e il tempo che il Padre ha riservato al suo potere (54), si estende il popolo di Dio, in vista del quale è stato detto in maniera profetica: «Allarga lo spazio della tua tenda, distendi i teli dei tuoi padiglioni! Non accorciare! » (Is 54,2) (55), grazie ad essa cresce il corpo mistico fino alla misura dell'età della pienezza di Cristo (56); grazie ad essa il tempio spirituale, in cui si adora Dio in spirito e verità (57), si amplia e si edifica sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, mentre ne è pietra angolare lo stesso Cristo Gesù (cfr. Ef 2,20).
CAPITOLO II
L'OPERA MISSIONARIA IN SE STESSA
Introduzione
10. La Chiesa, che da Cristo è stata inviata a rivelare ed a comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini ed a tutti i popoli, comprende che le resta ancora da svolgere un'opera missionaria ingente. Ben due miliardi di uomini infatti - ed il loro numero cresce di giorno in giorno - uniti in grandi raggruppamenti e determinati da vincoli culturali stabili, da tradizioni religiose antiche o da salde relazioni sociali, o non hanno ancora o hanno appena ascoltato il messaggio evangelico. Di essi alcuni seguono una delle grandi religioni, altri restano ancora estranei all'idea stessa di Dio, altri ne negano dichiaratamente l'esistenza, anzi talvolta l'avversano. La Chiesa quindi, per essere in grado di offrire a tutti il mistero della salvezza e la vita che Dio ha portato all'uomo, deve cercare di inserirsi in tutti questi raggruppamenti con lo stesso movimento con cui Cristo stesso, attraverso la sua incarnazione, si legò a quel certo ambiente socio-culturale degli uomini in mezzo ai quali visse.
Art. 1 - La testimonianza cristiana
Testimonianza di vita e dialogo
11. È necessario che la Chiesa sia presente in questi raggruppamenti umani attraverso i suo}figli, che vivono in mezzo ad essi o ad essi sono inviati. Tutti i cristiani infatti, dovunque vivano, sono tenuti a manifestare con l'esempio della loro vita e con la testimonianza della loro parola l'uomo nuovo, di cui sono stati rivestiti nel battesimo, e la forza dello Spirito Santo, da cui sono stati rinvigoriti nella cresima; sicché gli altri, vedendone le buone opere, glorifichino Dio Padre (58) e comprendano più pienamente il significato genuino della vita umana e l'universale legame di solidarietà degli uomini tra loro.
Ma perché essi possano dare utilmente questa testimonianza, debbono stringere rapporti di stima e di amore con questi uomini, riconoscersi come membra di quel gruppo umano in mezzo a cui vivono, e prender parte, attraverso il complesso delle relazioni e degli affari dell'umana esistenza, alla vita culturale e sociale. Così debbono conoscere bene le tradizioni nazionali e religiose degli altri, lieti di scoprire e pronti a rispettare quei germi del Verbo che vi si trovano nascosti; debbono seguire attentamente la trasformazione profonda che si verifica in mezzo ai popoli, e sforzarsi perché gli uomini di oggi, troppo presi da interessi scientifici e tecnologici, non perdano il contatto con le realtà divine, ma anzi si aprano ed intensamente anelino a quella verità e carità rivelata da Dio. Come Cristo stesso penetrò nel cuore degli uomini per portarli attraverso un contatto veramente umano alla luce divina, così i suoi discepoli, animati intimamente dallo Spirito di Cristo, debbono conoscere gli uomini in mezzo ai quali vivono ed improntare le relazioni con essi ad un dialogo sincero e comprensivo, affinché questi apprendano quali ricchezze Dio nella sua munificenza ha dato ai popoli; ed insieme devono tentare di illuminare queste ricchezze alla luce del Vangelo, di liberarle e di ricondurle sotto l'autorità di Dio salvatore.
Presenza della carità
12. La presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere animata da quella carità con la quale Dio ci ha amato: egli vuole appunto che anche noi reciprocamente ci amiamo con la stessa carità (59). Ed effettivamente la carità cristiana si estende a tutti, senza discriminazioni razziali, sociali o religiose, senza prospettive di guadagno o di gratitudine. Come Dio ci ha amato con amore disinteressato, così anche i fedeli con la loro carità debbono preoccuparsi dell'uomo, amandolo con lo stesso moto con cui Dio ha cercato l'uomo. Come quindi Cristo percorreva tutte le città e i villaggi, sanando ogni malattia ed infermità come segno dell'avvento del regno di Dio (60), così anche la Chiesa attraverso i suoi figli si unisce a tutti gli uomini di qualsiasi condizione, ma soprattutto ai poveri ed ai sofferenti, prodigandosi volentieri per loro (61). Essa infatti condivide le loro gioie ed i loro dolori, conosce le aspirazioni e i problemi della vita, soffre con essi nell'angoscia della morte. A quanti cercano la pace, essa desidera rispondere con il dialogo fraterno, portando loro la pace e la luce che vengono dal Vangelo.
I fedeli debbono impegnarsi, collaborando con tutti gli altri, alla giusta composizione delle questioni economiche e sociali. Si applichino con particolare cura all'educazione dei fanciulli e dei giovani nei vari ordini di scuole, che vanno considerate non semplicemente come un mezzo privilegiato per la formazione e lo sviluppo della gioventù cristiana, ma insieme come un servizio di primaria importanza per gli uomini e specialmente per le nazioni in via di sviluppo, in ordine all'elevazione della dignità umana ed alla preparazione di condizioni più umane. Portino ancora i cristiani il loro contributo ai tentativi di quei popoli che, lottando contro la fame, l'ignoranza e le malattie, si sforzano per creare migliori condizioni di vita e per stabilire la pace nel mondo. In questa attività ambiscano i fedeli di collaborare intelligentemente alle iniziative promosse dagli istituti privati e pubblici, dai governi, dagli organismi internazionali, dalle varie comunità cristiane e dalle religioni non cristiane.
La Chiesa tuttavia, non desidera affatto intromettersi nel governo della città terrena. Essa non rivendica a se stessa altra sfera di competenza, se non quella di servire gli uomini amorevolmente e fedelmente, con l'aiuto di Dio (62).
I discepoli di Cristo, mantenendosi in stretto contatto con gli uomini nella vita e nell'attività, si ripromettono così di offrir loro un'autentica testimonianza cristiana e di lavorare alla loro salvezza, anche là dove non possono annunciare pienamente il Cristo. Essi infatti non cercano il progresso e la prosperità puramente materiale degli uomini, ma intendono promuovere la loro dignità e la loro unione fraterna, insegnando le verità religiose e morali che Cristo ha illuminato con la sua luce, e così gradualmente aprire una via sempre più perfetta verso il Signore. In tal modo gli uomini vengono aiutati a raggiungere la salvezza attraverso la carità verso Dio e verso il prossimo; comincia allora a risplendere il mistero del Cristo, in cui appare l'uomo nuovo, creato ad immagine di Dio (63), ed in cui si rivela la carità di Dio.
Art. 2 - La predicazione del Vangelo
e la riunione del popolo di Dio
Evangelizzazione e conversione
13. Ovunque Dio apre una porta della parola per parlare del mistero del Cristo (64), ivi a tutti gli uomini (65), con franchezza (66) e con perseveranza deve essere annunziato (67) il Dio vivente e colui che egli ha inviato per la salvezza di tutti, Gesù Cristo (68). Solo così i non cristiani, a cui aprirà il cuore lo Spirito Santo (69), crederanno e liberamente si convertiranno al Signore, e sinceramente aderiranno a colui che, essendo « la via, la verità e la vita» (Gv 14,6), risponde a tutte le attese del loro spirito, anzi le supera infinitamente.
Una tale conversione va certo intesa come un inizio: eppure è sufficiente perché l'uomo avverta che, staccato dal peccato, viene introdotto nel mistero dell'amore di Dio, che lo chiama a stringere nel Cristo una relazione personale con lui. Difatti, sotto l'azione della grazia di Dio, il neo-convertito inizia un itinerario spirituale in cui, trovandosi già per la fede in contatto con il mistero della morte e della risurrezione, passa dall'uomo vecchio all'uomo nuovo che in Cristo trova la sua perfezione (70). Questo passaggio, che implica un progressivo cambiamento di mentalità e di costumi, deve manifestarsi nelle sue conseguenze di ordine sociale e svilupparsi progressivamente nel tempo del catecumenato. E poiché il Signore in cui si crede è segno di contraddizione (71), non di rado chi si è convertito va incontro a rotture e a distacchi, ma anche a gioie, che Dio generosamente concede (72).
La Chiesa proibisce severamente di costringere o di indurre e attirare alcuno con inopportuni raggiri ad abbracciare la fede, allo stesso modo in cui rivendica energicamente il diritto che nessuno con ingiuste vessazioni sia distolto dalla fede stessa (73).
Secondo una prassi antichissima nella Chiesa, i motivi della conversione vanno bene esaminati, e, se è necessario, purificati.
Catecumenato e iniziazione cristiana
14. Coloro che da Dio, tramite la Chiesa, hanno ricevuto il dono della fede in Cristo (74), siano ammessi nel corso di cerimonie liturgiche al catecumenato. Questo, lungi dall'essere una semplice esposizione di verità dogmatiche e di norme morali, costituisce una vera scuola di formazione, debitamente estesa nel tempo, alla vita cristiana, in cui appunto i discepoli vengono in contatto con Cristo, loro maestro. Perciò i catecumeni siano convenientemente iniziati al mistero della salvezza ed alla pratica della morale evangelica, e mediante dei riti sacri, da celebrare successivamente (75), siano introdotti nella vita religiosa, liturgica e caritativa del popolo di Dio.
In seguito, liberati grazie ai sacramenti dell'iniziazione cristiana dal potere delle tenebre (76), morti e sepolti e risorti insieme con il Cristo (77), ricevono lo Spirito di adozione a figli (78) e celebrano il memoriale della morte e della resurrezione del Signore con tutto il popolo di Dio.
È auspicabile una riforma della liturgia del tempo quaresimale e pasquale, perché sia in grado di preparare l'anima dei catecumeni alla celebrazione del mistero pasquale, durante le cui feste essi per mezzo del battesimo rinascono in Cristo.
Questa iniziazione cristiana nel corso del catecumenato non deve essere soltanto opera dei catechisti o dei sacerdoti, ma di tutta la comunità dei fedeli, soprattutto dei padrini, in modo che i catecumeni avvertano immediatamente di appartenere al popolo di Dio. Essendo la vita della Chiesa apostolica, è necessario che essi imparino a cooperare attivamente all'evangelizzazione ed alla edificazione della Chiesa con la testimonianza della vita e con la professione della fede.
Infine, nel nuovo Codice dovrà essere più esattamente definito lo stato giuridico dei catecumeni. Essi infatti sono già uniti alla Chiesa (79), appartengono già alla famiglia del Cristo (80), e non è raro che conducano già una vita ispirata alla fede, alla speranza ed alla carità.
Art. 3 - La formazione della comunità cristiana
La comunità cristiana
15. Lo Spirito Santo, che mediante il seme della parola e la predicazione del Vangelo chiama tutti gli uomini a Cristo e suscita nei loro cuori l'adesione alla fede, allorché rigenera a nuova vita in seno al fonte battesimale i credenti in Cristo, li raccoglie nell'unico popolo di Dio, che è « stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione sacra, popolo di redenti » (81).
Perciò i missionari, come cooperatori di Dio (82), devono dar vita a comunità di fedeli che, seguendo una condotta degna della vocazione alla quale sono state chiamate (83), siano tali da esercitare quella triplice funzione sacerdotale, profetica e regale che Dio ha loro affidata. In questo modo la comunità cristiana diventa segno della presenza divina nel mondo: nel sacrificio eucaristico, infatti, essa passa incessantemente al Padre in unione con il Cristo (84), zelantemente alimentata con la parola di Dio (85) rende testimonianza al Cristo (86) e segue la via della carità, ricca com'è di spirito apostolico (87).
Fin dall'inizio la comunità cristiana deve essere formata in modo che possa provvedere da sola, per quanto è possibile, alle proprie necessità. Un tal gruppo di fedeli, in possesso del patrimonio culturale della nazione cui appartiene, deve mettere profonde radici nel popolo: da esso germoglino famiglie dotate di spirito evangelico (88) e sostenute da scuole appropriate; si costituiscano associazioni e organismi, per mezzo dei quali l'apostolato dei laici sia in grado di permeare di spirito evangelico l'intera società. Risplenda infine la carità tra cattolici appartenenti a diversi riti (89).
Anche lo spirito ecumenico deve essere favorito tra i neofiti, nella chiara convinzione che i fratelli che credono in Cristo sono suoi discepoli, rigenerati nel battesimo e compartecipi di moltissimi tesori del popolo di Dio. Nella misura in cui lo permette la situazione religiosa, va promossa un'azione ecumenica tale che i cattolici, esclusa ogni forma di indifferentismo, di sincretismo e di sconsiderata concorrenza, attraverso una professione di fede - per quanto possibile comune - in Dio ed in Gesù Cristo di fronte ai non credenti, attraverso la cooperazione nel campo tecnico e sociale come in quello religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli separati, secondo le norme del decreto sull'ecumenismo. Collaborino soprattutto per la causa di Cristo, che è il loro comune Signore: sia il suo nome il vincolo che li unisce! Questa collaborazione va stabilita non solo tra persone private, ma anche, secondo il giudizio dell'ordinario del luogo, a livello delle Chiese o comunità ecclesiali, e delle loro opere.
I fedeli, che da tutti i popoli sono riuniti nella Chiesa, «non si distinguono dagli altri uomini né per territorio né per lingua né per istituzioni politiche» (90) perciò debbono vivere per Iddio e per il Cristo secondo le usanze e il comportamento del loro paese: come buoni cittadini essi debbono coltivare un sincero e fattivo amor di patria, evitare ogni forma di razzismo e di nazionalismo esagerato e promuovere l'amore universale tra i popoli.
Grande importanza hanno per il raggiungimento di questi obiettivi, e perciò vanno particolarmente curati, i laici, cioè i fedeli che, incorporati per il battesimo a Cristo, vivono nel mondo. Tocca proprio a loro, penetrati dello Spirito di Cristo, agire come un fermento nelle realtà terrene, animandole dall'interno ed ordinandole in modo che siano sempre secondo il Cristo (91).
Non basta però che il popolo cristiano sia presente ed organizzato nell'ambito di una nazione; non basta che faccia dell'apostolato con l'esempio: esso è costituito ed è presente per annunziare il Cristo con la parola e con l'opera ai propri connazionali non cristiani e per aiutarli ad accoglierlo nella forma più piena.
Inoltre, per la costituzione della Chiesa e lo sviluppo della comunità cristiana, sono necessari vari tipi di ministero, che, suscitati nell'ambito stesso dei fedeli da una aspirazione divina, tutti debbono diligentemente promuovere e rispettare: tra essi sono da annoverare i compiti dei sacerdoti, dei diaconi e dei catechisti, e l'Azione cattolica. Parimenti i religiosi e le religiose, per stabilire e rafforzare il regno di Cristo nelle anime, come anche per estenderlo ulteriormente, svolgono un compito indispensabile sia con la preghiera, sia con l'attività esterna.
Il clero indigeno
16. La Chiesa si rallegra vivamente e ringrazia per il dono inestimabile della vocazione sacerdotale che Dio ha concesso a tanti giovani in mezzo a popoli convertiti di recente al cristianesimo. È indubbio che la Chiesa mette più profonde radici in un gruppo umano qualsiasi, quando le varie comunità di fedeli traggono dai propri membri i ministri della salvezza, che nell'ordine dei vescovi, dei sacerdoti e dei diaconi servono ai loro fratelli, sicché le nuove Chiese acquistano a poco a poco la struttura di diocesi, fornite di clero proprio.
Quanto dunque questo Concilio ha deciso intorno alla vocazione ed alla formazione sacerdotale, deve essere religiosamente osservato dove la Chiesa viene stabilita per la prima volta e nelle giovani Chiese. Soprattutto va tenuto presente quel che è stato affermato a proposito della formazione spirituale e della sua stretta coordinazione con quella dottrinale e pastorale, della vita da condurre secondo l'ideale evangelico senza riguardo all'interesse proprio o familiare, nonché della necessità di approfondire il senso del mistero della Chiesa. Da questi principi i sacerdoti impareranno magnificamente a dedicarsi senza riserve al servizio del corpo di Cristo ed al lavoro evangelico, a restare uniti come cooperatori fedeli al proprio vescovo, ad offrire la propria collaborazione ai confratelli (92).
Per il raggiungimento di questo fine generale, l'intero ciclo di formazione degli alunni deve essere ordinato alla luce del mistero della salvezza come è presentato nella sacra Scrittura. Essi devono scoprire questo mistero del Cristo e della salvezza umana presente nella liturgia e viverlo (93).
Tali esigenze comuni della preparazione sacerdotale, anche di ordine pastorale e pratico, indicate dal Concilio (94), vanno armonizzate con la preoccupazione di adeguarsi al particolare modo di pensare e di agire della propria nazione. Bisogna dunque aprire ed affinare lo spirito degli alunni, perché conoscano bene e possano valutare la cultura del loro paese; nello studio delle discipline filosofiche e teologiche essi debbono scoprire quali rapporti intercorrono tra tradizioni e religione nazionale e la religione cristiana (95). Analogamente, la preparazione al sacerdozio deve tenere presenti le necessità pastorali della regione: gli alunni devono apprendere la storia, la finalità e il metodo dell'azione missionaria della Chiesa, nonché le particolari condizioni sociali, economiche e culturali del proprio popolo. Vanno anche educati allo spirito ecumenico e preparati al dialogo fraterno con i non cristiani (96). Tutto questo suppone che gli studi preparatori al sacerdozio si compiano, per quanto è possibile, mantenendo ciascuno il più stretto contatto con la propria nazione (97). E si abbia anche cura di formare alla esatta amministrazione ecclesiastica, anche in senso economico.
Si devono scegliere inoltre dei sacerdoti capaci, perché dopo un certo periodo di pratica pastorale, perfezionino i loro studi superiori nelle università anche straniere, specie in quelle di Roma, ed in altri istituti scientifici, di modo che, come elementi del clero locale con dottrina ed esperienza congrue possano aiutare efficacemente le nuove Chiese nell'adempimento delle funzioni ecclesiastiche più alte.
Laddove le conferenze episcopali lo riterranno opportuno, si restauri l'ordine diaconale come stato permanente, secondo le disposizioni della costituzione sulla Chiesa (98). È bene infatti che gli uomini, i quali di fatto esercitano il ministero di diacono, o perché come catechisti predicano la parola di Dio, o perché a nome del parroco e del vescovo sono a capo di comunità cristiane lontane, o perché esercitano la carità attraverso opere sociali e caritative, siano fortificati dall'imposizione delle mani, che è trasmessa fin dagli apostoli, e siano più saldamente congiunti all'altare per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato.
Catechisti
17. Degna di lode è anche quella schiera, tanto benemerita dell'opera missionaria tra i pagani, che è costituita dai catechisti, sia uomini che donne. Essi, animati da spirito apostolico e facendo grandi sacrifici, danno un contributo singolare ed insostituibile alla propagazione della fede e della Chiesa.
Nel nostro tempo poi, in cui il clero è insufficiente per l'evangelizzazione di tante moltitudini e per l'esercizio del ministero pastorale, il compito del catechista è della massima importanza. Pertanto è necessario che la loro formazione sia perfezionata e adeguata al progresso culturale, in modo che, come validi cooperatori dell'ordine sacerdotale, possano svolgere nella maniera migliore il loro compito, che si va facendo sempre più vasto e impegnativo. Si devono quindi moltiplicare le scuole diocesane e regionali nelle quali i futuri catechisti apprendano sia la dottrina cattolica - specialmente quella che ha per oggetto la Bibbia e la liturgia -, sia anche il metodo catechetico e la tecnica pastorale, e ricevano un'autentica formazione morale cristiana (99) in uno sforzo costante per coltivare la pietà e la santità della vita . Si tengano inoltre dei convegni o corsi periodici per aggiornare i catechisti nelle discipline e tecniche utili al loro ministero e per alimentare e rinvigorire la loro vita spirituale. Inoltre, a quelli che si dedicano completamente a quest'opera bisogna garantire un decoroso tenore di vita e la sicurezza sociale, corrispondendo loro un giusto compenso (100).
È desiderabile che alla formazione ed al sostentamento dei catechisti si provveda convenientemente con sussidi speciali della sacra Congregazione di Propaganda Fide. Se apparirà necessario ed opportuno, si fondi un'opera per i catechisti.
Le Chiese inoltre devono sentire e dimostrare gratitudine per l'opera generosa dei catechisti ausiliari, il cui aiuto sarà loro indispensabile. Sono essi che nelle loro comunità presiedono alla preghiera ed impartiscono l'insegnamento. Ci si deve debitamente preoccupare anche della loro formazione dottrinale e spirituale. È altresì auspicabile che ai catechisti convenientemente formati sia conferita, riconoscendosene l'opportunità, la missione canonica nella pubblica celebrazione della liturgia, perché siano al servizio della fede con maggiore autorità agli occhi del popolo.
Promozione della vita religiosa
18. La vita religiosa deve essere curata e promossa fin dal periodo iniziale della fondazione della Chiesa, perché essa non solo è fonte di aiuti preziosi e indispensabili per l'attività missionaria, ma attraverso una più intima consacrazione a Dio fatta nella Chiesa manifesta anche chiaramente e fa comprendere l'intima natura della vocazione cristiana (101).
Gli istituti religiosi che lavorano alla fondazione della Chiesa, impregnati dei mistici tesori di cui è ricca la tradizione religiosa ecclesiale, devono sforzarsi di metterli in luce e di trasmetterli secondo il genio e il carattere di ciascuna nazione. E devono anche considerare attentamente in che modo le tradizioni di vita ascetica e contemplativa, i cui germi talvolta Dio ha immesso nelle antiche culture prima della predicazione del Vangelo, possano essere utilizzate per la vita religiosa cristiana.
Nelle giovani Chiese bisogna promuovere la vita religiosa nelle sue varie forme, perché essa mostri i diversi aspetti della missione di Cristo e della vita ecclesiale, si consacri alle varie attività pastorali e prepari i propri membri ad esplicarle come si conviene. I vescovi tuttavia in sede di conferenza episcopale facciano attenzione perché non si moltiplichino, danneggiando la vita religiosa e l'apostolato, le congregazioni aventi identica finalità apostolica.
Meritano speciale considerazione le varie iniziative destinate a stabilire la vita contemplativa. Certi istituti, mantenendo gli elementi essenziali della istituzione monastica, tendono a impiantare la ricchissima tradizione del proprio ordine; altri cercano di ritornare alla semplicità delle forme del monachesimo primitivo. Tutti comunque devono cercare un reale adattamento alle condizioni locali. Poiché la vita contemplativa interessa la presenza ecclesiale nella sua forma più piena, è necessario che essa sia costituita dappertutto nelle giovani Chiese.
CAPITOLO III
LE CHIESE PARTICOLARI
Il progresso delle giovani Chiese
19. L'opera di costituzione della Chiesa in un determinato raggruppamento umano raggiunge in certa misura il suo termine, allorché la comunità dei fedeli, inserita ormai profondamente nella vita sociale e in qualche modo modellata sulla cultura locale, gode di una salda stabilità: fornita cioè di una sua schiera, anche se insufficiente, di clero locale, di religiosi e di laici, essa viene arricchendosi di quelle funzioni ed istituzioni che sono necessarie perché il popolo di Dio, sotto la guida di un proprio vescovo, conduca e sviluppi la sua vita.
In queste giovani Chiese appunto la vita del popolo di Dio deve giungere a maturità in tutti i campi della vita cristiana, che deve essere rinnovata secondo le norme di questo Concilio: ed ecco i gruppi di fedeli con crescente consapevolezza si fanno comunità viventi della fede, della liturgia e della carità; i laici, con la loro attività, che è a un tempo civica ed apostolica, si sforzano di instaurare nella città terrena un ordine di giustizia e di carità; l'uso dei mezzi di comunicazione sociale è ispirato a criteri di opportunità e prudenza; le famiglie, praticando la vera vita cristiana, diventano fonte dell'apostolato dei laici e vivaio di vocazioni sacerdotali e religiose. La fede infine è oggetto di insegnamento catechistico appropriato, trova la sua espressione in una liturgia rispondente all'indole del popolo, e viene introdotta, grazie ad un'adeguata legislazione canonica, nelle sane istituzioni umane e nelle consuetudini locali.
I vescovi poi, ciascuno con il proprio presbiterio, approfondendo sempre meglio in se stessi il senso di Cristo e della Chiesa, devono essere in unità di pensieri e di vita con la Chiesa universale. Ed intima resti la comunione delle giovani Chiese con tutta quanta la Chiesa, la cui tradizione esse devono saper collegare in tutti i suoi elementi con la propria cultura, sicché ne risulti, come per uno scambio reciproco di energie, una crescita nella vita del corpo mistico (102). Siano pertanto curati quegli elementi teologici, psicologici ed umani che si rivelano atti ed efficaci per lo sviluppo di questo senso di comunione con la Chiesa universale.
Queste stesse Chiese, che si trovano quasi sempre nelle regioni economicamente depresse del mondo, soffrono per lo più per grave scarsezza di sacerdoti e per mancanza di mezzi materiali. È quindi assolutamente indispensabile che l'azione missionaria continua di tutta la Chiesa fornisca loro quegli aiuti che servano soprattutto allo sviluppo della Chiesa locale e alla maturità della vita cristiana. Questa azione missionaria deve estendere il soccorso anche a quelle Chiese che, pur esistendo da antica data, si trovano, per così dire, in fase di regresso o in uno stato di debolezza.
Tuttavia queste Chiese devono organizzare il lavoro pastorale comune creando opere adatte perché le vocazioni che interessano il clero diocesano o gli istituti religiosi crescano di numero, vengano vagliate con maggiore sicurezza e coltivate con migliore riuscita (103) così, a poco a poco, saranno in grado di provvedere a se stesse e di portare aiuto alle altre.
L'attività missionaria delle Chiese particolari
20. La Chiesa particolare, dovendo riprodurre il più perfettamente possibile la Chiesa universale, abbia la piena coscienza di essere inviata anche a coloro che non credono in Cristo e vivono nel suo stesso territorio, al fine di costituire, con la testimonianza di vita dei singoli fedeli e della comunità tutta, il segno che addita loro il Cristo (104).
È inoltre necessario il ministero della parola, perché il messaggio evangelico giunga a tutti. Il vescovo deve essere essenzialmente il messaggero di fede che porta nuovi discepoli a Cristo. Per rispondere bene a questo nobilissimo compito deve conoscere a fondo sia le condizioni del suo gregge, sia la concezione che di Dio hanno i suoi concittadini, tenendo conto esattamente anche dei mutamenti introdotti dalla cosiddetta urbanizzazione, dal fenomeno della emigrazione e dall'indifferentismo religioso.
I sacerdoti locali attendano con molto zelo all'opera di evangelizzazione nelle giovani Chiese, collaborando attivamente con i missionari di origine straniera, con i quali costituiscono un unico corpo sacerdotale riunito sotto l'autorità del vescovo: ciò non solo per pascere i propri fedeli e per celebrare il culto divino, ma anche per predicare il Vangelo a coloro che stanno fuori. Perciò dimostrino prontezza e, all'occasione, si offrano generosamente al proprio vescovo per iniziare l'attività missionaria nelle zone più lontane ed abbandonate della propria diocesi o anche di altre diocesi.
Dello stesso zelo siano animati i religiosi e le religiose, ed anche i laici verso i propri concittadini, specie quelli più poveri.
Le conferenze episcopali procurino che periodicamente si tengano corsi di aggiornamento biblico, teologico, spirituale e pastorale, allo scopo di consentire al clero, di fronte al variare incessante delle situazioni, di approfondire la conoscenza della teologia e dei metodi pastorali.
Quanto al resto, si osservino religiosamente tutte le disposizioni che questo Concilio ha emanato, specialmente quelle del decreto relativo al ministero ed alla vita sacerdotale.
Una Chiesa particolare, per poter realizzare la propria opera missionaria, ha bisogno di ministri adatti, che vanno preparati tempestivamente in maniera rispondente alle condizioni di ciascuna di esse. E poiché gli uomini tendono sempre più a riunirsi in gruppi, è sommamente conveniente che le conferenze episcopali concordino una comune linea di azione, in ordine al dialogo da stabilire con tali gruppi. Se però in certe regioni esistono dei gruppi di uomini, che sono distolti dall'abbracciare la fede cattolica dall'incapacità di adattarsi a quella forma particolare che la Chiesa ha assunto in mezzo a loro, è senz'altro desiderabile che si provveda ad una tale situazione con misure particolari (105) finché non si arrivi a riunire tutti i cristiani in un'unica comunità. Se poi la santa Sede dispone di missionari preparati a questo scopo, pensino i singoli vescovi a chiamarli nelle proprie diocesi o li accolgano ben volentieri, favorendo efficacemente le loro iniziative.
Perché questo zelo missionario fiorisca nei membri della loro patria, è altresì conveniente che le giovani Chiese partecipino quanto prima effettivamente alla missione universale della Chiesa, inviando anch'esse dei missionari a predicare il Vangelo dappertutto nel mondo, anche se soffrono di scarsezza di clero. La comunione con la Chiesa universale raggiungerà in un certo senso la sua perfezione solo quando anch'esse prenderanno parte attiva allo sforzo missionario diretto verso le altre nazioni.
L'apostolato dei laici
21. La Chiesa non si può considerare realmente fondata, non vive in maniera piena, non è segno perfetto della presenza di Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si affianca e collabora un laicato autentico. Non può infatti il Vangelo penetrare ben addentro nella mentalità, nel costume, nell'attività di un popolo, se manca la presenza dinamica dei laici. Perciò, fin dal periodo di fondazione di una Chiesa, bisogna dedicare ogni cura alla formazione di un maturo laicato cristiano.
La ragione è che i fedeli laici appartengono insieme al popolo di Dio e alla società civile. Appartengono anzitutto alla propria nazione, perché vi son nati, perché con la educazione han cominciato a partecipare al suo patrimonio culturale, perché alla sua vita si rannodano nella trama multiforme delle relazioni sociali, perché al suo sviluppo cooperano e danno un personale contributo con la loro professione, perché i suoi problemi essi sentono come loro problemi e come tali si sforzano di risolverli. Ma essi appartengono anche a Cristo, in quanto nella Chiesa sono stati rigenerati attraverso la fede e il battesimo, affinché, rinnovati nella vita e nell'opera, siano di Cristo (106), ed in Cristo tutto a Dio sia sottoposto, e finalmente Dio sia tutto in tutti (107).
Principale loro compito, siano essi uomini o donne, è la testimonianza a Cristo, che devono rendere, con la vita e con la parola, nella famiglia, nel gruppo sociale cui appartengono e nell'ambito della professione che esercitano. In essi deve realmente apparire l'uomo nuovo, che è stato creato secondo Dio in giustizia e santità della verità (108). Questa vita nuova debbono esprimerla nell'ambito della società e della cultura della propria patria, e nel rispetto delle tradizioni nazionali. Debbono perciò conoscere questa cultura, purificarla, conservarla e svilupparla in armonia con le nuove condizioni, e infine perfezionarla in Cristo, affinché la fede di Cristo e la vita della Chiesa non siano già elementi estranei alla società in cui vivono, ma comincino a penetrarla ed a trasformarla. I laici si sentano uniti ai loro concittadini da sincero amore, rivelando con il loro comportamento quel vincolo assolutamente nuovo di unità e di solidarietà universale, che attingono dal mistero del Cristo. Diffondano anche la fede di Cristo tra coloro a cui li legano vincoli sociali e professionali: questo obbligo è reso più urgente dal fatto che moltissimi uomini non possono né ascoltare il Vangelo né conoscere Cristo se non per mezzo di laici che siano loro vicini. Anzi, laddove è possibile, i laici siano pronti a cooperare ancora più direttamente con la gerarchia, svolgendo missioni speciali per annunziare il Vangelo e divulgare l'insegnamento cristiano: daranno così vigore alla Chiesa che nasce.
I ministri della Chiesa da parte loro abbiano grande stima dell'attività apostolica dei laici: li educhino a quel senso di responsabilità che li impegna, in quanto membra di Cristo, dinanzi a tutti gli uomini; diano loro una conoscenza approfondita del mistero del Cristo, insegnino loro i metodi di azione pastorale e li aiutino nelle difficoltà, secondo lo spirito della costituzione Lumen gentium e del decreto Apostolicam actuositatem.
Nel pieno rispetto dunque delle funzioni e responsabilità specifiche dei pastori e dei laici, la giovane Chiesa tutta intera renda a Cristo una testimonianza unanime, viva e ferma, divenendo così segno luminoso di quella salvezza che a noi è venuta nel Cristo.
Tradizioni particolari nell'unità ecclesiale
22. Il seme, cioè la parola di Dio, germogliando nel buon terreno irrigato dalla rugiada divina, assorbe la linfa vitale, la trasforma e l'assimila per produrre finalmente un frutto abbondante. Indubbiamente, come si verifica nell'economia dell'incarnazione, le giovani Chiese, che han messo radici in Cristo e son costruite sopra il fondamento degli apostoli, hanno la capacità meravigliosa di assorbire tutte le ricchezze delle nazioni, che appunto a Cristo sono state assegnate in eredità (109). Esse traggono dalle consuetudini e dalle tradizioni, dal sapere e dalla cultura, dalle arti e dalle scienze dei loro popoli tutti gli elementi che valgono a render gloria al Creatore, a mettere in luce la grazia del Salvatore e a ben organizzare la vita cristiana (110).
Per raggiungere questo scopo è necessario che, nell'ambito di ogni vasto territorio socio-culturale, come comunemente si dice, venga promossa una ricerca teologica di tal natura per cui, alla luce della tradizione della Chiesa universale, siano riesaminati fatti e parole oggetto della Rivelazione divina, consegnati nella sacra Scrittura e spiegati dai Padri e dal magistero ecclesiatico. Si comprenderà meglio allora secondo quali criteri la fede, tenendo conto della filosofia e del sapere, può incontrarsi con la ragione, ed in quali modi le consuetudini, la concezione della vita e la struttura sociale possono essere conciliati con il costume espresso nella Rivelazione divina. Ne risulteranno quindi chiari i criteri da seguire per un più accurato adattamento della vita cristiana nel suo complesso. Così facendo sarà esclusa ogni forma di sincretismo e di particolarismo fittizio, la vita cristiana sarà commisurata al genio e al carattere di ciascuna cultura (111), e le tradizioni particolari insieme con le qualità specifiche di ciascuna comunità nazionale, illuminate dalla luce del Vangelo, saranno assorbite nell'unità cattolica. Infine le nuove Chiese particolari, conservando tutta la bellezza delle loro tradizioni, avranno il proprio posto nella comunione ecclesiale, lasciando intatto il primato della cattedra di Pietro, che presiede all'assemblea universale della carità (112).
È dunque desiderabile, per non dire sommamente conveniente, che le conferenze episcopali si riuniscano insieme nell'ambito di ogni vasto territorio socio-culturale, per poter realizzare, in piena armonia tra loro ed in uniformità di decisioni, questo piano di adattamento.
CAPITOLO IV
I MISSIONARI
La vocazione missionaria
23. Benché l'impegno di diffondere la fede ricada su qualsiasi discepolo di Cristo in proporzione alle sue possibilità (113) Cristo Signore chiama sempre dalla moltitudine dei suoi discepoli quelli che egli vuole, per averli con sé e per inviarli a predicare alle genti (114). Perciò egli, per mezzo dello Spirito Santo, che distribuisce come vuole i suoi carismi per il bene delle anime (115), accende nel cuore dei singoli la vocazione missionaria e nello stesso tempo suscita in seno alla Chiesa quelle istituzioni (116) che si assumono come dovere specifico il compito della evangelizzazione che appartiene a tutta quanta la Chiesa.
Difatti sono insigniti di una vocazione speciale coloro che, forniti di naturale attitudine e capaci per qualità ed ingegno, si sentono pronti a intraprendere l'attività missionaria (117), siano essi autoctoni o stranieri: sacerdoti, religiosi e laici. Essi, inviati dalla legittima autorità, si portano per spirito di fede e di obbedienza presso coloro che sono lontani da Cristo, riservandosi esclusivamente per quell'opera per la quale, come ministri del Vangelo, sono stati scelti (118), « affinché l'offerta dei pagani sia ben accolta e santificata per lo Spirito Santo » (Rm 15,16) .
Spiritualità missionaria
24. Orbene, alla chiamata di Dio l'uomo deve rispondere in maniera tale da vincolarsi del tutto all'opera evangelica, « senza prender consiglio dalla carne e dal sangue » (119). Ed è impossibile dare una risposta a questa chiamata senza l'ispirazione e la forza dello Spirito Santo. Il missionario diventa infatti partecipe della vita e della missione di colui che «annientò se stesso, prendendo la natura di schiavo » (Fil 2,7); deve quindi esser pronto a mantenersi fedele per tutta la vita alla sua vocazione, a rinunciare a se stesso e a tutto quello che in precedenza possedeva in proprio, ed a « farsi tutto a tutti» (120).
Annunziando il Vangelo ai pagani, deve far conoscere con fiducia il mistero del Cristo, del quale è ambasciatore: è in suo nome che deve avere il coraggio di parlare come è necessario (121), senza arrossire dello scandalo della croce. Seguendo l'esempio del suo Maestro, mite e umile di cuore, deve dimostrare che il suo giogo è soave e il suo peso leggero (122). Vivendo autenticamente il Vangelo (123), con la pazienza, con la longanimità, con la benignità, con la carità sincera (124), egli deve rendere testimonianza al suo Signore fino a spargere, se necessario, il suo sangue per lui. Virtù e fortezza egli chiederà a Dio, per riconoscere che nella lunga prova della tribolazione e della povertà profonda risiede l'abbondanza della gioia (125). E sia ben persuaso che è l'obbedienza la virtù distintiva del ministro di Cristo, il quale appunto con la sua obbedienza riscattò il genere umano.
I messaggeri del Vangelo, per non trascurare la grazia che è in loro, devono rinnovarsi di giorno in giorno interamente nel loro spirito (126). Gli ordinari ed i superiori da parte loro procurino di riunire in determinati periodi i missionari per rinvigorirli nella speranza della loro vocazione e per aggiornare il ministero apostolico, fondando anche delle case a questo scopo.
Formazione spirituale e morale
25. Il futuro missionario deve ricevere una formazione spirituale e morale particolare per prepararsi a questo nobilissimo compito (127). Egli deve essere pronto a prendere iniziative, costante nel portarle a compimento, perseverante nelle difficoltà, paziente e forte nel sopportare la solitudine, la stanchezza, la sterilità nella propria fatica. Andrà incontro agli uomini francamente e con cuore aperto; accoglierà volentieri gli incarichi che gli vengono affidati; saprà adattarsi generosamente alla diversità di costume dei popoli ed al mutare delle situazioni; in piena armonia e con reciproca carità offrirà la sua collaborazione ai confratelli ed a tutti coloro che svolgono il suo stesso lavoro, in modo che tutti, compresi i fedeli, sull'esempio della prima comunità apostolica formino un cuore solo ed un'anima sola (128).
Tali disposizioni interne devono essere diligente mente promosse e coltivate già fin dal tempo della formazione, nonché elevate e nutrite attraverso la vita spirituale.
Il missionario, animato da viva fede e da incrollabile speranza, sia uomo di preghiera; sia ardente per spirito di virtù, di amore e di sobrietà (129); impari ad essere contento delle condizioni in cui si trova (130); porti sempre la morte di Gesù nel suo cuore con spirito di sacrificio, affinché sia la vita di Gesù ad agire nel cuore di coloro a cui viene mandato (131); nel suo zelo per le anime spenda volentieri del suo e spenda anche tutto se stesso per la loro salvezza (132), sicché « nell'esercizio quotidiano del suo dovere cresca nell'amore di Dio e del prossimo » (133). Solo così, unito al Cristo nell'obbedienza alla volontà del Padre, potrà continuare la missione sotto l'autorità gerarchica della Chiesa e collaborare al mistero della salvezza.
Formazione dottrinale e apostolica
26. Coloro che saranno inviati ai vari popoli pagani, se vogliono riuscire buoni ministri del Cristo, «siano nutriti dalle parole della fede e della buona dottrina» (1 Tm 4,6): essi le attingeranno soprattutto dalla sacra Scrittura, approfondendo quel mistero del Cristo di cui saranno poi messaggeri e testimoni.
Perciò tutti i missionari - sacerdoti, religiosi, suore e laici - debbono essere singolarmente preparati e formati, secondo la loro condizione, perché siano all'altezza del compito che dovranno svolgere (134). Fin dall'inizio la loro formazione dottrinale deve essere impostata in modo da non perdere di vista l'universalità della Chiesa e la diversità dei popoli. Ciò vale, sia per le discipline che servono a prepararli direttamente al ministero, sia per le altre scienze che possono loro riuscire utili per una conoscenza generale dei popoli, delle culture e delle religioni, orientata non soltanto verso il passato, ma soprattutto verso il presente. Chiunque infatti sta per recarsi presso un altro popolo, deve stimare molto il patrimonio, le lingue ed i costumi. È dunque indispensabile al futuro missionario attendere agli studi di missionologia, conoscere cioè la dottrina e le norme della Chiesa relative all'attività missionaria, sapere quali strade abbiano seguito nel corso dei secoli i messaggeri del Vangelo, essere al corrente della situazione missionaria attuale e dei metodi che si ritengono al giorno d'oggi più efficaci (135).
Benché questo ciclo integrale di insegnamento debba essere arricchito ed animato da zelo pastorale, bisogna dare tuttavia anche una speciale ed ordinata formazione apostolica, sia con la teoria che con le esercitazioni pratiche (136).
Il maggior numero possibile di religiosi e di suore siano ben istruiti e preparati nell'arte catechistica, onde collaborino sempre più all'apostolato. È necessario che anche coloro, i quali si impegnano solo temporaneamente nell'attività missionaria, acquistino una formazione adeguata alla loro condizione.
Tutti questi tipi di formazione poi vanno completati nei paesi nei quali sono inviati, in maniera che i missionari conoscano a fondo la storia, le strutture sociali e le consuetudini dei vari popoli, approfondiscano l'ordine morale, le norme religiose e le idee più profonde che quelli, in base alle loro tradizioni, hanno già intorno a Dio, al mondo e all'uomo (137). Apprendano le lingue tanto bene da poterle usare con speditezza e proprietà: sarà questo il modo per arrivare più facilmente alla mente ed al cuore di quegli uomini (138). Siano inoltre debitamente preparati di fronte a necessità pastorali di carattere particolare.
Alcuni di essi poi devono ricevere una più accurata preparazione presso gli istituti di missionologia o presso altre facoltà o università, per poter svolgere con maggiore efficacia dei compiti speciali (139) ed aiutare con la loro cultura gli altri missionari nell'esercizio del lavoro missionario, che specialmente ai nostri tempi presenta tante difficoltà ed insieme tante occasioni favorevoli. È inoltre auspicabile che le conferenze episcopali regionali abbiano a disposizione un buon numero di questi esperti, ed utilizzino la loro scienza ed esperienza nelle necessità del loro ministero. Non devono poi mancare gli esperti nell'uso degli strumenti tecnici e della comunicazione sociale, la cui importanza tutti devono apprezzare.
Gli istituti missionari
27. Tutto questo, benché sia indispensabile a chiunque viene inviato alle genti, in realtà molto difficilmente può essere realizzato dai singoli. Appunto perché l'opera missionaria stessa, come conferma l'esperienza, non può essere compiuta dai singoli individui, una vocazione comune li ha riuniti in istituti dove, mettendo insieme le loro forze, possono ricevere una formazione adeguata, per eseguire quell'opera a nome della Chiesa e dietro comando dell'autorità gerarchica. Per molti secoli tali istituti han portato il peso del giorno e del calore, sia che al lavoro missionario si dedicassero totalmente, sia che vi si dedicassero soltanto in parte. Spesso la santa Sede affidò loro dei territori immensi da evangelizzare, nei quali seppero riunire, per il Signore, un nuovo popolo, cioè una Chiesa locale gerarchicamente unita ai propri pastori. A queste Chiese appunto, che han fondato con il loro sudore o piuttosto con il loro sangue, essi presteranno servizio con il proprio zelo e la propria esperienza in una collaborazione fraterna, sia che esercitino la cura delle anime, sia che svolgano funzioni speciali in vista del bene comune.
Talvolta si assumeranno dei compiti più urgenti in tutto l'ambito di una determinata regione: ad esempio, l'evangelizzazione di certe categorie o di popoli che, per ragioni particolari, non hanno forse ricevuto ancora il messaggio evangelico, o ad esso han fatto finora resistenza (140). In caso di necessità, essi devono esser pronti a formare e ad aiutare con la loro esperienza coloro che si consacrano all'attività missionaria solo temporaneamente. Per tutte queste ragioni, ed anche perché molti sono ancora i popoli da condurre a Cristo, questi istituti restano assolutamente necessari.
CAPITOLO V
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ MISSIONARIA
Introduzione
28. I cristiani, avendo carismi differenti (141), devono collaborare alla causa del Vangelo, ciascuno secondo le sue possibilità, i suoi mezzi, il suo carisma e il suo ministero (142). Tutti dunque, coloro che seminano e coloro che mietono (143), coloro che piantano e coloro che irrigano, devono formare una cosa sola (144), affinché « tendendo tutti in maniera libera e ordinata allo stesso scopo» indirizzino in piena unanimità le loro forze all'edificazione della Chiesa. Per tale ragione il lavoro dei messaggeri del Vangelo e l'aiuto degli altri cristiani vanno regolati e collegati in modo che « tutto avvenga in perfetto ordine » (145) in tutti i settori dell'attività e della cooperazione missionaria.
Organizzazione generale
29. Poiché il compito di annunciare dappertutto nel mondo il Vangelo riguarda primariamente il collegio episcopale (146) il sinodo dei vescovi, cioè «la commissione permanente dei vescovi per la Chiesa universale» (147), tra gli affari di importanza generale (148) deve seguire con particolare sollecitudine l'attività missionaria, che è il dovere più alto e più sacro della Chiesa (149).
Per tutte le missioni e per tutta l'attività missionaria uno soltanto deve essere il dicastero competente, ossia quello di « Propaganda Fide », cui spetta di regolare e di coordinare in tutto quanto il mondo, sia l'opera missionaria in se stessa, sia la cooperazione missionaria, nel rispetto tuttavia del diritto delle Chiese orientali (150).
Benché lo Spirito Santo susciti in diverse maniere lo spirito missionario nella Chiesa di Dio, prevenendo sovente l'azione stessa di coloro cui tocca governare la vita della Chiesa, tuttavia questo dicastero da parte sua deve promuovere la vocazione e la spiritualità missionaria, lo zelo e la preghiera per le missioni, e fornire a loro riguardo informazioni autentiche e valide. È suo compito suscitare e distribuire i missionari, secondo i bisogni più urgenti delle regioni. È suo compito elaborare un piano organico di azione, emanare norme direttive e principi adeguati in ordine all'evangelizzazione e dare l'impulso iniziale. È suo compito promuovere e coordinare efficacemente la raccolta dei sussidi, che vanno poi distribuiti tenendo conto della necessità o della utilità, nonché dell'estensione del territorio, del numero dei fedeli e degli infedeli, delle opere e delle istituzioni, dei ministri e dei missionari.
Esso, in collegamento con il segretariato per l'unità dei cristiani, deve ricercare i modi ed i mezzi con cui procurare ed organizzare la collaborazione fraterna e la buona intesa con le iniziative missionarie delle altre comunità cristiane, onde eliminare, per quanto è possibile, lo scandalo della divisione.
È necessario pertanto che questo dicastero costituisca insieme uno strumento di amministrazione ed un organo di direzione dinamica, che faccia uso dei metodi scientifici e dei mezzi adatti alle condizioni del nostro tempo, tenga conto cioè delle ricerche attuali di teologia, di metodologia e di pastorale missionaria.
Nella direzione di questo dicastero devono avere parte attiva, con voto deliberativo, dei rappresentanti scelti tra tutti coloro che collaborano all'attività missionaria: vescovi di tutto il mondo, su parere delle conferenze episcopali, e direttori degli istituti e delle opere pontificie, secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal romano Pontefice. Tutti questi delegati verranno convocati periodicamente e reggeranno, sotto l'autorità del sommo Pontefice, la organizzazione suprema di tutta l'attività missionaria.
Lo stesso dicastero avrà a disposizione una commissione permanente di esperti consultori, veramente insigni per dottrina ed esperienza; tra le altre funzioni, essi avranno quella di raccogliere tutte le notizie utili, sia intorno alle situazioni locali delle varie regioni e alla mentalità propria dei diversi gruppi umani, sia intorno ai metodi di evangelizzazione da adottare, proponendo poi delle conclusioni scientificamente fondate per l'opera e la cooperazione missionaria.
Gli istituti di suore, le opere regionali per le missioni, le organizzazioni dei laici, in specie quelle a carattere internazionale, devono essere debitamente rappresentate.
Organizzazione locale nelle missioni
30. Perché nell'esercizio dell'attività missionaria si raggiungano quei risultati che ne costituiscono la finalità, tutti coloro che lavorano nelle missioni devono avere «un cuore solo ed un'anima sola» (At4,32).
È compito del vescovo, come capo e centro unitario dell'apostolato diocesano, promuovere, dirigere e coordinare l'attività missionaria, in modo tale tuttavia che sia salvaguardata ed incoraggiata nella sua spontaneità l'iniziativa di coloro che all'opera stessa partecipano. Tutti i missionari, anche religiosi esenti, dipendono da lui nelle varie opere che riguardano l'esercizio dell'apostolato sacro (151). Al fine di meglio coordinare le iniziative, il vescovo costituisca, per quanto è possibile, un consiglio pastorale, di cui devono fare parte chierici, religiosi e laici attraverso delegati scelti. Provveda anche a che l'attività apostolica non resti limitata ai soli convertiti, ma che una giusta parte di operai e di sussidi sia destinata all'evangelizzazione dei non cristiani.
Cooperazione stabilita dalle conferenze episcopali
31. Le conferenze episcopali devono trattare in pieno accordo le questioni più gravi e i problemi più urgenti, senza trascurare però le differenze tra luogo e luogo (152) Perché poi non si utilizzino male persone e mezzi, già di per sé insufficienti, perché non si moltiplichino senza vera necessità le iniziative, si raccomanda di fondare, mettendo insieme le forze, delle opere che servano per il bene di tutti, quali ad esempio i seminari, le scuole superiori e tecniche, i centri pastorali, catechistici e liturgici, e quelli per i mezzi di comunicazione sociale. Una tale cooperazione va eventualmente instaurata anche tra diverse conferenze episcopali.
Coordinazione locale degli istituti
32. Conviene anche coordinare le attività svolte dagli istituti o dalle associazioni ecclesiatiche. Esse, di qualsiasi tipo siano, devono dipendere, per tutto quanto riguarda l'attività missionaria, dall'ordinario del luogo. A tal fine sarà utilissimo fissare delle convenzioni particolari, atte a regolare i rapporti tra l'ordinario del luogo e il superiore dell'istituto.
Allorché ad un istituto viene affidato un territorio, sarà pensiero del superiore ecclesiatico e dell'istituto stesso di indirizzare tutto a questo fine: che la nuova comunità cristiana cresca e diventi una Chiesa locale, che poi, al momento opportuno, sarà retta da un proprio pastore con clero proprio.
Cessando il mandato su un territorio, si determina una nuova situazione. Allora le conferenze episcopali e gli istituti devono emanare di comune accordo le norme che regolino i rapporti tra gli ordinari dei luoghi e gli istituti (153). Tocca però alla santa Sede fissare i principi generali, in base ai quali devono essere concluse le convenzioni in sede regionale o anche quelle di carattere particolare.
Anche se gli istituti sono pronti a continuare l'opera iniziata, collaborando nel ministero ordinario della cura d'anime, bisognerà tuttavia provvedere, man mano che cresce il clero locale, a che gli istituti, compatibilmente con il loro scopo, rimangano fedeli alla diocesi stessa, impegnandosi generosamente in opere di carattere speciale o in una qualche regione.
Coordinazione tra gli istituti
33. È poi necessario che gli istituti che attendono all'attività missionaria in uno stesso territorio trovino la giusta maniera per coordinare le loro opere. A questo proposito sono di grande utilità le conferenze di religiosi e le unioni di suore, di cui devono far parte tutti gli istituti della stessa nazione o regione. Queste conferenze devono ricercare quanto si può fare in comune, mettendo cioè insieme le forze, e mantenersi in stretto contatto con le conferenze episcopali.
Tutto questo è bene sia esteso in forma analoga anche alla collaborazione tra istituti missionari nei paesi in cui hanno avuto origine, al fine di risolvere più facilmente e con minori spese tutte le questioni ed iniziative comuni: si pensi ad esempio alla formazione dottrinale dei futuri missionari, ai corsi per missionari, alle relazioni da inviare alle pubbliche autorità o agli organismi internazionali e soprannazionali.
Coordinazione tra gli istituti scientifici
34. Poiché il retto ed ordinato esercizio della attività missionaria esige che gli operai evangelici siano scientificamente preparati ai loro doveri, in specie al dialogo con le religioni e le civiltà non cristiane, e che nella fase di esecuzione siano efficacemente aiutati, si desidera che a favore delle missioni collaborino fraternamente e generosamente tra loro tutti gli istituti scientifici che coltivano la missionologia e le altre discipline o arti utili alle missioni, come l'etnologia e la linguistica, la storia e la scienza delle religioni, la sociologia, le tecniche pastorali e simili.
CAPITOLO Vl
LA COOPERAZIONE
Introduzione
35. Essendo la Chiesa tutta missionaria, ed essendo l'opera evangelizzatrice dovere fondamentale del popolo di Dio, il sacro Concilio invita tutti i fedeli ad un profondo rinnovamento interiore, affinché, avendo una viva coscienza della propria responsabilità in ordine alla diffusione del Vangelo, prendano la loro parte nell'opera missionaria presso i pagani.
Tutti i fedeli devono cooperare all'apostolato missionario
36. Tutti i fedeli, quali membra del Cristo vivente, a cui sono stati incorporati ed assimilati mediante il battesimo, la cresima e l'eucaristia, hanno lo stretto obbligo di cooperare all'espansione e alla dilatazione del suo corpo, sì da portarlo il più presto possibile alla sua pienezza (154).
Pertanto tutti i figli della Chiesa devono avere la viva coscienza della loro responsabilità di fronte al mondo, devono coltivare in se stessi uno spirito veramente cattolico e devono spendere le loro forze nell'opera di evangelizzazione. Ma tutti sappiano che il primo e principale loro dovere in ordine alla diffusione della fede è quello di vivere una vita profondamente cristiana. Sarà appunto il loro fervore nel servizio di Dio, il loro amore verso il prossimo ad immettere come un soffio nuovo di spiritualità in tutta quanta la Chiesa, che apparirà allora come « un segno levato sulle nazioni » (155), come « la luce del mondo» (Mt 5,14) e «il sale della terra» (Mt 5,13). Una tale testimonianza di vita raggiungerà più facilmente il suo effetto se verrà data insieme con gli altri gruppi cristiani, secondo le norme contenute nel decreto relativo all'ecumenismo (156).
Sarà questo rinnovamento spirituale a far salire spontaneamente preghiere ed opere di penitenza a Dio, perché fecondi con la sua grazia il lavoro dei missionari; da esso avranno origine le vocazioni missionarie; da esso deriveranno quegli aiuti di cui le missioni han bisogno.
E perché tutti e singoli i fedeli conoscano adeguatamente la condizione attuale della Chiesa nel mondo e giunga loro la voce delle moltitudini che gridano: «Aiutateci» (157), bisogna offrir loro dei ragguagli di carattere missionario con l'ausilio anche dei mezzi di comunicazione sociale: sentiranno così come cosa propria l'attività missionaria, apriranno il cuore di fronte alle necessità tanto vaste e profonde degli uomini e potranno venir loro in aiuto. È necessario altresì coordinare queste notizie e cooperare con gli organismi nazionali e internazionali.
La cooperazione delle comunità cristiane
37. Poiché il popolo di Dio vive nelle comunità, specialmente in quelle diocesane e parrocchiali, ed in esse in qualche modo appare in forma visibile, tocca anche a queste comunità render testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni.
La grazia del rinnovamento non può avere sviluppo alcuno nelle comunità, se ciascuna di esse non allarga la vasta trama della sua carità sino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per coloro che sono i suoi propri membri.
È così che l'intera comunità prega, coopera, esercita una attività tra i popoli pagani attraverso quei suoi figli che Dio sceglie per questo nobilissimo compito.
Sarà quindi utilissimo mantenere i contatti, senza tuttavia trascurare l'opera missionaria generale, con i missionari che in questa stessa comunità hanno avuto origine, o con una parrocchia o con una diocesi di missione, perché divenga visibile l'unione intima tra le comunità, con il vantaggio di una reciproca edificazione.
Dovere missionario dei vescovi
38. Tutti i vescovi, in quanto membri del corpo episcopale che succede al collegio apostolico, sono stati consacrati non soltanto per una diocesi, ma per la salvezza di tutto il mondo. Il comando di Cristo di predicare il Vangelo ad ogni creatura (158) riguarda innanzitutto e immediatamente proprio loro, insieme con Pietro e sotto la guida di Pietro. Da qui deriva quella comunione e cooperazione a livello delle Chiese, che oggi è così necessaria per svolgere l'opera di evangelizzazione. In forza di questa comunione, le singole Chiese sentono la preoccupazione per tutte le altre, si informano reciprocamente dei propri bisogni, si scambiano l'una con l'altra i propri beni, essendo l'estensione del corpo di Cristo dovere dell'intero collegio episcopale (159).
Il vescovo, suscitando, promuovendo e dirigendo l'opera missionaria nella sua diocesi, con la quale forma un tutto uno, rende presente e, per così dire visibile lo spirito e l'ardore missionario del popolo di Dio, sicché la diocesi tutta si fa missionaria.
È pure compito del vescovo suscitare nel suo popolo, specialmente in mezzo ai malati e ai sofferenti, delle anime che con cuore generoso sanno offrire a Dio le loro preghiere e penitenze per l'evangelizzazione del mondo; incoraggiare volentieri le vocazioni dei giovani e dei chierici per gli istituti missionari, accettando con riconoscenza che Dio ne scelga alcuni per inserirli nell'attività missionaria della Chiesa; spronare e sostenere le congregazioni diocesane perché si assumano la loro parte nelle missioni; promuovere le opere degli istituti missionari in seno ai suoi fedeli, specialmente le pontificie opere missionarie. A queste opere infatti deve essere giustamente riservato il primo posto, perché costituiscono altrettanti mezzi sia per infondere nei cattolici, fin dalla più tenera età, uno spirito veramente universale e missionario, sia per favorire una adeguata raccolta di sussidi a vantaggio di tutte le missioni e secondo le necessità di ciascuna (160).
E poiché si fa ogni giorno più urgente la necessità di operai nella vigna del Signore ed i sacerdoti diocesani desiderano avere anch'essi un ruolo sempre più importante nell'evangelizzazione del mondo, il santo Concilio auspica che i vescovi, considerando la grandissima scarsezza di sacerdoti che impedisce la evangelizzazione di molte regioni, mandino alle diocesi mancanti di clero, debitamente preparati, alcuni dei loro migliori sacerdoti, perché si consacrino all'opera missionaria: sarà qui che essi, almeno per un certo periodo, eserciteranno con spirito di servizio il ministero missionario (161).
Ma perché l'attività missionaria dei vescovi si risolva realmente a vantaggio di tutta la Chiesa, è bene che le conferenze episcopali regolino esse tutte le questioni che si riferiscono alla ordinata cooperazione nella propria regione.
In sede di conferenza i vescovi devono trattare: dei sacerdoti del clero diocesano da consacrare alla evangelizzazione delle nazioni; del contributo finanziario che ciascuna diocesi, in proporzione del proprio reddito, deve versare annualmente per l'opera missionaria; della direzione e dell'organizzazione dei modi e dei mezzi ordinati al soccorso diretto delle missioni (162); dell'aiuto da offrire agli istituti missionari ed ai seminari di clero diocesano per le missioni e, se è necessario, della loro fondazione; della maniera di favorire rapporti sempre più stretti tra questi istituti e le diocesi.
Parimenti spetta alle conferenze episcopali fondare e promuovere delle opere che consentano di accogliere fraternamente e di seguire ed assistere pastoralmente coloro che, per ragioni di lavoro e di studio, emigrano dalle terre di missione. Grazie a questi immigrati infatti i popoli lontani diventano in qualche modo vicini, mentre alle comunità che sono cristiane da antica data si offre la magnifica occasione di aprire un dialogo con le nazioni che non hanno ancora ascoltato il Vangelo e di mostrare loro, nel servizio di amore e di aiuto che prestano, il volto genuino del Cristo (163).
Dovere missionario dei sacerdoti
39. I sacerdoti rappresentano il Cristo e sono i collaboratori dell'ordine episcopale nell'assolvimento di quella triplice funzione sacra che, per sua natura, si riferisce alla missione della Chiesa (164). Siano dunque profondamente convinti che la loro vita è stata consacrata anche per il servizio delle missioni. E poiché mediante il loro ministero - incentrato essenzialmente nell'eucaristia, la quale dà alla Chiesa la sua perfezione - essi entrano in comunione con Cristo capo ed a questa comunione conducono le anime, non possono non avvertire quanto ancora manchi alla pienezza del suo corpo e quanto quindi Sl debba compiere perché esso cresca sempre più. Essi pertanto organizzeranno la cura pastorale in modo tale che giovi alla espansione del Vangelo presso i non cristiani.
Nella loro cura pastorale i sacerdoti desteranno e conserveranno in mezzo ai fedeli lo zelo per l'evangelizzazione del mondo, istruendoli con la catechesi e la predicazione intorno al dovere che la Chiesa ha di annunziare il Cristo ai pagani; inculcando alle famiglie cristiane la necessità e l'onore di coltivare le vocazioni missionarie in mezzo ai loro figli e figlie; alimentando tra i giovani delle scuole e delle associazioni cattoliche il fervore missionario, sicché sorgano da essi dei futuri predicatori del Vangelo. Insegnino anche ai fedeli a pregare per le missioni e non arrossiscano di chieder loro elemosine, facendosi quasi mendicanti per il Cristo e la salvezza delle anime (165).
I professori dei seminari e delle università esporranno ai giovani la situazione reale del mondo e della Chiesa, perché sia chiara al loro spirito la necessità di una più intensa evangelizzazione dei non cristiani e ne tragga alimento il loro zelo. Nell'insegnamento poi delle discipline dogmatiche, bibliche, morali e storiche mettano bene in luce quegli aspetti missionari che vi sono contenuti, al fine di formare in questo modo una coscienza missionaria nei futuri sacerdoti.
Dovere missionario degli istituti religiosi
40. Gli istituti religiosi, di vita contemplativa ed attiva, hanno avuto fin qui ed hanno tuttora una parte importantissima nell'evangelizzazione del mondo. Il sacro Concilio ne riconosce di buon grado i meriti, rende grazie a Dio per i tanti sacrifici da loro affrontati per la gloria di Dio e il servizio delle anime, e li esorta a perseverare indefessamente nel lavoro intrapreso, consapevoli come sono che la virtù della carità, che devono coltivare in maniera più perfetta in forza della loro vocazione, li spinge e li obbliga ad uno spirito e ad un lavoro veramente cattolici (166).
Gli istituti di vita contemplativa con le loro preghiere, penitenze e tribolazioni, hanno la più grande importanza ai fini della conversione delle anime; perché è Dio che, in risposta alla preghiera, invia operai nella sua messe (167), apre lo spirito dei non cristiani perché ascoltino il Vangelo (168), e rende feconda nei loro cuori la parola della salvezza (169). Si invitano anzi gli istituti di questo tipo a fondare le loro case nelle terre di missione, come del resto non pochi han già fatto, affinché, vivendovi ed adattandosi alle tradizioni autenticamente religiose dei popoli, rendano tra i non cristiani una magnifica testimonianza alla maestà ed alla carità di Dio, come anche all'unione in Cristo.
Gli istituti di vita attiva, perseguano o no un fine strettamente missionario, devono in tutta sincerità domandarsi dinanzi a Dio se sono in grado di estendere la propria azione al fine di espandere il regno di Dio tra le nazioni; se possono lasciare ad altri alcune opere del loro ministero, per dedicare le loro forze alle missioni; se possono iniziare un'attività nelle missioni, adattando, se necessario, le loro costituzioni, secondo lo spirito del fondatore; se i loro membri prendono parte secondo le proprie forze all'attività missionaria; se il loro sistema di vita costituisce una testimonianza al Vangelo, ben rispondente al carattere ed alla condizione del popolo.
Poiché infine, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, si sviluppano sempre più nella Chiesa gli istituti secolari, la loro opera, guidata dall'autorità del vescovo, può riuscire sotto diversi aspetti utilissima nelle missioni, come segno di dedizione totale all'evangelizzazione del mondo.
Dovere missionario dei laici
41. I laici cooperano all'opera evangelizzatrice della Chiesa partecipando insieme come testimoni e come vivi strumenti alla sua missione salvifica soprattutto quando, chiamati da Dio (170), vengono destinati dai vescovi a quest'opera.
Nelle terre già cristiane i laici cooperano all'opera evangelizzatrice sviluppando in se stessi e negli altri la conoscenza e l'amore per le missioni, suscitando delle vocazioni nella propria famiglia, nelle associazioni cattoliche e nelle scuole, offrendo sussidi di qualsiasi specie, affinché il dono della fede, che han ricevuto gratuitamente, possa essere comunicato anche ad altri.
Nelle terre di missione invece, i laici, sia forestieri che autoctoni, devono insegnare nelle scuole, avere la gestione delle faccende temporali, collaborare alla attività parrocchiale e diocesana, stabilire e promuovere l'apostolato laicale nelle sue varie forme, affinché i fedeli delle giovani Chiese possano svolgere quanto prima la propria parte nella vita della Chiesa (171).
I laici infine devono offrire volentieri la loro collaborazione in campo economico-sociale ai popoli in via di sviluppo. Tale collaborazione è tanto più degna di lode quanto più direttamente riguarda la fondazione di istituti connessi con le strutture fondamentali della vita sociale, o destinati alla formazione di coloro che hanno responsabilità politiche.
Meritano una lode speciale quei laici che nelle università o negli istituti scientifici promuovono con le loro ricerche di carattere storico o scientifico religioso la conoscenza dei popoli e delle religioni, aiutando così i messaggeri del Vangelo e preparando i1 dialogo con i non cristiani.
Collaborino poi fraternamente con gli altri cristiani, con i non cristiani, specialmente con i membri delle associazioni internazionali, proponendosi costantemente come obiettivo che « la costruzione della città terrena sia fondata sul Signore ed a lui sia sempre diretta » (172).
Naturalmente per assolvere tutti questi compiti i laici han bisogno di un'indispensabile preparazione tecnica e spirituale, da impartire in istituti specializzati, affinché la loro vita costituisca tra i non cristiani una testimonianza a Cristo, secondo l'espressione dell'Apostolo: « Non date scandalo né ai Giudei né ai Gentili, né alla Chiesa di Dio, così come anch'io mi sforzo di piacere a tutti in ogni cosa, non cercando il mio vantaggio, ma quello del più gran numero, perché siano salvi» (1 Cor 10,32-33).
CONCLUSIONE
42. I Padri conciliari, in unione con il romano Pontefice, sentendo profondamente il dovere di diffondere dappertutto il regno di Dio, rivolgono un saluto affettuosissimo a tutti i messaggeri del Vangelo, a coloro specialmente che soffrono persecuzioni per il nome di Cristo, e si associano alle loro sofferenze (173).
Sono anch'essi infiammati da quello stesso amore, di cui ardeva Cristo per gli uomini. Consapevoli che è Dio a far sì che venga il suo regno sulla terra, insieme con tutti i fedeli essi pregano perché, mediante l'intercessione della vergine Maria, degli apostoli, le nazioni siano quanto prima condotte alla conoscenza della verità (174) e la gloria di Dio, che rifulge sul volto di Cristo Gesù, cominci a brillare in tutti gli uomini per l'azione dello Spirito Santo (175).
Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto è stato così sinodalmente deciso, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.
Roma, presso San Pietro 7 dicembre 1965.
Io PAOLO Vescovo della Chiesa Cattolica
PER SCARICARE IL DECRETO SULL'ATTIVITA' MISSIONARIA DELLA CHIESA "AD GENTES" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

La Chiesa "sacramento universale di salvezza" (n. 1)
774 La parola greca µLFJD4@< è stata tradotta in latino con due termini: mysterium esacramentum. Nell'interpretazione ulteriore, il termine sacramentum esprime più precisamente il segno visibile della realtà nascosta della salvezza, indicata dal termine mysterium. In questo senso, Cristo stesso è il mistero della salvezza: « Non est enim aliud Dei mysterium, nisi Christus – Non v'è altro mistero di Dio, se non Cristo ». 198 L'opera salvifica della sua umanità santa e santificante è il sacramento della salvezza che si manifesta e agisce nei sacramenti della Chiesa (che le Chiese d'Oriente chiamano anche « i santi misteri »). I sette sacramenti sono i segni e gli strumenti mediante i quali lo Spirito Santo diffonde la grazia di Cristo, che è il Capo, nella Chiesa, che è il suo corpo. La Chiesa, dunque, contiene e comunica la grazia invisibile che essa significa. È in questo senso analogico che viene chiamata « sacramento ».
775 « La Chiesa è in Cristo come sacramento, cioè segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano ». 199 Essere il sacramento dell'intima unione degli uomini con Dio: ecco il primo fine della Chiesa. Poiché la comunione tra gli uomini si radica nell'unione con Dio, la Chiesa è anche il sacramento dell'unità del genere umano. In essa, tale unità è già iniziata poiché essa raduna uomini « di ogni nazione, razza, popolo e lingua » (Ap 7,9); nello stesso tempo, la Chiesa è « segno e strumento » della piena realizzazione di questa unità che deve ancora compiersi.
776 In quanto sacramento, la Chiesa è strumento di Cristo. Nelle sue mani essa è lo « strumento della redenzione di tutti », 200 « il sacramento universale della salvezza », 201 attraverso il quale Cristo « svela e insieme realizza il mistero dell'amore di Dio verso l'uomo ». 202 Essa « è il progetto visibile dell'amore di Dio per l'umanità », 203 progetto che vuole « la costituzione di tutto il genere umano nell'unico popolo di Dio, la sua riunione nell'unico corpo di Cristo, la sua edificazione nell'unico tempio dello Spirito Santo ». 204

LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO
ECCLESIAE SANCTAE
Vengono promulgate norme per l'applicazione di alcuni Decreti del Concilio Vaticano II
Il governo della Santa Chiesa esige senza alcun dubbio che, dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, siano stabilite nuove norme e siano sanciti nuovi ordinamenti che rispondano alle necessità che il Concilio ha posto in rilievo, e siano sempre più adatti ai nuovi scopi e settori d'apostolato. Questi ultimi, grazie al Concilio, sono stati aperti alla Chiesa nel mondo attuale, il quale, in seguito a profonde trasformazioni, ha bisogno di un irraggiamento di luce e attende un ardore soprannaturale di carità.
Già dalla fine del Concilio Ecumenico, spinti da queste riflessioni, Noi abbiamo costituito Commissioni di studio, ognuna delle quali, per parte sua, applicasse le sue consegne e la sua esperienza al fine di definire le norme fisse d'esecuzione di Decreti del Concilio, per i quali era stata concessa una vacanza della legge. Come volentieri scrivemmo nel motu proprio MunusApostolicum dello scorso 10 giugno, queste Commissioni si dedicarono con zelo al compito loro affidato e Ci fecero conoscere le loro conclusioni nel tempo indicato.
Dopo aver attentamente considerato queste conclusioni, Noi giudichiamo che è ormai venuto il tempo di promulgare le norme di cui sopra. Tuttavia, poiché si tratta di una materia che riguarda la disciplina, per la quale l'esperienza può ancora suscitare molti suggerimenti, e poiché, d'altra parte, una Commissione apposita lavora alla revisione del Codice di Diritto Canonico, nel quale tutte le leggi della Chiesa universale saranno coordinate secondo un criterio più appropriato, esatto e preciso, Ci pare di agire con saggezza e prudenza promulgando queste norme ad esperimento.
Nell'intervallo, vi sarà agio per le Conferenze Episcopali di comunicarCi le riflessioni e le osservazioni che l'applicazione delle norme potrebbe suggerire, e di proporCi nuovi pareri.
Così dunque, dopo aver profondamente riflettuto, di Nostra iniziativa e con la nostra autorità apostolica, decretiamo e promulghiamo le seguenti norme per l'applicazione dei Decreti del Conci- lio: Christus Dominus (sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa), Presbyterorum Ordinis (sul ministero e la vita sacerdotale), Perfectae caritatis (sul rinnovamento della vita religiosa) e Ad gentes divinitus (sull'attività missionaria della Chiesa). Noi prescriviamo che queste norme siano osservate a titolo di esperimento, e cioè fino alla promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, a meno che, nell'intervallo, la Sede Apostolica non decida altrimenti.
Queste norme entreranno in vigore il prossimo 11 ottobre, giorno consacrato alla Maternità della Beata Vergine Maria e giorno in cui, quattro anni or sono, il Sacro Concilio fu inaugurato solennemente dal Nostro Predecessore Giovanni XXIII di venerata memoria.
Tutto ciò che abbiamo stabilito in questa Lettera data in forma di motu proprio, Noi ordiniamo che sia tenuto per fermo e ratificato, nonostante ogni cosa contraria, anche degna di specialissima menzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 6 agosto 1966, nella festa della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, anno quarto del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI
I. NORME PER L'APPLICAZIONE DEI DECRETI
DEL CONCILIO VATICANO II
«CHRISTUS DOMINUS» E «PRESBYTERORUM ORDINIS»
L'ufficio episcopale, che il Concilio Vaticano II ha messo più vivamente in luce nella Costituzione dogmatica Lumen gentium e nel Decreto Christus Dominus, è stato divinamente istituito in vista dell'edificazione del Corpo Mistico di Cristo, che è la Chiesa.
Perciò i Sacri Pastori sono tenuti a compiere, con cura costante, l'ufficio che essi hanno di insegnare, di santificare e di pascere il Popolo di Dio, sia assumendo generosamente la loro parte nella sollecitudine di tutte le Chiese col Romano Pontefice, sia provvedendo con maggiore attenzione al buon governo delle diocesi che sono loro affidate, sia infine collaborando attivamente tra loro per il bene comune di più Chiese.
Nel governo delle diocesi a loro affidate, i Vescovi hanno, come necessari aiuti e come consiglieri, in primo luogo i Sacerdoti, perciò volentieri li ascolteranno e ancor più li vorranno consultare, restando sempre salvo il potere degli stessi Vescovi di agire liberamente in ogni cosa, di stabilire criteri e norme e di emanare leggi secondo la coscienza ch'essi hanno del loro ufficio e i principi del governo della Chiesa (cf Cost. dogm. Lumen gentium, n. 27).
E affinché i Vescovi siano più facilmente e più opportunamente in grado di esercitare il loro ufficio pastorale, e per applicare con maggiore efficacia i principi che il Sacro Concilio ha solennemente approvato, sia nel Decreto Christus Dominus, sia nel Decreto Presbyterorum ordinis, vengono stabilite le norme seguenti.
RIPARTIZIONE DEL CLERO
E AIUTI DA FORNIRSI ALLE DIOCESI
(Decr. Christus Dominus, n. 6 e Decr. Presbyterorum ordinis, n. 10)
1. Sia istituito presso la Sede Apostolica, se si crederà opportuno, uno speciale Consiglio con il compito di stabilire i principi con cui la distribuzione del clero sia resa più adatta alle necessità delle varie Chiese.
2. Spetterà ai Sinodi Patriarcali e alle Conferenze Episcopali, tenendo presente quanto prescritto dalla Sede Apostolica, stabilire ordinanze ed emettere norme per i Vescovi, per ottenere un'opportuna distribuzione del clero sia del proprio territorio, sia di quello che provenga da altre regioni; con tale distribuzione si provveda alle necessità di tutte le diocesi del proprio territorio, e si pensi anche al bene delle Chiese in terra di Missione e nelle Nazioni che soffrono per scarsezza di clero. Perciò si costituisca, presso ogni Conferenza Episcopale, una Commissione, il cui compito sarà di prendere in considerazione le necessità delle varie diocesi del suo territorio e la loro possibilità di cedere ad altre Chiese alcuni elementi del proprio clero, e di dare esecuzione alle conclusioni, stabilite e approvate dalla Conferenza, che riguardano la distribuzione del clero, riferendole ai Vescovi di quei territori.
3. Per rendere più facile il passaggio di un chierico da una diocesi all'altra - fermo restando l'istituto dell'incardinazione e dell'escardinazione, anche se adattato alle nuove circostanze - si stabiliscono le seguenti norme:
§ 1. I chierici nei Seminari siano formati in modo da aver sollecitudine non soltanto della diocesi al cui servizio sono ordinati, ma della Chiesa intera, in modo che, col permesso del proprio Vescovo, siano pronti a dedicarsi alle Chiese particolari, che ne abbiano grave necessità;
§ 2. Fuori del caso di vera necessità della propria diocesi, gli Ordinari non neghino il permesso di emigrazione ai chierici che conoscono preparati e che stimano adatti a esercitare il sacro ministero nelle regioni che soffrono per la penuria di clero; curino però, attraverso una convenzione scritta con l'Ordinario del luogo d'arrivo, che siano definiti i diritti e i doveri dei loro chierici;
§ 3. Parimenti gli stessi Ordinari s'interessino affinché i chierici, che dalla propria diocesi intendono recarsi in quella di un'altra nazione, siano adeguatamente preparati per esercitare in quel luogo il sacro ministero, cioè che acquistino conoscenza degli istituti, delle condizioni sociali, della lingua di quella regione, nonché degli usi e delle abitudini di quegli abitanti;
§ 4. Gli Ordinari possono concedere ai loro chierici il permesso di passare a un'altra diocesi per un tempo determinato, magari rinnovabile più volte, ma a condizione che gli stessi chierici restino incardinati alla propria diocesi e che ritornandovi godano di tutti i diritti e doveri che avrebbero se vi fossero stati impegnati nel sacro ministero;
§ 5. Il chierico poi che passa legittimamente dalla propria diocesi ad un'altra, trascorsi cinque anni, sarà incardinato di diritto a quest'ultima diocesi se avrà manifestato per iscritto tale volontà sia all'Ordinario della diocesi ospite, sia all'Ordinario proprio, né entro quattro mesi abbia ricevuto da nessuno dei due un parere contrario.
4. Inoltre, per favorire speciali iniziative pastorali o missionarie in favore di certe regioni o di gruppi sociali, che abbisognano di speciale aiuto, possono fruttuosamente essere erette dalla Sede Apostolica delle Prelature composte di presbiteri del clero secolare, in possesso di una particolare formazione, dotate di propri statuti e sotto la direzione di un proprio Prelato.
Sarà compito di questo Prelato fondare e dirigere Seminari nazionali o internazionali, per una opportuna formazione degli alunni. Tale Prelato avrà il diritto di incardinare quegli alunni e di promuoverli agli Ordini col titolo di servizio della Prelatura.
Il Prelato deve interessarsi della vita spirituale di coloro che ha promosso col titolo predetto e di perfezionare continuamente la loro peculiare formazione, in vista dello speciale ministero, con opportuni accordi con gli Ordinari dei luoghi in cui questi sacerdoti sono mandati. Così pure deve provvedere loro un dignitoso sostentamento, assicurato mediante gli stessi accordi, o con beni propri della Prelatura o con altri opportuni aiuti. Similmente dovrà interessarsi di coloro che per malferma salute o per altre cause sono costretti ad abbandonare il loro ministero.
Nulla impedisce che dei laici, sia celibi sia coniugati, mediante convenzioni con la Prelatura, offrano la loro abilità professionale a servizio delle opere e delle iniziative di essa.
Tali Prelature non siano erette se non dopo aver ascoltato le Conferenze Episcopali del territorio in cui esse prestano la loro opera. Nel loro servizio le Prelature si premurino di rispettare i diritti degli Ordinari del luogo e abbiano continue e strette relazioni con le stesse Conferenze Episcopali.
5. È dovere dei Sinodi Patriarcali e delle Conferenze Episcopali stabilire quegli opportuni regolamenti sull'uso dei beni ecclesiastici, con cui, facendo attenzione anzitutto alle necessità delle diocesi del proprio territorio, vengano imposti dei tributi da versare in favore sia delle opere di apostolato e di carità, sia delle Chiese povere o che, per particolari circostanze, si trovano in necessità.
POTERI DEI VESCOVI DIOCESANI
(Decr. Christus Dominus, n. 8)
6. Le norme per l'applicazione di ciò che prescrive il n. 8 sono state stabilite con il motu proprio De Episcoporum muneribus, del 15 giugno 1966.
FAVORIRE LO STUDIO E LA SCIENZA PASTORALE
(Decr. Christus Dominus, n. 16 e Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 19)
7. Procurino i Vescovi da soli o uniti tra di loro, che tutti i Presbiteri, anche se incaricati di un ministero, seguano una serie di lezioni pastorali, subito dopo l'ordinazione, per la durata di un anno e frequentino in giorni prestabiliti altri corsi, sia ad essi offerta l'occasione sia di acquisire una più piena conoscenza dei metodi pastorali, della scienza teologica, morale e liturgica, sia di irrobustire la vita spirituale e di comunicarsi tra loro, come fratelli, le esperienze apostoliche.
Provvedano inoltre i Vescovi o le Conferenze Episcopali, secondo le condizioni di ogni territorio, che siano eletti uno o diversi Presbiteri di provata scienza e virtù, i quali a guisa di prefetti degli studi, promuovano e organizzino dei corsi pastorali e altri mezzi ritenuti necessari per favorire la formazione scientifica e pastorale dei Sacerdoti del proprio territorio, come: centri destinati agli studi, biblioteche circolanti, convegni di catechetica, di omiletica, di liturgia o simili.
ASSICURARE AI SACERDOTI UNA GIUSTA REMUNERAZIONE
E ORGANIZZARE LA PREVIDENZA SOCIALE
(Decr. Christus Dominus, n. 16
e Decr. Presbyterorum ordinis, nn. 20-21)
8. I Sinodi Patriarcali e le Conferenze Episcopali provvedano, ognuno nella propria diocesi o riunendosi in gruppi o su scala nazionale, ad emanare delle norme che garantiscano un decoroso sostentamento di quanti svolgono o hanno svolto una funzione al servizio del Popolo di Dio. Si richiede che la retribuzione da assegnare ai chierici sia anzitutto uguale per tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, tenendo conto però sia della natura dell'ufficio sia delle circostanze di tempo e di luogo, nonché sufficiente a una vita decorosa dei chierici e anche a soccorrere i poveri.
La riforma del sistema beneficiario è affidata alla Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico. Frattanto i Vescovi, dopo aver udito i Consigli presbiterali, provvedano a una equa distribuzione dei beni, anche di quelli che provengono dai redditi beneficiari.
Almeno nelle regioni in cui il sostentamento del clero dipende completamente o in gran parte dalle offerte dei fedeli, le Conferenze Episcopali procurino che esista in ogni diocesi una istituzione speciale che raccolga i beni offerti a questo scopo, il cui amministratore sia il Vescovo diocesano, con la collaborazione di sacerdoti delegati e, se ce ne fosse bisogno, anche di laici esperti in economia.
Infine le stesse Conferenze Episcopali procurino che nelle rispettive nazioni vi siano, in conformità alle leggi ecclesiastiche e civili, o delle istituzioni diocesane confederate tra loro o altre istituzioni costituite per diverse diocesi unite insieme o un'associazione a carattere nazionale, le quali provvedano adeguatamente, sotto la vigilanza della Gerarchia, sia alla conveniente previdenza e assistenza sanitaria, sia al doveroso sostentamento dei chierici malati, invalidi o anziani.
Spetterà al Codice di Diritto Canonico riformato stabilire i criteri secondo cui si dovrà pure costituire in ogni diocesi o regione un altro fondo comune con cui i Vescovi possano soddisfare gli altri obblighi verso le persone che prestano servizio alla Chiesa, o venir incontro alle varie necessità della diocesi e con il quale le diocesi più ricche possano aiutare quelle più povere.
SOLLECITUDINE PER ALCUNE CATEGORIE DI FEDELI
(Decr. Christus Dominus, n. 18)
9. Le Conferenze Episcopali, dato l'odierno grande numero di emigranti e di turisti, sono pregate d'affidare ad un sacerdote delegato a questo scopo, o a una speciale Commissione, tutto ciò che si riferisce allo studio e all'organizzazione del loro servizio spirituale.
NOMINA DEI VESCOVI
(Decr. Christus Dominus, n. 20)
10. Fermo restando il diritto del Romano Pontefice di nominare liberamente i Vescovi e di conferir loro l'ufficio, e salva la disciplina delle Chiese Orientali, le Conferenze Episcopali ogni anno trattino prudentemente sotto segreto degli ecclesiastici degni d'essere promossi all'ufficio Episcopale e propongano alla Sede Apostolica i nomi dei candidati, secondo le norme stabilite o da stabilirsi dalla Sede Apostolica stessa.
RINUNCIA DEI VESCOVI AL LORO UFFICIO
(Decr. Christus Dominus, n. 21)
11. Per rendere possibile l'esecuzione della prescrizione del n. 21 del Decreto Christus Dominus, tutti i Vescovi diocesani e gli altri ad essi equiparati per diritto sono vivamente pregati di presentare spontaneamente, non più tardi dei 75 anni compiuti, la rinuncia all'ufficio all'Autorità competente, la quale, esaminati tutti gli aspetti di ogni singolo caso, provvederà.
Il Vescovo la cui rinuncia all'ufficio sia stata accettata, potrà conservare, se lo desidera, la residenza nella stessa diocesi. Questa poi deve provvedere al conveniente e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia. È compito della Conferenza Episcopale territoriale determinare, con una norma generale, i criteri secondo i quali le diocesi devono soddisfare questo obbligo.
DELIMITAZIONE DEI CONFINI DELLE DIOCESI
(Decr. Christus Dominus, nn. 22-24)
12. § 1. Affinché la delimitazione delle diocesi possa essere adeguatamente riveduta, le Conferenze Episcopali, ognuna per il suo territorio, esamineranno le attuali divisioni territoriali delle Chiese, istituendo, se occorre, una Commissione particolare. A tale fine bisogna studiare con cura lo stato delle diocesi quanto al territorio, alle persone e ai beni. Sarà ascoltato ognuno dei Vescovi direttamente interessati, e così pure i Vescovi di tutta la provincia o regione ecclesiastica nei limiti della quale ha luogo la revisione delle diocesi; sarà domandato l'apporto, se possibile, di esperti veramente competenti, ecclesiastici o laici; le ragioni obiettive che potrebbero suggerire un mutamento delle circoscrizioni saranno ponderate con calma; dovranno essere proposte tutte le modifiche che dovrebbero essere introdotte secondo quanto affermato nei nn. 22-23 del DecretoChristus Dominus; nella divisione o nello smembramento delle diocesi si avrà cura di una giusta e opportuna distribuzione dei sacerdoti e dei seminaristi, tenuto conto sia delle necessità che presenta l'esercizio del ministero della salvezza in ciascuna diocesi, sia delle condizioni particolari e dei desideri dei sacerdoti e dei seminaristi.
§ 2. Per le Chiese Orientali, poi, è desiderabile che nel definire i confini delle eparchie sia tenuto conto anche della maggiore vicinanza dei luoghi di residenza dei fedeli di un medesimo rito.
FACOLTÀ DEI VESCOVI AUSILIARI
(Decr. Christus Dominus, nn. 25-26)
13. § 1. È necessario costituire Vescovi Ausiliari per una determinata diocesi ogni qual volta lo esigano ragioni di vera necessità nell'esercizio dell'apostolato. Orbene, i principi da tener presenti quando si tratta della potestà da attribuire al Vescovo Ausiliare sono: il bene della cura del gregge del Signore, l'unità di direzione nel governo della diocesi, la condizione di membro del Collegio Episcopale di cui è insignito l'Ausiliare e l'efficace cooperazione col Vescovo diocesano.
§ 2. Il Vescovo diocesano deve costituire l'Ausiliare o Vicario Generale (Sincello) o Vicario Episcopale, a condizione però che in ciascun caso questi dipenda unicamente dall'autorità del Vescovo diocesano.
§ 3. Per provvedere sufficientemente al bene della diocesi e per porre al sicuro la dignità del Vescovo Ausiliare, il Concilio ha voluto manifestare il suo desiderio che, quando la sede è vacante, coloro che ne hanno il diritto affidino il governo della diocesi al Vescovo Ausiliare, oppure, quando essi sono più di uno, a uno di costoro. Tuttavia, a meno che la competente Autorità non abbia stabilito diversamente in un caso speciale, il Vescovo Ausiliare non perde, durante la vacanza della sede, i poteri e le facoltà di cui godeva per diritto, vivente il titolare della sede, come Vicario Episcopale o come Vicario Generale. Nel caso in cui l'Ausiliare non sia stato eletto Vicario Capitolare, continua a godere di questa sua potestà, concessagli dal diritto, finché il nuovo Vescovo non abbia preso possesso della sede; ma la eserciterà in piena concordia coi Vicario Capitolare, che presiede al governo della diocesi.
I VICARI EPISCOPALI
(Decr. Christus Dominus, n. 27)
14. § 1. Il nuovo ufficio di Vicario Episcopale è stato introdotto nel diritto dal Concilio, affinché il Vescovo, assistito da nuovi cooperatori, possa esercitare il governo pastorale della diocesi nel miglior modo. Perciò la nomina di uno o più Vicari Episcopali è lasciata alla libera iniziativa del Vescovo diocesano, secondo le particolari necessità del luogo; anzi rimane immutata la sua facoltà di nominare uno o diversi Vicari Generali, a norma del can. 366 CIC.
§ 2. I Vicari Episcopali hanno la stessa potestà ordinaria vicaria, che il diritto comune dà al Vicario Generale, relativamente a una determinata parte del territorio diocesano, o in un particolare genere di affari, oppure nei riguardi dei fedeli di un determinato rito o di una categoria di persone, secondo la designazione del Vescovo diocesano. Perciò essi godono, nei limiti della loro competenza, delle facoltà abituali che la Santa Sede concede al Vescovo e possono dare esecuzione ai rescritti, a meno che non sia stato stabilito diversamente, oppure a meno che l'esecuzione del rescritto non sia stata scelta in considerazione della persona del Vescovo. Tuttavia il Vescovo diocesano ha la libertà di riservare a sé o al Vicario Generale le cause che crede, oppure anche di conferire al Vicario Episcopale lo speciale mandato prescritto dal diritto per alcuni affari.
§ 3. Essendo cooperatore dell'ufficio episcopale, il Vicario Episcopale deve riferire al Vescovo diocesano su tutto ciò che ha compiuto o che intende compiere; anzi non deve mai agire contro l'intenzione o contro la volontà del Vescovo. Inoltre non manchi di stabilire un dialogo frequente anche con gli altri cooperatori del Vescovo, in modo particolare con il Vicario Generale, nei modi da stabilirsi dal Vescovo, per rendere sempre più salda nel clero e nel popolo cristiano l'unità della disciplina e per ottenere frutti più copiosi nella diocesi.
§ 4. Un indulto rifiutato dal Vicario Generale o dal Vicario Episcopale, non può essere concesso validamente da un altro Vicario dello stesso Vescovo, anche se sono state esposte le ragioni del rifiuto da parte del Vicario. Inoltre un indulto rifiutato dal Vicario Generale o «Sincello» o dal Vicario Episcopale e poi ottenuto dal Vescovo, senza far menzione del precedente rifiuto, è invalido; l'indulto invece rifiutato dal Vescovo non può mai essere concesso validamente dal Vicario Generale o dal Vicario Episcopale, anche se si fa presente la risposta negativa del Vescovo, a meno che costui non acconsenta.
§ 5. I Vicari Episcopali che non siano Vescovi Ausiliari ricevono la nomina per un tempo determinato nell'atto stesso di costituzione; possono però essere rimossi a piacere del Vescovo. Quando la sede diventa vacante scadono dal loro ufficio, a meno che non siano Vescovi Ausiliari; tuttavia conviene che il Vicario Capitolare si serva di loro in qualità di suoi delegati, affinché non ne scapiti minimamente il bene della diocesi.
CONSIGLIO PRESBITERALE E CONSIGLIO PASTORALE
(Decr. Christus Dominus, n. 27 e Decr. Presbyterorum ordinis, n. 7)
15. Per ciò che concerne il Consiglio Presbiterale:
§ 1. In ogni diocesi sia istituito nel modo e nelle forme fissate dal Vescovo, un Consiglio Presbiterale, cioè un gruppo o senato di sacerdoti, rappresentanti il Presbiterio, che possa efficacemente aiutare col suo consiglio il Vescovo nel governo della diocesi. In questo Consiglio, il Vescovo ascolterà i suoi sacerdoti, li consulterà e si intratterrà con essi su ciò che riguarda le necessità dell'opera pastorale e il bene della diocesi.
§ 2. Tra i membri del Consiglio Presbiterale potranno essere scelti anche dei Religiosi, in quanto hanno cura del ministero delle anime e di altre opere d'apostolato.
§ 3. Il Consiglio Presbiterale ha solo voce consultiva.
§ 4. Durante la vacanza della sede, il Consiglio Presbiterale decade, a meno che in particolari circostanze, riconosciute dalla Santa Sede, il Vicario Capitolare o l'Amministratore Apostolico non lo confermi. Il nuovo Vescovo si costituirà egli stesso un nuovo Consiglio Presbiterale.
16. Per ciò che riguarda il Consiglio Pastorale, vivamente comandato dal Decreto ChristusDominus:
§ 1. È compito del Consiglio Pastorale studiare, esaminare tutto ciò che concerne le attività pastorali, e proporre quindi conclusioni pratiche, al fine di promuovere la conformità della vita e dell'azione del Popolo di Dio con il Vangelo.
§ 2. Il Consiglio Pastorale, che ha voce soltanto consultiva, può essere costituito in diversi modi. Ordinariamente, anche se per sua natura è un'istituzione permanente, esso può essere a tempo determinato quanto ai suoi membri e alla sua attività, e può adempiere al suo ufficio occasionalmente; il Vescovo potrà convocarlo ogni volta che lo crederà opportuno.
§ 3. Nel Consiglio Pastorale troveranno posto sacerdoti, Religiosi e laici, particolarmente scelti dal Vescovo.
§ 4. Affinché il Consiglio raggiunga veramente il suo scopo, è conveniente che studi preventivi precedano il lavoro in comune, con l'aiuto, se occorre, degli Istituti e degli uffici che operano a questo fine.
§ 5. Ove esistano, su un medesimo territorio, Gerarchie di riti diversi, si raccomanda fortemente che, nella misura del possibile, il Consiglio Pastorale sia di carattere interrituale, cioè composto di sacerdoti, Religiosi e laici dei diversi riti.
§ 6. Le altre disposizioni da prendersi sono lasciate alla libera decisione del Vescovo diocesano, tenuto conto di ciò che è detto al n. 17.
17. § 1. È opportuno che, per le questioni che riguardano sia il Consiglio Presbiterale, sia il Consiglio Pastorale, nonché le loro mutue relazioni, o le relazioni con i Consigli Episcopali già esistenti secondo il diritto in vigore, i Vescovi, specialmente riuniti nelle Conferenze, prendano disposizioni comuni ed emanino norme simili in tutte le diocesi del territorio.
I Vescovi avranno anche cura che tutti i Consigli diocesani siano il meglio possibile coordinati mediante una definizione precisa delle competenze, una partecipazione mutua dei loro membri a sessioni comuni o continue, e in altri modi.
§ 2. Frattanto i Consigli del Vescovo che esistono in forza del diritto vigente, vale a dire il Capitolo Cattedrale, la Riunione dei consultori, e altri ancora se ne esistono, conservano i loro compiti e le loro competenze, in attesa della loro revisione.
SOPPRESSIONE DI DIRITTI E PRIVILEGI
NEL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI O DEI BENEFICI
(Decr. Christus Dominus, n. 28)
18. § 1. Il bene delle anime esige che il Vescovo goda della libertà richiesta per conferire con giustizia ed equità ai sacerdoti più idonei gli uffici e benefici, anche non curati. La Sede Apostolica stessa non si riserva più il conferimento di uffici o di benefici, siano essi curati o non curati, salvo i benefici concistoriali. Nel testo di fondazione di qualsiasi beneficio sono proibite per sempre le clausole che limitassero la libertà del Vescovo quanto al loro conferimento; sono abrogati i privilegi non onerosi, eventualmente concessi fino ad oggi a persone fisiche o morali, che comportano un diritto di elezione, di nomina, o di presentazione per qualsiasi ufficio o beneficio non concistoriale vacante; sono abrogate le consuetudini e ritirati i diritti quanto alla nomina, all'elezione, alla presentazione di sacerdoti ad un ufficio o beneficio parrocchiale; la legge del concorso, anche per gli uffici o benefici non curati, è soppressa.
Per ciò che concerne le cosiddette elezioni popolari, dove sono in vigore, è compito della Conferenza Episcopale proporre alla Sede Apostolica le misure ritenute più adatte perché, nella misura del possibile, vengano abrogate.
§ 2. Se però, in questa materia, diritti e privilegi sono stati stabiliti attraverso una convenzione tra la Sede Apostolica e una Nazione, oppure attraverso un contratto intervenuto con persone fisiche o morali, sarà necessario trattare della loro cessazione con gli interessati.
VICARI FORANEI
(Decr. Christus Dominus, n. 30)
19. § 1. Tra i più prossimi collaboratori del Vescovo diocesano si pongono i sacerdoti che esercitano un ufficio pastorale superparrocchiale, e tra essi occorre rammentare i Vicari Foranei, chiamati anche Arcipreti, o Decani e, presso gli Orientali, Protopresbiteri. Ad esercitare questo ufficio siano chiamati sacerdoti che si distinguono per scienza e zelo apostolico, in modo che, muniti da parte del Vescovo delle facoltà necessarie, possano convenientemente promuovere e dirigere un'azione pastorale d'insieme nel territorio loro affidato. Perciò questo ufficio non è legato ad una determinata sede parrocchiale.
§ 2. I Vicari Foranei, Arcipreti o Decani, siano nominati per un tempo da determinarsi secondo un diritto particolare; essi potranno essere rimossi a piacimento del Vescovo. È bene che il Vescovo diocesano li interpelli ogni volta che si tratta di nomina, trasferimento o rimozione di parroci nel territorio cui presiedono.
RIMOZIONE, TRASFERIMENTO E RINUNCIA DEI PARROCI
(Decr. Christus Dominus, n. 31)
20. § 1. Il Vescovo può, restando salvo il diritto vigente per i Religiosi, legittimamente rimuovere qualsiasi parroco dalla sua parrocchia, ogni qual volta il suo ministero, anche se egli non ha commesso colpa grave, è reso pregiudizievole o almeno inefficace per una delle ragioni indicate dal diritto o altra simile a giudizio del Vescovo: fino alla riforma del Codice si segua la procedura stabilita per i parroci amovibili (cann. 2157-2161 CIC), e resti salvo il diritto delle Chiese Orientali.
§ 2. Se il bene delle anime, o i bisogni ovvero l'utilità della Chiesa lo richiedono, il Vescovo può trasferire un parroco dalla parrocchia che egli regge in modo utile ad un'altra parrocchia o a qualsiasi altro ufficio ecclesiastico. E, se il parroco si rifiuta, il Vescovo deve, perché il trasferimento sia validamente decretato, seguire in tutto la procedura di cui sopra.
§ 3. Affinché la disposizione del Decreto Christus Dominus, n.31, possa essere portata ad effetto, tutti i parroci sono pregati di presentare spontaneamente la rinuncia all'ufficio al loro Vescovo non oltre i 75 anni compiuti. Questi, tenuto conto di tutte le circostanze personali e locali, deciderà se accettarla o differirla. Il Vescovo provveda al conveniente mantenimento e alloggio dei dimissionari.
EREZIONE, SOPPRESSIONE E MODIFICAZIONE DI PARROCCHIE
(Decr. Christus Dominus, n. 32)
21. § 1. Bisogna assolutamente adoperarsi, in modo conveniente alle diverse circostanze, di dividere o smembrare le parrocchie nelle quali, a motivo del troppo grande numero di fedeli o dell'estensione eccessiva del territorio o per qualsiasi altro motivo, l'attività apostolica non può svolgersi che con difficoltà o in modo inadeguato. Parimenti, bisogna raggruppare in una sola le parrocchie troppo piccole, nella misura in cui la realtà lo richieda e le circostanze lo permettano.
§ 2. Nessuna parrocchia verrà più unita di pieno diritto ad un Capitolo di canonici. Se ve ne sono di unite, dopo aver udito il Capitolo e il Consiglio Presbiterale, si separino e si nomini un parroco - scelto o no fra i membri del Capitolo - che abbia tutte le facoltà che spettano ai parroci per diritto.
§ 3. Il Vescovo diocesano può, di propria autorità, dopo aver udito il Consiglio presbiterale, erigere o sopprimere parrocchie o modificarle in qualche modo, ma in modo che, se vi sono convenzioni tra la Sede Apostolica e il Governo civile o dei diritti quesiti di altre persone fisiche o morali, per tali casi l'Autorità competente trovi, d'accordo con gli interessati, la giusta soluzione.
I RELIGIOSI
(Decr. Christus Dominus, nn. 33-35)
22. Le norme che sono qui stabilite valgono per tutti i Religiosi dei due sessi, di qualunque rito siano, restando salvi i diritti dei Patriarchi per gli Orientali.
23. § 1. Tutti i Religiosi, anche esenti, che svolgono l'attività in un luogo in cui non esiste che un solo rito diverso dal loro, o in cui il numero dei fedeli del rito è talmente dominante che esso è considerato come unico secondo l'opinione generale, dipendono dall'Ordinario del luogo o dal Gerarca di questo rito in tutto ciò che riguarda le attività esteriori del ministero, e gli sono sottomessi secondo il diritto.
§ 2. Dove invece esistono più Ordinari del luogo o Gerarchi, questi stessi Religiosi, nel compimento del loro ufficio presso i fedeli di riti diversi, sono tenuti ad osservare le norme date di comune accordo da questi stessi Ordinari e Gerarchi.
24. Benché anche nelle terre di Missione sia in vigore l'esenzione dei Religiosi nel suo legittimo campo, tuttavia le circostanze particolari dell'esercizio del sacro ministero in queste regioni richiedono che siano osservate, secondo lo spirito del Decreto Ad gentes divinitus, gli statuti speciali dati o approvati dalla Sede Apostolica in ciò che concerne le relazioni tra l'Ordinario del luogo e il Superiore dei religiosi, soprattutto in una Missione affidata ad un Istituto determinato.
25. § 1. Tutti i Religiosi, anche esenti, sono tenuti alle leggi, decreti e disposizioni dati dall'Ordinario del luogo circa le diverse opere, in quanto riguardano l'esercizio dell'apostolato, dell'azione pastorale e sociale prescritta o raccomandata dall'Ordinario del luogo.
§ 2. Essi sono parimenti tenuti alle leggi, decisioni ed ordini dati dall'Ordinario del luogo o dalla Conferenza dei Vescovi, concernenti tra l'altro:
a) l'uso pubblico di tutti i mezzi di comunicazione sociale a norma dei nn. 20 e 21 del Decreto Inter mirifica;
b) l'accesso agli spettacoli pubblici;
c) l'iscrizione a società o associazioni, o la collaborazione con esse, che l'Ordinario del luogo o la Conferenza Episcopale hanno dichiarato doversi evitare;
d) l'abito ecclesiastico, restando salvo tuttavia il canone 596 del CIC e il canone 139 del CICO, sui Religiosi, e secondo la disposizione seguente: l'Ordinario del luogo o la Conferenza Episco pale, per evitare il disorientamento dei fedeli, possono proibire ai chierici, sia secolari sia religiosi, anche esenti, di portare l'abito laico in pubblico.
26. Gli stessi Religiosi sono tenuti, inoltre, alle leggi e decreti emanati dal Vescovo del luogo a norma del diritto, concernenti l'esercizio pubblico del culto nelle proprie chiese e oratori pubblici e semipubblici, se i fedeli vi hanno generalmente accesso, restando salvo il loro proprio rito, che essi utilizzano legittimamente solo per la loro comunità, e il loro modo di recitare in coro t'Ufficio Divino e di praticare gli esercizi religiosi che mirano al fine speciale del loro Istituto.
27. § 1. La Conferenza Episcopale di ogni nazione può, dopo aver udito i Superiori religiosi interessati, stabilire norme per la questua, che dovranno essere osservate da tutti gli Ordini e Congregazioni Religiose, senza escludere quelli che, per loro istituzione, portano il nome di mendicanti e lo sono in effetti, restando salvo tuttavia il diritto che hanno questi ultimi di mendicare. § 2. Parimenti, i Religiosi non procederanno alla raccolta di sussidi con pubblica sottoscrizione senza il consenso degli Ordinari del luogo in cui tali sussidi sono raccolti.
28. Le opere proprie o particolari di ciascun istituto, cioè quelle che, con l'approvazione della Sede Apostolica, sono legate alla stessa fondazione o a venerabili tradizioni, e in seguito sono state definite e regolate dalle Costituzioni e dalle altre leggi proprie dell'Istituto, i Religiosi devono promuoverle con zelo, tenendo conto specialmente dei bisogni spirituali delle diocesi e avendo cura di conservare la concordia fraterna con il Clero diocesano e gli altri Istituti che dirigono opere simili.
29. § 1. Le opere proprie o particolari che sono dirette nelle case dell'Istituto, anche nelle case affidate, dipendono dai Superiori di questo Istituto; costoro le dirigono e le amministrano secondo le Costituzioni. Ma tali opere sono sottoposte anche alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, a norma del diritto.
§ 2. Quanto alle opere, anche proprie o particolari di un Istituto, che sono affidate dall'Ordinario del luogo, esse sono sottomesse all'autorità e alla direzione del medesimo Ordinario, restando salvo il diritto che hanno i Superiori religiosi di vegliare sulla vita dei membri, ed anche, congiuntamente con l'Ordinario del luogo, sul compimento dei compiti che sono affidati a tali membri.
30. § l. Per ogni opera di apostolato che sarà affidata dall'Ordinario del luogo a un Istituto, senza pregiudizio delle altre norme del diritto, sarà fatta una convenzione scritta tra l'Ordinario del luogo e il Superiore competente dell'Istituto, nella quale, fra le altre cose, sarà chiaramente definito ciò che riguarda l'opera da compiere, i membri da impegnarvi, e gli elementi di natura economica.
§ 2. Per queste opere poi spetta al Superiore religioso, dopo uno scambio di vedute con l'Ordinario del luogo, di scegliere religiosi veramente idonei, e, se si tratta di affidare una carica ecclesiastica a un Religioso, questi deve essere nominato dall'Ordinario del luogo, su presentazione o almeno con l'assenso del suo Superiore, per un tempo determinato di comune accordo.
31. Anche quando un Ordinario del luogo o una Conferenza Episcopale dovrà conferire un incarico a un Religioso, ciò sia fatto col consenso del suo Superiore e mediante una convenzione scritta.
32. Per una causa grave, ogni religioso può essere rimosso dall'incarico a lui affidato sia a piacimento dell'Autorità che lo affida, dopo aver avvertito il Superiore religioso, sia a piacimento del Superiore dopo aver avvertito l'Autorità che affida l'incarico, secondo un diritto uguale per le due parti, senza che sia richiesto il consenso dell'altra parte; né l'una né l'altra parte è tenuta a comunicare le proprie ragioni e ancor meno a provarle, restando salvo il ricorso alla Sede Apostolica in devolutivo.
33. § 1. L'Ordinario del luogo può, di sua propria autorità, con il consenso del Superiore competente, affidare una parrocchia a un Istituto religioso, anche erigendola in una chiesa religiosa del medesimo Istituto. Questa parrocchia può essere affidata, sia in perpetuo, sia per un tempo determinato. In entrambi i casi si dovrà procedere per convenzione scritta tra l'Ordinario e il Superiore competente dell'Istituto; in essa, tra le altre cose, sarà espressamente ed accuratamente indicato ciò che riguarda l'opera da compiere, le persone da impegnarvi e gli elementi di natura economica.
§ 2. L'Ordinario del luogo può costituire parroco un Religioso con il permesso del Superiore, anche per una parrocchia che non è affidata all'Istituto, dopo aver fatto una convenzione particolare conveniente con il Superiore competente del medesimo Istituto.
34. § 1. Una casa religiosa, formata o non formata, appartenente a un Istituto religioso esente, non può essere soppressa senza il beneplacito della Sede Apostolica e senza che sia stato consultato l'Ordinario del luogo.
§ 2. I Superiori religiosi che intendono sopprimere una casa o un'opera per qualunque ragione, non lo facciano affrettatamente. Si ricordino infatti che incombe a tutti i Religiosi il dovere di lavorare con ardore e sollecitudine non solo all'edificazione e allo sviluppo del Corpo Mistico di Cristo nel suo insieme, ma anche al bene delle Chiese particolari.
§ 3. Quando la soppressione di una casa o di un'opera qualunque è richiesta dai Superiori, soprattutto per mancanza di personale, l'Ordinario del luogo prenderà in considerazione la domanda in modo benevolo.
35. Le associazioni di fedeli che sono poste sotto la guida e la direzione di un Istituto religioso, anche se sono state erette dalla Sede Apostolica, sono sottomesse alla giurisdizione e alla vigilanza dell'Ordinario del luogo, il quale, a norma dei sacri canoni, ha il diritto e il dovere di visitarle. Queste associazioni, se si dedicano ad attività esteriori di apostolato o di promozione del culto divino, devono seguire le prescrizioni emanate su tale materia dall'Ordinario del luogo o dalla Conferenza Episcopale.
36. § 1. L'attività apostolica dei membri degli Istituti di perfezione che non sono votati alla vita puramente contemplativa non sarà circoscritta alle opere proprie dell'Istituto, o ad altre occasionalmente assunte, fino al punto che, in ragione dei bisogni urgenti delle anime o della penuria del Clero, gli Ordinari del luogo non possano chiamare, pur avendo riguardo al carattere proprio di ciascun Istituto e col consenso del Superiore religioso competente, non solo i Sacerdoti ma anche tutti i membri, uomini e donne, perché essi apportino il soccorso della loro attività nei diversi ministeri delle diocesi o delle regioni.
§ 2. Se l'Ordinario del luogo giudica necessario o molto utile l'aiuto dei Religiosi per l'esercizio delle molteplici attività di apostolato e per sostenere le attività della carità o del ministero pastorale nelle parrocchie secolari o nelle associazioni diocesane, i Superiori religiosi, su domanda dell'Ordinario, devono, nella misura del possibile, fornire l'aiuto richiesto.
37. In tutte le chiese e tutti gli oratori pubblici o semipubblici dipendenti da Religiosi, quando questi edifici sono di fatto abitualmente aperti ai fedeli, l'Ordinario del luogo può prescrivere che i documenti episcopali siano letti pubblicamente e che vi si tenga il catechismo, ed altresì che vi sia fatta una colletta speciale per opere determinate, parrocchiali o diocesane, nazionali o universali; questa colletta dovrà essere poi sollecitamente inviata alla Curia Vescovile.
38. L'Ordinario del luogo ha il diritto di visitare le chiese e gli oratori, anche semipubblici, dei Religiosi, anche esenti, se i fedeli vi hanno comunemente accesso, relativamente all'osservanza delle leggi generali e delle decisioni del Vescovo circa il culto divino. Se vi riscontrasse degli abusi e l'avvertimento dato al Superiore religioso restasse senza risultato, l'Ordinario può di propria autorità provvedervi direttamente.
39. § 1. Secondo la norma n. 35, 4 del Decreto Christus Dominus, l'organizzazione generale delle scuole cattoliche degli Istituti religiosi comporta, restando salvo il diritto degli Istituti a dirigere queste scuole e osservate le norme ivi stabilite (n. 35, 5) circa la previa intesa a cui devono pervenire i Vescovi e i Superiori religiosi, la distribuzione generale di tutte le scuole cattoliche nella diocesi, la loro collaborazione reciproca e la sorveglianza su di esse affinché non siano meno idonee delle altre scuole a perseguire i fini culturali e sociali.
§ 2. L'Ordinario del luogo può visitare, a norma dei sacri canoni, personalmente o tramite un suo delegato, tutte le scuole degli Istituti religiosi, i collegi, oratori, ricreatori, patronati, ospedali, orfanatrofi e altre istituzioni simili destinate ad opere religiose o caritative, sia spirituali che temporali, ad eccezione delle scuole interne che sono aperte solo agli alunni propri dell'Istituto.
40. Le norme relative all'introduzione dei religiosi nelle opere e nei ministeri diocesani, che devono essere esercitati sotto la direzione dei Vescovi, vanno applicate, con gli opportuni adattamenti, anche alle opere e ai ministeri che oltrepassano i limiti di una diocesi.
LE CONFERENZE EPISCOPALI
(Decr. Christus Dominus, n. 38)
41. § 1. I Vescovi delle nazioni o dei territori nei quali la Conferenza Episcopale non esiste ancora, a norma del Decreto Christus Dominus, provvederanno a costituirla il più presto possibile e a redigerne gli Statuti che dovranno essere rivisti dalla Sede Apostolica.
§ 2. Le Conferenze Episcopali già costituite devono redigere i propri Statuti, secondo le prescrizioni del Concilio, o, se li hanno già redatti, li aggiornino secondo lo spirito dello stesso Concilio e li mandino alla Sede Apostolica per la revisione.
§ 3. I Vescovi delle nazioni nelle quali è difficile costituire una Conferenza, d'intesa con la Sede Apostolica, dovranno unirsi alla Conferenza che meglio si accorda con le esigenze dell'apostolato della loro nazione.
§ 4. Le Conferenze Episcopali di più nazioni o internazionali non possono costituirsi che con l'approvazione della Sede Apostolica, cui spetta fissarne le norme particolari. Ogni volta che attività o relazioni aventi di per sé aspetto internazionale vengono intraprese dalle Conferenze, la Santa Sede deve esserne precedentemente avvertita.
§ 5. Relazioni tra Conferenze Episcopali, soprattutto di nazioni vicine, potranno essere stabilite in modo opportuno e adeguato attraverso i Segretariati di tali Conferenze. Esse potranno tra l'altro:
a) comunicare i metodi principali d'azione soprattutto nel campo dell'attività pastorale;
b) trasmettere gli scritti o i fogli che riportano le decisioni della Conferenza, o ancora gli atti e i documenti che i Vescovi pubblicano di comune accordo;
c) fare conoscere le diverse iniziative di apostolato proposte o raccomandate dalla Conferenza Episcopale e tutto ciò che potrebbe essere utile in casi analoghi;
d) presentare i problemi più gravi che paiono essere di maggior importanza nell'ora presente e in circostanze particolari;
e) indicare i pericoli o errori che si diffondono nella propria nazione e che potrebbero sorgere anche presso altri popoli, perché si possano prendere le disposizioni opportune e atte per prevenirli, o estirparli, o limitarli, e altre cose simili.
CIRCOSCRIZIONI DELLE PROVINCE E DELLE REGIONI ECCLESIASTICHE
(Decr. Christus Dominus, nn. 39-41)
42. Le Conferenze dei Vescovi esamineranno attentamente se per promuovere maggiormente il bene delle anime nel territorio: a) non sia richiesta una più approfondita delimitazione delle province ecclesiastiche; b) se non sia consigliabile l'erezione di regioni ecclesiastiche. In caso affermativo esse presenteranno alla Sede Apostolica i motivi per i quali dovrebbero essere stabilite di diritto la revisione della delimitazione delle province e l'erezione delle regioni. Inoltre esse faranno conoscere alla Santa Sede le modalità secondo cui dovrebbero essere aggregate le diocesi del territorio che sono state fino ad ora immediatamente soggette alla Sede Apostolica.
REDAZIONE DEI DIRETTORI PASTORALI
(Decr. Christus Dominus, n. 44)
43. In ciò che concerne i Direttori di pastorale, i Sinodi Patriarcali e le Conferenze Episcopali sono pregati di studiare rapidamente quali sono i problemi di cui dovranno trattare i Direttori generali e speciali e di comunicare quanto prima alla Sede Apostolica i loro desideri e pareri.
II. NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO
«PERFECTAE CARITATIS» DEL CONCILIO VATICANO II
Perché i frutti del Concilio possano diligentemente giungere a maturazione, bisogna che gli Istituti religiosi promuovano anzitutto uno spirito nuovo e, partendo di qui, che essi abbiano a cuore di realizzare con prudenza certo, ma anche con premura, l'opportuno rinnovamento della vita e della disciplina, dandosi assiduamente allo studio in particolare della Costituzione dogmatica Lumengentium (cap. V e VI) e del Decreto Perfectae caritatis, e dando applicazione all'insegnamento e alle norme del Concilio.
In vista della rapida applicazione del Decreto Perfectae caritatis, le Norme seguenti, valide per tutti i religiosi, latini e orientali, facendo gli adattamenti necessari, fissano il modo di procedere e qualche prescrizione.
Parte I
Norme per promuovere un adeguato rinnovamento
della vita religiosa
I. Chi deve promuovere il rinnovamento adeguato
1. Nel rinnovamento e nell'adattamento della vita religiosa, la parte principale spetta agli Istituti stessi che la realizzeranno soprattutto attraverso i Capitoli generali o, presso gli Orientali, attraverso le Sinassi. Il ruolo dei Capitoli non si esaurisce nella sola promulgazione delle leggi, ma si compie promovendo anche la vitalità spirituale e apostolica.
2. È necessaria la collaborazione di tutti, Superiori e membri, per rinnovare la vita religiosa in loro stessi, per preparare lo spirito dei Capitoli, per adempiere il loro compito, e perché le leggi e le norme promulgate dai capitoli siano fedelmente osservate.
3. Per promuovere il rinnovamento adeguato in ciascun Istituto, uno speciale Capitolo generale, ordinario o straordinario, sarà riunito nello spazio di due o al massimo tre anni. Questo Capitolo potrà essere diviso in due periodi distinti, separati da un intervallo che non supererà in generale un anno, se così il Capitolo stesso avrà deciso a votazione segreta.
4. In preparazione di questo Capitolo, il Consiglio generale organizzerà con cura una consultazione ampia e libera dei membri e classificherà opportunamente i risultati di questa consultazione per aiutare e dirigere il lavoro del Capitolo. E ciò potrà essere realizzato, per esempio, ascoltando i Capitoli conventuali e provinciali, costituendo commissioni, proponendo serie di quesiti, ecc.
5. Per i Monasteri stauropegiaci è compito del Patriarca emanare le norme per realizzare questa consultazione.
6. Questo Capitolo generale ha il potere di modificare, a titolo di esperimento, certe prescrizioni delle Costituzioni o, presso gli Orientali, delle Tipiche, purché siano rispettati il fine, la natura e il carattere dell'Istituto. Esperienze contrarie al diritto comune, ma fatte con prudenza, saranno, secondo l'opportunità, autorizzate volentieri dalla Santa Sede.
Queste esperienze possono protrarsi fino al prossimo Capitolo generale ordinario, il quale avrà la facoltà di prolungarle, ma non oltre il Capitolo immediatamente seguente.
7. Della stessa facoltà, per il periodo di tempo che separa questi due Capitoli, alle condizioni che questi dovranno determinare, godrà il Consiglio generale e, presso gli Orientali nei Monasteri autonomi, l'Igumeno con la piccola Sinassi.
8. L'approvazione definitiva delle Costituzioni è riservata all'Autorità competente.
9. Per quanto concerne la revisione delle Costituzioni di Monache, ogni Monastero in forma capitolare o addirittura ciascuna Monaca, esprimerà i suoi voti che saranno raccolti dall'Autorità suprema dell'Ordine, se essa esiste, e ciò in vista di salvaguardare l'unità della famiglia religiosa, secondo il carattere proprio di ciascuna di queste famiglie. Se non c'è autorità suprema, questi voti saranno raccolti dal Delegato della Santa Sede e, presso gli Orientali, dal Patriarca o dal Gerarca del luogo. Voti e pareri potranno essere ottenuti anche dalle assemblee delle Federazioni o da altre riunioni legittimamente convocate. La sollecitudine pastorale dei Vescovi rechi anche in questo un benevolo aiuto.
10. Se nei Monasteri di Monache alcuni esperimenti temporanei fossero a volte giudicati opportuni in materia di osservanza, essi potranno essere autorizzati dai Superiori generali o dai Delegati della Santa Sede e, presso gli Orientali, dal Patriarca o dal Gerarca del luogo; ma si terrà conto della mentalità particolare o dello stato d'animo delle monache che hanno bisogno soprattutto di stabilità e di sicurezza.
11. È compito delle Autorità di cui si è parlato sopra provvedere, dopo la consultazione e con l'aiuto dei Monasteri, alla revisione del testo delle Costituzioni e presentarlo all'approvazione della Santa Sede o del Gerarca competente.
II Revisione delle Costituzioni e delle Tipiche
12. Per ogni Istituto le leggi generali (Costituzioni, Tipiche, Regole o comunque si chiamino) abbracceranno ordinariamente i seguenti elementi:
a) Principi evangelici e teologici della vita religiosa e dell'unione di questa con la Chiesa ed espressioni adatte e sicure grazie alle quali u si interpretino e si osservino lo spirito e le finalità proprie dei Fondatori, come pure le sane tradizioni: tutto ciò costituisce il patrimonio di ciascun Istituto» (Decr. Perfectae caritatis, n. 2 b);
b) le norme giuridiche necessarie per definire chiaramente il carattere, i fini e i mezzi dell'Istituto. Queste norme non devono essere eccessivamente moltiplicate, ma devono sempre essere espresse in modo adeguato.
13. L'unione di questi due elementi, spirituale e giuridico, è necessaria perché i testi fondamentali dell'Istituto abbiano una base stabile e perché il vero spirito e la norma vitale li penetrino; bisogna dunque guardarsi dal comporre un testo o solo giuridico o di pura esortazione.
14. Si escludano dal testo fondamentale degli Istituti gli elementi già caduti in disuso, o soggetti a mutazioni secondo i costumi di ciascuna epoca, o che rispondono a consuetudini puramente locali. Le norme che corrispondono all'epoca attuale, alle condizioni fisiche e psicologiche dei membri, e a circostanze particolari, saranno poste in testi annessi, chiamati «direttori», libri di usanze, o con altri nomi.
III. Criteri di rinnovamento adeguato
15. Le norme e lo spirito ai quali bisogna che risponda il rinnovamento adeguato, devono essere cercati non solo nel Decreto Perfectae caritatis, ma anche negli altri documenti del Concilio Vaticano II, in particolare nei capitoli V e VI della Costituzione dogmatica Lumen gentium.
16. Gli Istituti avranno cura che i principi stabiliti nel n. 2 del Decreto Perfectae caritatis guidino realmente il rinnovamento della loro vita religiosa; per cui:
§ 1. Lo studio e la meditazione dei Vangeli e di tutta la Sacra Scrittura siano promossi più intensamente presso i membri, fin dal noviziato; parimenti bisogna fare in modo che partecipino con mezzi più adeguati al mistero e alla vita della Chiesa;
§ 2. La dottrina della vita religiosa sia studiata e presentata sotto i diversi aspetti (teologico, storico, canonico, ecc.);
§ 3. Per procurare il bene stesso della Chiesa, gli Istituti perseverino nello sforzo di conoscere esattamente il loro spirito d'origine, affinché, mantenendolo fedelmente negli adattamenti che dovranno fare, la loro vita religiosa sia purificata dagli elementi estranei e da quelli caduti in disuso.
17. Bisogna considerare caduti in disuso gli elementi che non costituiscono la natura e i fini dell'Istituto e che, avendo perduto il loro senso e la loro forza, non aiutano più realmente la vita religiosa; si terrà fermo tuttavia che c'è una testimonianza che lo stato religioso ha il dovere di portare.
18. Il metodo di governo sarà tale che «i Capitoli e i Consigli... ciascuno a suo modo, esprimano la partecipazione e l'interesse di tutti i membri al bene di tutta la comunità» (Decr. Perfectae caritatis, n. 14), il che avverrà in particolare se i religiosi avranno un ruolo veramente efficace nella scelta dei membri di questi organi; parimenti, che renda l'esercizio dell'autorità più efficace e più agevole, secondo le esigenze dell'epoca attuale. Perciò i Superiori di tutti i gradi saranno dotati di facoltà opportune, in modo da non moltiplicare i ricorsi inutili o troppo frequenti alle autorità superiori.
19. Il rinnovamento adeguato del resto non può essere realizzato una volta per tutte, ma deve essere attuato continuamente in un certo senso, attraverso il fervore dei membri e la preoccupazione dei Capitoli e dei Superiori.
Parte II
Alcuni elementi da adattare e da rinnovare nella vita religiosa
I. L'ufficio divino dei Religiosi e delle Religiose
(Decr. Perfectae caritatis, n. 3)
20. Benché i religiosi che recitano il piccolo Ufficio debitamente approvato abbiano parte nella preghiera pubblica della Chiesa (cf Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 98), si raccomanda agli Istituti di recitare t'Ufficio divino in parte o integralmente al posto del piccolo Ufficio, al fine di partecipare più intimamente alla vita liturgica della Chiesa. I membri Orientali recitino le dossologie e le Lodi divine secondo le loro Tipiche e le loro Consuetudini.
II. L'Orazione mentale (Decr. Perfectae caritatis, n. 6)
21. Perché i religiosi partecipino più intimamente e con più frutto al sacrosanto mistero dell'Eucaristia e alla preghiera pubblica della Chiesa, e perché tutta la loro vita spirituale sia più abbondantemente nutrita, si sostituirà la molteplicità delle preghiere con un maggiore tempo dedicato alla preghiera mentale, mantenendo tuttavia i pii esercizi comunemente accolti nella Chiesa, e vegliando che i membri siano formati con cura nelle vie della vita spirituale.
III. La Mortificazione (Decr. Perfectae caritatis, nn. 5 e 12)
22. I Religiosi più degli altri fedeli si diano alle opere di penitenza e di mortificazione. Gli Istituti rivedano, se è necessario, le loro proprie osservanze penitenziali, in modo che, tenuto conto delle tradizioni, sia dell'Oriente, sia dell'Occidente, e altresì delle condizioni attuali, i loro membri possano realmente praticarle, anche in forme nuove improntate al modo di vita attuale.
IV. La Povertà (Decr. Perfectae caritatis, n. 13)
23. Gli Istituti, specialmente ad opera dei Capitoli generali, favoriscano con cura e con misure concrete lo spirito e la pratica della povertà secondo il n. 13 del Decreto Perfectae caritatis, cercando anche e instaurando, secondo il carattere loro proprio, nuove forme che rendano più efficace nel nostro tempo l'esercizio e la testimonianza della povertà.
24. Spetta agli stessi Istituti di voti semplici decidere in Capitolo generale se la rinuncia ai beni patrimoniali, acquisiti o acquisibili, deve essere introdotta nelle Costituzioni e, in questo caso, se essa deve essere obbligatoria o facoltativa, e il tempo in cui dovrà essere fatta, cioè prima della professione perpetua o dopo diversi anni.
V. La Vita da condurre in comune (Decr. Perfectae caritatis, n. 15)
25. Negli Istituti dediti alle opere di apostolato, la vita comune, che è così importante perché i membri, come una famiglia unita nel Cristo, intrattengano relazioni fraterne, dovrà essere favorita ad ogni costo nel modo che è conforme alla vocazione dell'Istituto.
26. Spesso l'orario quotidiano in questi Istituti non può essere identico in tutte le case, né a volte per tutti i membri in una stessa casa. Ma esso deve sempre essere stabilito in modo tale che i religiosi dispongano, oltre al tempo consacrato alla vita spirituale e ai loro impegni, di un po' di tempo per se stessi, e possano godere della ricreazione conveniente.
27. I Capitoli generali e le Sinassi cercheranno il modo in forza del quale i membri chiamati conversi, cooperatori, o con altro nome, possano ottenere per gradi il diritto di voto attivo in determinati atti della comunità e nelle elezioni e anche di voto passivo per certi incarichi; in questo modo avverrà veramente che essi siano più strettamente uniti alla vita e alle attività della comunità e che i sacerdoti possano dedicarsi più liberamente ai propri ministeri.
28. Nei Monasteri in cui si sarà giunti a un solo tipo di Monache, le obbligazioni corali siano definite nelle Costituzioni, tenendo conto della diversità delle persone, come esige la distinzione dei compiti e delle vocazioni speciali.
29. Le suore dedite al servizio esterno dei Monasteri, dette oblate o designate con qualche altro nome, avranno regolamenti particolari, nei quali si terrà conto della loro vocazione che non è solo contemplativa, e altresì delle esigenze della vocazione delle Monache con le quali esse vivono in stretta relazione, benché non siano monache.
La superiora del Monastero ha l'obbligo grave di prendersi premurosa cura di loro, di procurare loro la formazione religiosa adeguata, di trattarle con vera carità e di favorire il legame della fraternità fra loro e la comunità delle Monache.
VI. La Clausura delle Monache (Decr. Perfectae caritatis, n. 16)
30. La clausura papale dei Monasteri deve essere considerata come un'istituzione ascetica singolarmente coerente con la vocazione particolare delle monache, e come il segno, la protezione e la forma speciale del loro ritiro dal mondo.
Le Monache dei riti Orientali osserveranno la loro propria clausura nello stesso spirito.
31. Questa clausura deve essere sistemata in modo che la separazione materiale da tutto ciò che è esterno sia sempre assicurata. Ma ogni Famiglia religiosa, secondo il suo spirito specifico, può stabilire e definire nelle sue Costituzioni le norme particolari di questa separazione materiale.
32. La clausura minore è soppressa. Di conseguenza le Monache che per istituzione si dedicano ad attività esterne, definiranno nelle Costituzioni la propria clausura. Ma le Monache che hanno assunto attività esterne, mentre sono contemplative per istituzione, dopo un tempo conveniente che sarà loro accordato perché possano deliberare, dovranno o abbandonare le attività esterne e prendere la clausura papale, o, se conservano queste attività, definire nelle Costituzioni la clausura loro propria, ferma restando la loro condizione di Monache.
VII. La Formazione dei Religiosi (Decr. Perfectae caritatis, n. 18)
33. La formazione dei membri non sarà regolata nella stessa maniera in tutti gli Istituti fin dal noviziato, ma sarà tenuto conto del carattere proprio di ciascun Istituto. Nella sua revisione e adattamento si dia spazio sufficiente all'esperienza, secondo prudenza.
34. Quanto è fissato nel Decreto Optatam totius (sulla formazione dei sacerdoti) dovrà essere osservato fedelmente nel metodo di formazione dei religiosi chierici, dopo essere stato convenientemente adattato al carattere di ciascun Istituto.
35. Il proseguimento della formazione dopo il noviziato, in modo adeguato a ciascun Istituto, è assolutamente indispensabile per tutti i religiosi, anche per i contemplativi; per i fratelli delle Congregazioni laicali e le suore d'Istituti dedicati all'apostolato essa sia protratta generalmente per tutta la durata dei voti temporanei, come già avviene in molti Istituti, sotto il nome di iuniorato o scolasticato o altro.
36. Questa formazione sarà data in case adatte e, perché essa non sia semplicemente teorica, sarà completata con l'esercizio, a titolo di addestramento, di attività o di incarichi conformi al carattere e alle circostanze particolari di ciascun Istituto, in modo che i membri s'inseriscano gradualmente nella vita che più tardi dovranno condurre.
37. Quando degli Istituti non possono ciascuno per suo conto fornire una sufficiente formazione, dottrinale o tecnica, vi si potrà supplire mediante la collaborazione fraterna di più congregazioni, salvaguardando sempre la formazione propria a ciascuna. Questa collaborazione può avere forme e gradi diversi: lezioni o corsi comuni, prestiti di professori e persino raggruppamenti di questi ultimi e contribuzione ad una scuola comune frequentata dai membri di più Istituti. Gli Istituti che hanno i mezzi necessari aiuteranno volentieri gli altri.
38. Dopo aver compiuto le esperienze necessarie, spetterà a ciascun Istituto redigere le norme proprie che convengono alla formazione dei suoi membri.
VIII. Unione e Soppressione di Istituti (Decr. Perfectae caritatis, nn. 21-22)
39. La promozione di una qualsiasi unione tra Istituti suppone una conveniente preparazione spirituale, psicologica, giuridica, nello spirito del Decreto Perfectae caritatis. A tal fine sarà spesso opportuno che un Assistente, approvato dall'Autorità competente, aiuti gli Istituti.
40. Nei suddetti casi e circostanze, bisogna mirare al bene della Chiesa, tenuto conto tuttavia del carattere proprio di ciascun Istituto e della libertà di ciascuno dei membri.
41. Fra i criteri che possono concorrere a determinare un giudizio riguardo la soppressione di un Istituto o di un Monastero, dopo aver vagliato tutte le circostanze, si porrà attenzione soprattutto ai seguenti punti nel loro insieme: il piccolo numero di religiosi relativamente agli anni d'esistenza, la mancanza di candidati da parecchi anni, l'età avanzata della maggior parte dei membri. Se si arriva a decidere la soppressione, bisogna provvedere che il gruppo sia aggregato, «se sarà possibile, a un altro Istituto o Monastero più fiorente che non molto differisca nelle finalità e nello spirito» (Decr.Perfectae caritatis, n. 21). Prima sia udito ogni religioso e tutto si faccia nella carità.
IX. Conferenze o Unioni dei Superiori e delle Superiore Maggiori (Decr. Perfectae caritatis, n. 23)
42. Bisognerà procurare che l'unione dei Superiori generali e l'unione delle Superiore generali possano essere ascoltate e consultate attraverso un Consiglio costituito presso la Sacra Congregazione dei Religiosi.
43. È della massima importanza che le Conferenze o Unioni nazionali dei Superiori e delle Superiore Maggiori collaborino con le Conferenze Episcopali nella fiducia e nel rispetto (cf Decr.Christus Dominus, n. 35, 5; Decr. Ad gentes divinitus 33). È perciò auspicabile che le questioni concernenti l'una e l'altra parte siano trattate da Commissioni miste, costituite di Vescovi e di Superiori o Superiore Maggiori.
Conclusione
44. Queste norme, che varranno per i Religiosi della Chiesa universale, lasciano intatte le leggi generali della Chiesa, sia della Chiesa Latina sia delle Chiese Orientali, come pure le leggi proprie degli Istituti religiosi, a meno che non vi apportino esplicitamente o implicitamente delle modifiche.
III. NORME PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO
«AD GENTES DIVINITUS»
DEL CONCILIO VATICANO II
Poiché il Decreto del Sacro Concilio Vaticano II Ad gentes divinitus (sull'attività missionaria della Chiesa) deve essere fedelmente osservato da tutti, in modo che tutta la Chiesa si faccia realmente missionaria e tutto il Popolo di Dio sia cosciente del suo dovere missionario, gli Ordinari del luogo facciano in modo che tutti i fedeli cristiani conoscano il Decreto: si tengano conferenze al clero sullo stesso e lo si predichi al popolo al fine di illustrare e inculca re la comune responsabilità di coscienza sull'attività missionaria.
Al fine di facilitare e rendere più fedele l'applicazione del Decreto, si stabilisce quanto segue:
1. La teologia della Missione sia inserita nell'insegnamento della dottrina teologica in modo tale che nella sua progressiva evoluzione di forma appaia in piena luce la natura missionaria della Chiesa. Si faccia inoltre attenzione alle vie del Signore le quali preparano l'evangelizzazione e la possibilità di salvezza dei non evangelizzati, inculcando la necessità dell'evangelizzazione e dell'incorporazione alla Chiesa (Ad gentes divinitus, cap. 1).
Quanto è stato detto deve essere tenuto nel debito conto per organizzare rettamente e ordinatamente gli studi nei Seminari e nelle Università (n. 39).
2. Si invitano le Conferenze Episcopali a proporre al più presto alla Santa Sede i quesiti più generali relativi alle Missioni, affinché possano essere studiati nella prossima assemblea del Sinodo dei Vescovi (n. 29).
3. al fine di intensificare lo spirito missionario nel popolo cristiano, si raccomandino orazioni e sacrifici quotidiani, in modo che la celebrazione dell'annuale giornata missionaria sia una spontanea manifestazione di quello spirito (n. 36).
I Vescovi e le Conferenze Episcopali redigeranno diverse invocazioni a favore delle Missioni per poi inserirle nell'Orazione dei Fedeli durante la Messa.
4. In ciascuna diocesi sia designato un sacerdote per promuovere efficacemente l'attività in favore delle missioni; questi dovrà anche far parte del Consiglio pastorale della diocesi (n. 38).
5. al fine di promuovere lo spirito missionario, si devono stimolare gli alunni dei Seminari e i giovani delle associazioni cattoliche affinché stabiliscano e mantengano contatti con gli alunni dei Seminari e di associazioni similari delle missioni, in modo che la mutua conoscenza accresca la coscienza missionaria ed ecclesiale nel popolo cristiano (n. 38).
6. I Vescovi, compenetrati della grande urgenza dell'evangelizzazione del mondo, favoriscano le vocazioni missionarie tra i propri chierici e giovani, e procurino di dar mezzi e opportunità agli Istituti che lavorano nelle missioni affinché facciano conoscere nella diocesi le necessità delle missioni e suscitino vocazioni (n. 38).
Nello stimolare le vocazioni per le missioni deve proporsi diligentemente tanto la missione della Chiesa verso tutte le nazioni come i modi nei quali gli uni e gli altri (Istituti, sacerdoti, religiosi e laici di ambo i sessi) si sforzano di realizzarla. Va sottolineata e illustrata con esempi soprattutto la speciale vocazione missionaria a vita (nn. 23 e 24).
7. Siano promosse in tutte le diocesi le Pontificie Opere Missionarie, osservandone fedelmente gli statuti, in particolare per quanto si riferisce all'invio dei sussidi (n. 38).
8. Poiché le offerte date spontaneamente dai fedeli per le missioni non bastano in alcun modo, si raccomanda di fissare quanto prima per ciascuna diocesi, parrocchia e ogni altra comunità diocesana la consegna di una determinata quota annuale, secondo le rispettive disponibilità, la quale dovrà essere distribuita dalla Santa Sede, senza pregiudizio per l'integrità delle altre offerte dei fedeli (n. 38).
9. In seno alle Conferenze Episcopali ci sia una Commissione episcopale per le missioni, incaricata di incrementare l'attività e la coscienza missionaria e una coerente disponibilità alla cooperazione tra le diocesi; di mantenere rapporti con le altre Conferenze Episcopali e di escogitare il modo di procurare diligentemente l'equità nell'aiuto alle missioni (n. 38).
10. Gli Istituti missionari rimangono quanto mai necessari, poiché si deve riconoscere che ad essi è affidato dalle Autorità ecclesiastiche il compito di assolvere il dovere missionario di tutto il Popolo di Dio (n. 27).
11. I Vescovi devono servirsi anche degli Istituti missionari per accendere nei fedeli lo zelo per le missioni, offrendo inoltre loro la possibilità, nei limiti di un giusto ordine, di suscitare e coltivare vocazioni di giovani per le missioni e di organizzare questue (nn. 23, 37 e 38).
Al fine di conseguire maggiore unità ed efficacia, i Vescovi si servano del Consiglio Nazionale o Regionale delle Missioni, del quale faranno parte i Direttori delle Pontificie Opere missionarie e degli Istituti missionari esistenti nella Nazione o Regione.
12. Ogni Istituto missionario deve provvedere al più presto possibile ad un suo opportuno rinnovamento tanto per ciò che riguarda i metodi di evangelizzazione e di iniziazione cristiana (nn. 13 e 14), quanto per ciò che riguarda la norma di vita delle comunità (Decr. Perfectae caritatis, n. 3).
13. § 1. È necessario che per tutte le missioni vi sia un solo dicastero competente, e cioè la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede. Però, poiché alcune missioni per particolari ragioni dipendono temporaneamente da altri Dicasteri, si deve nel frattempo istituire in tali Dicasteri una sezione missionaria, la quale sia in stretti rapporti con la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede affinché possa darsi una condotta e norma del tutto costante e uniforme nell'ordinamento e direzione di tutte le missioni (n. 29).
§ 2. Dalla Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede dipendono le Pontificie Opere Missionarie, e precisamente la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, l'Opera di san Pietro apostolo per il clero indigeno, l'Unione del clero per le missioni e l'Opera della santa Infanzia.
14. Il Presidente del Segretariato per l'unità dei Cristiani, in virtù del suo ufficio, è membro della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede; il segretario dello stesso Segretariato fa parte del gruppo dei consultori della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede (n. 29).
Similmente, la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede deve essere rappresentata in seno al Segretariato per l'Unità dei Cristiani.
15. Parteciperanno con voto deliberativo alla direzione della Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede ventiquattro rappresentanti, salvo che il Sommo Pontefice determini altrimenti caso per caso; precisamente: dodici Prelati delle missioni, quattro delle altre regioni; quattro Superiori Generali di Istituti; quattro delle Opere Pontificie, i quali dovranno essere tutti convocati due volte all'anno. I membri di tale commissione sono nominati per un quinquennio, e ogni anno si rinnoverà quasi la quinta parte degli stessi. Terminato il mandato potranno essere nominati per un altro quinquennio.
Le Conferenze Episcopali, gli Istituti e le Opere Pontificie, seguendo le norme che la Santa Sede comunicherà quanto prima, debbono proporre al Sommo Pontefice i nomi dei candidati, tra i quali lo stesso Sommo Pontefice eleggerà i menzionati rappresentanti, come pure i nomi di quelli, anche se vivono nelle missioni, tra i quali possono scegliersi i consultori.
16. I rappresentanti degli Istituti religiosi nelle missioni e delle Opere regionali al servizio delle missioni, come pure delle Organizzazioni dei laici, soprattutto internazionali, parteciperanno alle sessioni di questo Dicastero con voto consultivo (n. 29).
17. La Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede, dopo aver consultato le Conferenze Episcopali e gli Istituti missionari, fissi al più presto i principi generali in base ai quali stabilire le convenzioni tra gli Ordinari del luogo e gli Istituti missionari, per regolare i loro mutui rapporti (n. 32).
In tali convenzioni si tenga presente tanto la continuazione dell'opera missionaria come le necessità degli Istituti (n. 32).
18. È desiderabile che le Conferenze Episcopali nelle Missioni si riuniscano in assemblee organiche corrispondenti alle citate zone socio-culturali (cf il precedente n. 9) e pertanto la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede (n. 29) promuova questo coordinamento delle Conferenze Episcopali.
Spetta a tali Conferenze, congiuntamente alla Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede:
1°. Cercare i modi anche nuovi mediante i quali i fedeli cristiani e gli Istituti missionari, con unione di forze, devono inserirsi nei popoli o gruppi con i quali convivono o ai quali sono stati inviati (nn. 10 e 11) e con i quali si deve attuare il colloquio della salvezza.
2°. Istituire gruppi di esperti che studino la concezione dei popoli sull'universo e sull'uomo, la loro mentalità verso Dio, e diano prospettiva teologica (n. 22) a quanto vi è di buono e di vero.
Questo studio teologico servirà come necessario fondamento per realizzare gli adattamenti, compito anche questo al quale devono dedicarsi quei gruppi di esperti. Tali adattamenti devono riguardare tra l'altro i metodi di evangelizzazione, le forme liturgiche, la vita religiosa e la legislazione ecclesiastica (n. 19).
Al fine di perfezionare i metodi dell'evangelizzazione e della catechesi (nn. 11, 13 e 14), la Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede promuova una stretta cooperazione tra i principali Istituti Pastorali.
In quanto alle forme liturgiche, i gruppi di esperti dovranno inviare documenti e suggerimenti al Consiglio incaricato di applicare la Costituzione sulla Liturgia.
E quanto allo stato religioso (n. 18), ci si deve guardare dal prestare maggiore cura alla forma esteriore (ad es. il gesto, il vestito, le arti, ecc.) che non a far propria l'indole religiosa dei popoli e all'assimilare la perfezione evangelica.
3°. Promuovere nei Seminari, in determinati momenti, riunioni di Professori per adattare l'orientamento e il programma degli studi e per il reciproco scambio di informazioni, sentito il parere dei gruppi di esperti già citati, al fine di provvedere alle attuali necessità della formazione sacerdotale (n. 16).
4°. Studiare il modo più adatto di distribuire le forze nel territorio (sacerdoti, catechisti, Istituti, ecc.), soprattutto per ovviare alla mancanza di forze nelle località ove esistono comunità più numerose.
19. Nella distribuzione dei sussidi dovrà essere riservata ogni anno una congrua parte alla formazione e al sostentamento tanto del clero locale, dei missionari e dei catechisti, come pure dei gruppi di esperti citati al n. 18. I Vescovi invieranno relazioni di tutto ciò alla Sacra Congregazione per la Propagazione della Fede (nn. 17, 29).
20. Si costituisca debitamente il Consiglio Pastorale; al quale spetta, secondo il n. 27 del DecretoChristus Dominus, «studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre pratiche conclusioni», e anche cooperare alla preparazione del Sinodo diocesano e curare l'applicazione degli Statuti del Sinodo (n. 30).
21. Nelle missioni si fondino Conferenze di Religiosi e Unioni di Religiose alle quali prendano parte i Superiori Maggiori di tutti gli Istituti della stessa nazione o regione, e mediante le quali si coordinino le loro attività (n. 33).
22. Si moltiplichino nelle missioni, secondo la possibilità e la necessità, gli istituti scientifici i quali devono agire di comune accordo, per coordinare rettamente i lavori di indagine e di specializzazione, evitando così che nella stessa regione appariscano opere similari (n. 34).
23. Perché i Vescovi delle nazioni di antica cristianità accolgano come si deve gli immigrati dai territori di missione e li aiutino con una conveniente cura pastorale, è necessaria la cooperazione con i Vescovi delle missioni (n. 38).
24. Quanto ai laici nelle missioni:
§ 1. Si esiga la sincera intenzione di servire le missioni, maturità, preparazione idonea, specializzazione professionale e un conveniente periodo di permanenza in missione.
§ 2. Siano coordinate efficacemente tra loro le organizzazioni dei laici nelle missioni.
§ 3. Il Vescovo del luogo di missione si interessi con sollecitudine di questi laici.
§ 4. Si garantisca la sicurezza sociale di questi laici (n. 41).
PER SCARICARE LA LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO "ECCLESIAE SANCTAE" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
QUO APTIUS
CON LA QUALE
VENGONO TRASFERITE
LE FUNZIONI
DELLA CANCELLERIA APOSTOLICA
ALLA SEGRETERIA DI STATO
I Sommi Pontefici, allo scopo di far meglio corrispondere i servizi della Curia Romana alle necessità della Chiesa, ebbero la costante preoccupazione di ben ordinarli, di trasformarli in maniera opportuna e di fondarne anche di nuovi. Né fu diverso il Nostro intendimento, allorché, concluso il Concilio Ecumenico Vaticano II, con la Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae, decidemmo il riordinamento generale della Curia Romana, per renderla più conforme ai tempi moderni (Cf AAS 59 (1967), pp. 885ss.). Un tale lavoro, come per impulso del dinamismo ecclesiale, è stato successivamente in parte ritoccato e perfezionato, e di ciò si ha la prova sia nell'istituzione delle due Congregazioni per il Culto Divino e per le Cause dei Santi, derivate entrambe dall'antica Sacra Congregazione dei Riti, sia nella più recente creazione di nuovi organismi o enti (Cost. Ap. Sacra Rituum Congregatio: AAS 61 (1969), pp. 297ss; Lett. Ap. Apostolicae caritatis, in forma di Motu proprio, con la quale è stata istituita la Commissione per la pastorale dei migranti e degli itineranti: AAS 62 (1970), pp. 193 ss.; Lettera Amoris officio, con la quale è stato istituito il Pontificio Consiglio «Cor Unum» per promuovere il progresso umano e cristiano in Roma: AAS 63 (1971), pp. 669ss; nello stesso anno è stato istituito il Comitato per la Famiglia: AAS 65 (1973), pp. 60-61). Noi crediamo che un simile criterio valga ora per la Cancelleria Apostolica, un'istituzione, questa, tanto illustre ed antica, la quale ebbe un tempo, nell'ambito della Curia Romana, un posto di primaria importanza e prestò ai Romani Pontefici una qualificata collaborazione.
Difatti, al pari di qualsiasi altra autorità, anche il governo della Chiesa già nell'età più antica e in rapporto ai crescenti impegni del suo servizio, aveva sempre più bisogno di aiutanti per il disbrigo degli affari, soprattutto per la corrispondenza epistolare e per la redazione, la spedizione e la conservazione degli atti ufficiali. Gli uomini, addetti a questo compito, si chiamavano notari escriniarii e, senza speciale differenziazione, per quanto fossero riuniti in collegio, durante il periodo dell'alto medioevo, erano veri funzionari della Chiesa Romana.
Essendosi, poi, verificato un ulteriore accrescimento di queste incombenze, che oggi potremmo dire di «segreteria generale del Sommo Pontefice» si costituì fin dal secolo XI un Ufficio di carattere autonomo, il quale era diretto da un capo, denominato Bibliotecario, Cancelliere, Vicecancelliere, ed aveva un certo numero di collaboratori. Compiti di questo Ufficio, che fu appunto chiamato Cancelleria Apostolica, erano la preparazione delle minute dei documenti, la loro stesura definitiva, la loro registrazione e, dopo l'apposizione del regolare sigillo, la loro spedizione.
Ma, ancora una volta, per l'estendersi del campo di attività e per il crescente moltiplicarsi degli affari e degli atti ad essi relativi, si determinò più tardi una suddivisione dei vari compiti affidati a questa Cancelleria, ed avvenne così che per il loro svolgimento furono creati degli Uffici particolari, che si resero indipendenti dalla stessa Cancelleria. I principali di questi nuovi Uffici erano: la Dataria Apostolica, la quale, sottratta alla Cancelleria Apostolica una gran parte delle sue funzioni, si occupava dell'esame delle suppliche presentate al Papa, della concessione delle grazie ivi richieste e, più tardi, anche della materia concernente i benefici ecclesiastici; e la Segreteria di Stato, il cui inizio risale al secolo XV (si chiamava allora Camera Segreta) e che si sviluppò ancor più nei secoli XVI e XVII, allorché fu creata la figura del Segretario di Stato, come persona di assoluta fiducia per il Pontefice, che ne interpretasse esattamente il pensiero e ne eseguisse fedelmente le direttive. Questa Segreteria, la quale aveva il compito di trattare gli affari «diplomatici» segreti e di redigere la relativa corrispondenza, si serviva per questa materia, secondo gli usi dell'età moderna, anche della lingua volgare. Da essa presero origine la Segreteria dei Brevi ai Principi e la Segreteria delle Lettere Latine, che si svilupparono successivamente in Uffici a sé stanti. Deve essere, anche, ricordata la Segreteria dei Brevi Apostolici, la quale, alle dirette dipendenze del Sommo Pontefice, sin dalla fine del secolo XIV provvide alla spedizione delle lettere redatte in forma meno solenne. Inoltre, le Sacre Congregazioni della Curia Romana, sorte nel secolo XVI, provvedevano da se stesse alla redazione di alcuni atti per i settori di loro competenza, e così essi furono sottratti alla Cancelleria Apostolica.
Per tutte queste ragioni, dunque, e per altre circostanze determinate dallo sviluppo storico, all'inizio dell'età moderna il numero e l'ampiezza delle funzioni della Cancelleria Apostolica venne pian piano a diminuire e a restringersi di molto. Anche nella riforma della Curia Romana, che fu fatta dal Pontefice Pio X di santa memoria, e in quella che Noi stesso abbiamo avviato con la Costituzione Apostolica già nominata, alla Cancelleria Apostolica non rimase che il solo compito di preparare, redigere e spedire alcuni atti Pontifici di forma più solenne.
Bisogna, infine, tener presente che secondo il riordinamento della Curia Romana, da noi intrapresa con la predetta Costituzione, alcuni Uffici che si occupavano degli affari che appartenevano, un tempo, alla Cancelleria Apostolica, e cioè la Segreteria dei Brevi Apostolici, la Segreteria dei Brevi ai Principi, la Segreteria delle Lettere Latine, sono già passati alla Segreteria di Stato, la quale appare al presente come una ricostituzione di quell'antica Cancelleria Apostolica, adattata ovviamente e strutturata secondo le moderne esigenze.
Pertanto, tenendo conto, oltre che di queste, delle intrinseche esigenze che riguardano la redazione di ogni tipo di Lettere Apostoliche in Latino e volendo provvedere all'uniformità di questi atti ufficiali, anche al fine di rendere più semplice e più efficace un tale servizio nell'interesse della Chiesa, alla quale, del resto, presta la sua opera tutta la Curia Romana, nοi riteniamo conveniente che tutte queste mansioni, in precedenza distribuite in vario modo, siano convogliate in un'unica sede e siano affidate a quel Dicastero, che per sua natura è particolarmente vicino al Romano Pontefice e svolge per lui le funzioni di segreteria.
Stando così le cose, dopo averne esaminato e ponderato tutti gli aspetti e sentito in proposito il parere degli esperti, stabiliamo quanto segue:
1. Nella Curia Romana l'Ufficio della Cancelleria Apostolica in quanto tale cessa di esistere, e gli affari che prima erano ad essa affidati circa le Lettere Decretali, le Costituzioni Apostoliche e i Brevi di maggiore importanza e simili, sono attribuiti alla Nostra Segreteria di Stato o Papale, presso la quale dovranno essere custoditi con cura il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore.
2. Gli affari anzidetti, nell'ambito della Segreteria di Stato, saranno trattati da quel particolare ufficio, di cui parla la menzionata Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae universae al n. 22, 1° e 2° (Cf AAS 59 (1967), p. 896) - è, infatti, un ufficio unificato - che sarà chiamato Cancelleria delle Lettere Apostoliche.
3. Per quanto riguarda i Superiori, gli Officiali e il personale della Cancelleria Apostolica, che esisteva finora, sarà compito della Sede Apostolica provvedere a loro secondo opportunità.
4. La professione di fede, che i Presuli di nuova nomina facevano prima nella sede della Cancelleria Apostolica, in futuro sarà da essi emessa presso la Sacra Congregazione per i Vescovi.
5. Analogamente, le incombenze che nella medesima Cancelleria erano proprie dei Protonotari Apostolici di numero partecipanti saranno, d'ora innanzi, svolte da essi presso la Segreteria di Stato.
Tutto quanto è stato da Noi stabilito con la presente Lettera in forma di Motu proprio, ordiniamo che abbia fermo e stabile valore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche se degna di specialissima menzione, decidendo, altresì, che la stessa Lettera entri in vigore con effetto immediato.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 febbraio 1973, anno decimo del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI
PER SCARICARE LA LETTERA APOSTOLICA "QUO APTIUS" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

ESORTAZIONE APOSTOLICA
DI SUA SANTITÀ
PAOLO VI
Venerabili Fratelli e diletti Figli, salute e Apostolica Benedizione
Introduzione
IMPEGNO PARTICOLARE PER L'EVANGELIZZAZIONE
1. L'impegno di annunziare il Vangelo agli uomini del nostro tempo animati dalla speranza, ma, parimente, spesso travagliati dalla paura e dall'angoscia, è senza alcun dubbio un servizio reso non solo alla comunità cristiana, ma anche a tutta l'umanità. Di qui il dovere di confermare i fratelli, che Noi abbiamo ricevuto dal Signore con l'ufficio di Successore di Pietro (1), e che è per Noi un «assillo quotidiano» (2), un programma di vita e d'azione, e un impegno fondamentale del Nostro Pontificato; questo dovere Ci sembra ancora più nobile e necessario allorché si tratta di incoraggiare i nostri fratelli nella missione di evangelizzatori, affinché, in questi tempi d'incertezza e di disordine, essi la compiano con amore, zelo e gioia sempre maggiori.
IN OCCASIONE DI TRE AVVENIMENTI
2. È proprio ciò che Noi vogliamo fare qui, al termine di questo Anno Santo, nel corso del quale la Chiesa, «protesa con ogni sforzo verso la predicazione del Vangelo a tutti gli uomini» (3), non ha voluto fare altro che compiere il proprio ufficio di messaggera della Buona Novella di Gesù Cristo, proclamata in virtù di due consegne fondamentali: «Rivestitevi dell'uomo nuovo» (4), e «Lasciatevi riconciliare con Dio» (5).
Vogliamo farlo in questo decimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II, i cui obiettivi si riassumono, in definitiva, in uno solo: rendere la Chiesa del XX secolo sempre più idonea ad annunziare il Vangelo all'umanità del XX secolo.
Vogliamo farlo ad un anno dalla terza Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi - dedicata, come è noto, all'evangelizzazione - tanto più che questo Ci è stato richiesto dagli stessi Padri Sinodali. Infatti, alla fine di quella memorabile Assemblea, essi hanno deciso di rimettere al Pastore della Chiesa universale, con grande fiducia e semplicità, il frutto del loro lavoro, dichiarando che si aspettavano dal Papa uno slancio nuovo capace di creare, in una Chiesa ancor più radicata nella forza e nella potenza perenni della Pentecoste, nuovi tempi d'evangelizzazione (6 ).
TEMA SPESSO SOTTOLINEATO DURANTE IL NOSTRO PONTIFICATO
3. Di questo tema dell'evangelizzazione, Noi abbiamo sottolineato, a più riprese, l'importanza molto prima della celebrazione del Sinodo. «Le condizioni della società - dicevamo al Sacro Collegio dei Cardinali, il 22 giugno 1973 - ci obbligano tutti a rivedere i metodi, a cercare con ogni mezzo di studiare come portare all'uomo moderno il messaggio cristiano, nel quale, soltanto, egli può trovare la risposta ai suoi interrogativi e la forza per il suo impegno di solidarietà umana» (7). E Noi aggiungiamo che per dare una risposta valida alle esigenze del Concilio, le quali ci interpellano, è assolutamente necessario metterci di fronte ad un patrimonio di fede che la Chiesa ha il dovere di preservare nella sua purezza intangibile, ma anche di presentare agli uomini del nostro tempo, per quanto possibile, in modo comprensibile e persuasivo.
NELLA LINEA DEL SINODO DEL 1974
4. Questa fedeltà a un messaggio, del quale noi siamo i servitori, e alle persone a cui noi dobbiamo trasmetterlo intatto e vivo, è l'asse centrale dell'evangelizzazione. Essa pone tre brucianti domande, che il Sinodo del 1974 ha avuto costantemente davanti agli occhi:
- Che ne è oggi di questa energia nascosta della Buona Novella, capace di colpire profondamente la coscienza dell'uomo?
- Fino a quale punto e come questa forza evangelica è in grado di trasformare veramente l'uomo di questo secolo?
- Quali metodi bisogna seguire nel proclamare il Vangelo affinché la sua potenza possa raggiungere i suoi effetti?
Questi interrogativi esplicitano, in realtà, la domanda fondamentale che la Chiesa si pone oggi e che si potrebbe tradurre così: dopo il Concilio e grazie al Concilio, che è stato per essa un'ora di Dio in questo scorcio della storia, la Chiesa si sente o no più adatta ad annunziare il Vangelo e ad inserirlo nel cuore dell'uomo con convinzione, libertà di spirito ed efficacia?
INVITO ALLA RIFLESSIONE
5. Noi tutti vediamo l'urgenza di dare a questa domanda una risposta leale, umile, coraggiosa, e di agire di conseguenza. Nella nostra «sollecitudine per tutte le Chiese» (8).
Noi vorremmo aiutare i nostri Fratelli e Figli a rispondere a questi interrogativi. Possano le nostre parole, che vorrebbero essere, partendo dalle ricchezze del Sinodo, una riflessione sulla evangelizzazione, invitare alla medesima riflessione tutto il Popolo di Dio adunato nella Chiesa e dare nuovo slancio a tutti, specialmente a «quelli che si affaticano nella parola e nell'Insegnamento» (9), affinché ciascuno di essi sia «un fedele dispensatore della parola della verità» (10) e faccia opera di predicatore del Vangelo, assolvendo alla perfezione il proprio ministero. Una tale Esortazione Ci è parsa di capitale importanza, perché la presentazione del messaggio evangelico non è per la Chiesa un contributo facoltativo: è il dovere che le incombe per mandato del Signore Gesù, affinché gli uomini possano credere ed essere salvati. Sì, questo messaggio è necessario. È unico. È insostituibile. Non sopporta né indifferenza, né sincretismi, né accomodamenti. È in causa la salvezza degli uomini. Esso rappresenta la bellezza della rivelazione. Comporta una saggezza che non è di questo mondo. È capace di suscitare, per se stesso, la fede, una fede che poggia sulla potenza di Dio (11). Esso è la Verità. Merita che l'Apostolo vi consacri tutto il suo tempo, tutte le sue energie, e vi sacrifichi, se necessario, la propria vita.
I. Dal Cristo evangelizzatore alla Chiesa evangelizzatrice
TESTIMONIANZA E MISSIONE DI GESÙ
6. La testimonianza che il Signore dà di se stesso e che San Luca ha raccolto nel suo Vangelo - «Devo annunziare la Buona Novella del Regno di Dio» (12) - ha senza dubbio una grande portata, perché definisce con una parola la missione di Gesù: «Per questo sono stato mandato» (13). Queste parole acquistano tutta la loro significazione, se si accostano ai versetti precedenti, dove il Cristo aveva applicato a se stesso l'espressione del profeta Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto annuncio» (14).
Proclamare di città in città, soprattutto ai più poveri, spesso più disposti, il gioioso annuncio del compimento delle promesse e dell'Alleanza proposta da Dio: tale è la missione per la quale Gesù si dichiara inviato dal Padre. E tutti gli aspetti del suo Ministero - la stessa Incarnazione, i miracoli, l'insegnamento, la chiamata dei discepoli, l'invio dei Dodici, la Croce e la risurrezione, la permanenza della sua presenza in mezzo ai suoi - sono componenti della sua attività evangelizzatrice.
GESÙ PRIMO EVANGELIZZATORE
7. Molto spesso nel corso del Sinodo, i Vescovi hanno ricordato questa verità: Gesù medesimo, Vangelo di Dio (15), è stato assolutamente il primo e il più grande evangelizzatore. Lo è stato fino alla fine: fino alla perfezione e fino al sacrificio della sua vita terrena.
Evangelizzare: quale significato ha avuto questo imperativo per Cristo? Non è certo facile esprimere, in una sintesi completa, il senso, il contenuto, i modi dell'evangelizzazione, quale il Cristo la concepiva e l'ha realizzata. D'altra parte questa sintesi non potrà mai essere terminata. Ci basti ricordare alcuni aspetti essenziali.
L'ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO
8. Evangelizzatore, il Cristo annunzia prima di tutto un Regno, il Regno di Dio, il quale è tanto importante, rispetto a lui, che tutto diventa «il resto», che è «dato in aggiunta» (16). Solo il Regno è dunque assoluto e rende relativa ogni altra cosa. Il Signore si compiace di descrivere, sotto innumerevoli forme diverse, la felicità di appartenere a questo Regno, felicità paradossale fatta di cose che il mondo rifiuta (17); le esigenze del Regno e la sua Magna Charta (18), gli araldi del Regno (19), i suoi misteri (20); i suoi piccoli (21), la vigilanza e la fedeltà richieste a chiunque attende il suo avvento definitivo (22).
L'ANNUNCIO DELLA SALVEZZA LIBERATRICE
9. Come nucleo e centro della Buona Novella, il Cristo annunzia la salvezza, dono grande di Dio, che non solo è liberazione da tutto ciò che opprime l'uomo, ma è soprattutto liberazione dal peccato e dal Maligno, nella gioia di conoscere Dio e di essere conosciuti da lui, di vederlo, di abbandonarsi a lui. Tutto ciò comincia durante la vita del Cristo, è definitivamente acquisito mediante la sua morte e la sua risurrezione, ma deve essere pazientemente condotto nel corso della storia, per essere pienamente realizzato nel giorno della venuta definitiva del Cristo, che nessuno sa quanto avrà luogo, eccetto il Padre (23).
A PREZZO DI UNO SFORZO CROCIFIGGENTE
10. Questo Regno e questa salvezza, parole-chiave dell'evangelizzazione di Gesù Cristo, ogni uomo può riceverli come grazia e misericordia, e nondimeno ciascuno deve, al tempo stesso, conquistarli con la forza - appartengono ai violenti, dice il Signore (24) - con la fatica e la sofferenza, con una vita secondo il Vangelo, con la rinunzia e la croce, con lo spirito delle beatitudini. Ma, prima di tutto, ciascuno li conquista mediante un totale capovolgimento interiore che il Vangelo designa col nome di «metánoia», una conversione radicale, un cambiamento profondo della mente e del cuore (25).
PREDICAZIONE INSTANCABILE
11. Questa proclamazione del Regno di Dio, il Cristo la compie mediante la predicazione instancabile di una parola, di cui non si trova l'eguale in nessuna altra parte: «Ecco una dottrina nuova insegnata con autorità!» (26); «Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca» (27); «Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo!» (28). Le sue parole svelano il segreto di Dio, il suo disegno e Ia sua promessa, e cambiano perciò il cuore dell'uomo e il suo destino.
CON SEGNI EVANGELICI
12. Ma egli attua parimente questa proclamazione attraverso innumerevoli segni, che formano Io stupore delle folle e, nel contempo, le trascinano verso di lui per vederlo, ascoltarlo e lasciarsi trasformare da lai: malati guariti, acqua cambiata in vino, pane moltiplicato, morti che ritornano alla vita. E tra tutti, il segno al quale egli dà una grande importanza: i piccoli, i poveri sono evangelizzati, diventano suoi discepoli, si riuniscono «nel suo nome» nella grande comunità di quelli che credono in lui. Perché il Gesù che dichiarava: «Devo annunziare la buona novella del Regno di Dio» (29), è lo stesso Gesù di cui Giovanni Evangelista diceva che era venuto e doveva morire «per riunire insieme i figli di Dio dispersi» (30). Così egli compie la rivelazione, completandola e confermandola con ogni manifestazione che fa di se medesimo, mediante le parole e le opere, i segni e i miracoli, e più particolarmente mediante Ia sua morte, la sua risurrezione e l'invio dello Spirito di Verità (31).
PER UNA COMUNITÀ EVANGELIZZATA ED EVANGELIZZATRICE
13. Coloro che accolgono con sincerità la Buona Novella, proprio in virtù di questo accoglimento e della fede partecipata, si riuniscono nel nome di Gesù per cercare insieme il Regno, costruirlo, viverlo. L'ordine dato agli Apostoli - «Andate, proclamate la Buona Novella» - vale anche, sebbene in modo differente, per tutti i cristiani. È proprio per ciò che Pietro chiama questi ultimi «Popolo che Dio si è acquistato perché proclami le sue opere meravigliose (32), quelle medesime meraviglie che ciascuno ha potuto ascoltare nella propria lingua (33). Del resto, la Buona Novella del Regno, che viene e che è iniziato, è per tutti gli uomini di tutti i tempi. Quelli che l'hanno ricevuta e quelli che essa raccoglie nella comunità della salvezza, possono e devono comunicarla e diffonderla.
EVANGELIZZAZIONE, VOCAZIONE PROPRIA DELLA CHIESA
14. La Chiesa lo sa. Essa ha una viva consapevolezza che la parola del Salvatore - «Devo annunziare la buona novella del Regno di Dio» (34) - si applica in tutta verità a lei stessa. E volentieri aggiunge con S. Paolo: «Per me evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere. Guai a me se non predicassi il Vangelo!» (35). È con gioia e conforto che Noi abbiamo inteso, al termine della grande Assemblea dell'ottobre 1974, queste parole luminose: «Vogliamo nuovamente confermare che il mandato d'evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della Chiesa» (36), compito e missione che i vasti e profondi mutamenti della società attuale non rendono meno urgenti. Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale a dire per predicare ed insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare i peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo nella S. Messa che è il memoriale della sua morte e della sua gloriosa risurrezione.
LEGAMI RECIPROCI TRA LA CHIESA E L'EVANGELIZZAZIONE
15. Chiunque rilegge, nel Nuovo Testamento, le origini della Chiesa, seguendo passo passo la sua storia e considerandola nel suo vivere e agire, scorge che è legata all'evangelizzazione da ciò che essa ha di più intimo: - La Chiesa nasce dall'azione evangelizzatrice di Gesù e dei Dodici. Ne è il frutto normale, voluto, più immediato e più visibile: «Andate dunque, fate dei discepoli in tutte le nazioni» (37). Ora, «coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e circa tremila si unirono ad essi . . . E il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati» (38).
- Nata, di conseguenza, della missione, la Chiesa è, a sua volta, inviata da Gesù. La Chiesa resta nel mondo, mentre il Signore della gloria ritorna al Padre. Essa resta come un segno insieme opaco e luminoso di una nuova presenza di Gesù, della sua dipartita e della sua permanenza. Essa la prolunga e lo continua. Ed è appunto la sua missione e la sua condizione di evangelizzatore che, anzitutto, è chiamata a continuare (39). Infatti la comunità dei cristiani non è mai chiusa in se stessa. In essa la vita intima - la vita di preghiera, l'ascolto della Parola e dell'insegnamento degli Apostoli, la carità fraterna vissuta, il pane spezzato (40) - non acquista tutto il suo significato se non quando essa diventa testimonianza, provoca l'ammirazione e la conversione, si fa predicazione e annuncio della Buona Novella. Così tutta la Chiesa riceve la missione di evangelizzare, e l'opera di ciascuno è importante per il tutto.
- Evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l'evangelizzare se stessa. Comunità di credenti, comunità di speranza vissuta e partecipata, comunità d'amore fraterno, essa ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo dell'amore. Popolo di Dio immerso nel mondo, e spesso tentato dagli idoli, essa ha sempre bisogno di sentir proclamare «le grandi opere di Dio» (41), che l'hanno convertita al Signore, e d'essere nuovamente convocata e riunita da lui. Ciò vuol dire, in una parola, che essa ha sempre bisogno d'essere evangelizzata, se vuol conservare freschezza, slancio e forza per annunziare il Vangelo. Il Concilio Vaticano II ha ricordato (42) e il Sinodo del 1974 ha fortemente ripreso questo tema della Chiesa che si evangelizza mediante una conversione e un rinnovamento costanti, per evangelizzare il mondo con credibilità.
- La Chiesa è depositaria della Buona Novella che si deve annunziare. Le promesse della Nuova Alleanza in Gesù Cristo, l'insegnamento del Signore e degli Apostoli, la Parola di vita, le fonti della grazia e della benignità di Dio, il cammino della salvezza: tutto ciò le è stato affidato. Il contenuto del Vangelo, e quindi dell'evangelizzazione, essa lo conserva come un deposito vivente e prezioso, non per tenerlo nascosto, ma per comunicarlo.
- Inviata ed evangelizzata, la Chiesa, a sua volta, invia gli evangelizzatori. Mette nella loro bocca la Parola che salva, spiega loro il messaggio di cui essa stessa è depositaria, dà loro il mandato che essa stessa ha ricevuto e li manda a predicare: ma non a predicare le proprie persone o le loro idee personali (43), bensì un Vangelo di cui né essi, né essa sono padroni e proprietari assoluti per disporne a loro arbitrio, ma ministri per trasmetterlo con estrema fedeltà.
LA CHIESA, INSEPARABILE DAL CRISTO
16. C'è dunque un legame profondo tra il Cristo, la Chiesa e l'evangelizzazione. Durante questo tempo della Chiesa è lei che ha il mandato di evangelizzare. Questo mandato non si adempie senza di essa, né, e ancor meno, contro di essa.
È bene accennare a un momento come questo, quando avviene di sentire, non senza dolore, persone, che vogliamo credere ben intenzionate, ma certamente disorientate nel loro spirito, ripetere che esse desiderano amare il Cristo, ma non la Chiesa, ascoltare il Cristo, ma non la Chiesa, appartenere al Cristo, ma al di fuori della Chiesa. L'assurdo di questa dicotomia appare nettamente in queste parole del Vangelo: «Chi respinge voi, respinge me» (44). E come si può voler amare il Cristo senza amare la Chiesa, se la più bella testimonianza resa a Cristo è quella di S. Paolo: «Egli ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei»? (45)
II. Che cosa significa evangelizzare
COMPLESSITÀ DELL'AZIONE EVANGELIZZATRICE
17. Nell'azione evangelizzatrice della Chiesa, ci sono certamente degli elementi e degli aspetti da ritenere. Alcuni sono talmente importanti che si tende ad identificarli semplicemente con l'evangelizzazione. Si è potuto così definire l'evangelizzazione in termini di annuncio del Cristo a coloro che lo ignorano, di predicazione, di catechesi, di Battesimo e di altri Sacramenti da conferire.
Nessuna definizione parziale e frammentaria può dare ragione della realtà ricca, complessa e dinamica, quale è quella dell'evangelizzazione, senza correre il rischio di impoverirla e perfino di mutilarla. È impossibile capirla, se non si cerca di abbracciare con lo sguardo tutti gli elementi essenziali.
Questi elementi chiaramente sottolineati durante il menzionato Sinodo, vengono ancora approfonditi, di questi tempi, sotto l'influsso dei lavori sinodali, Siamo lieti che essi si collochino, in fondo, nella linea di quelli a noi trasmessi dal Concilio Vaticano II, soprattutto nelle Costituzioni «Lumen Gentium», «Gaudium et Spes», e nel Decreto «Ad Gentes».
RINNOVAMENTO DELL'UMANITÀ . . .
18. Evangelizzare, per la Chiesa, è portare la Buona Novella in tutti gli strati dell'umanità, è, col suo influsso, trasformare dal di dentro, rendere nuova l'umanità stessa: «Ecco io faccio nuove tutte le cose» (46). Ma non c'è nuova umanità, se prima non ci sono uomini nuovi, della novità del battesimo (47) e della vita secondo il Vangelo (48). Lo scopo dell'evangelizzazione è appunto questo cambiamento interiore e, se occorre tradurlo in una parola, più giusto sarebbe dire che la Chiesa evangelizza allorquando, in virtù della sola potenza divina del Messaggio che essa proclama (49), cerca di convertire la coscienza personale e insieme collettiva degli uomini, l'attività nella quale essi sono impegnati, la vita e l'ambiente concreto loro propri.
. . . E DEGLI STRATI DELL'UMANITÀ
19. Strati dell'umanità che si trasformano: per la Chiesa non si tratta soltanto di predicare il Vangelo in fasce geografiche sempre più vaste o a popolazioni sempre più estese, ma anche di raggiungere e quasi sconvolgere mediante la forza del Vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell'umanità, che sono in contrasto con la Parola di Dio e col disegno della salvezza.
EVANGELIZZAZIONE DELLE CULTURE
20. Si potrebbe esprimere tutto ciò dicendo così: occorre evangelizzare - non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice superficiale, ma in modo vitale, in profondità e fino alle radici - la cultura e le culture dell'uomo, nel senso ricco ed esteso che questi termini hanno nella Costituzione «Gaudium et Spes» (50), partendo sempre dalla persona e tornando sempre ai rapporti delle persone tra loro e con Dio.
Il Vangelo, e quindi l'evangelizzazione, non si identificano certo con la cultura, e sono indipendenti rispetto a tutte le culture, Tuttavia il Regno, che il Vangelo annunzia, è vissuto da uomini profondamente legati a una cultura, e la costruzione del Regno non può non avvalersi degli elementi della cultura e delle culture umane. Indipendenti di fronte alle culture, il Vangelo e l'evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna.
La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre. Occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture. Esse devono essere rigenerate mediante l'incontro con la Buona Novella. Ma questo incontro non si produrrà, se la Buona Novella non è proclamata.
IMPORTANZA PRIMORDIALE DELLA TESTIMONIANZA DI VITA
21. Ed essa deve essere anzitutto proclamata mediante la testimonianza. Ecco: un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità d'uomini nella quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di accoglimento, comunione di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per tutto ciò che è nobile e buono. Ecco: essi irradiano, inoltre, in maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che sono al di là dei valori correnti, e la speranza in qualche cosa che non si vede, e che non si oserebbe immaginare. Allora con tale testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della Buona Novella. Vi è qui un gesto iniziale di evangelizzazione. Forse tali domande saranno le prime che si porranno molti non cristiani, siano essi persone a cui il Cristo non era mai stato annunziato, battezzati non praticanti, individui che vivono nella cristianità ma secondo principii per nulla cristiani, oppure persone che cercano, non senza sofferenza, qualche cosa o Qualcuno che essi presagiscono senza poterlo nominare.
Altre domande sorgeranno, più profonde e più impegnative; provocate da questa testimonianza che comporta presenza, partecipazione, solidarietà, e che è un elemento essenziale, generalmente il primo, nella evangelizzazione (51). A questa testimonianza tutti i cristiani sono chiamati e possono essere, sotto questo aspetto, dei veri evangelizzatori. Pensiamo soprattutto alla responsabilità che spetta agli emigranti nei Paesi che li ricevono.
NECESSITÀ DI UN ANNUNCIO ESPLICITO
22. Tuttavia ciò resta sempre insufficiente, perché anche la più bella testimonianza si rivelerà a lungo impotente, se non è illuminata, giustificata - ciò che Pietro chiamava «dare le ragioni della propria speranza» (52), - esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del Signore Gesù. La Buona Novella, proclamata dalla testimonianza di vita, dovrà dunque essere presto o tardi annunziata dalla parola di vita. Non c'è vera evangelizzazione se il nome, l'insegnamento, la vita, le promesse, il Regno, il mistero di Gesù di Nazareth, Figlio di Dio, non siano proclamati.
La storia della Chiesa, a partire dal discorso di Pietro la mattina di Pentecoste, si mescola e si confonde con la storia di questo annuncio. Ad ogni nuova tappa della storia umana, la Chiesa, continuamente travagliata dal desiderio di evangelizzare, non ha che un assillo: chi inviare ad annunziare il mistero di Gesù? In quale linguaggio annunziare questo mistero? Come fare affinché esso si faccia sentire e arrivi a tutti quelli che devono ascoltarlo? Questo annuncio - kerigma, predicazione o catechesi - occupa un tale posto nell'evangelizzazione che ne è divenuto spesso sinonimo. Esso tuttavia non ne è che un aspetto.
PER UN'ADESIONE VITALE E COMUNITARIA
23. L'annuncio, in effetti, non acquista tutta la sua dimensione, se non quando è inteso, accolto, assimilato e allorché fa sorgere in colui che l'ha ricevuto un'adesione del cuore. Adesione alle verità che, per misericordia, il Signore ha rivelate. Ma più ancora, adesione al programma di vita - vita ormai trasformata - che esso propone. Adesione, in una parola, al Regno, cioè al «mondo nuovo», al nuovo stato di cose, alla nuova maniera di essere, di vivere, di vivere insieme, che il Vangelo inaugura. Una tale adesione, che non può restare astratta e disincarnata, si rivela concretamente mediante un ingresso visibile nella comunità dei fedeli. Così dunque, quelli, la cui vita si è trasformata, penetrano in una comunità che è di per sé segno di trasformazione e di novità di vita: è la Chiesa, sacramento visibile della salvezza (53). Ma, a sua volta, l'ingresso nella comunità ecclesiale si esprimerà attraverso molti altri segni che prolungano e dispiegano il segno della Chiesa. Nel dinamismo dell'evangelizzazione, colui che accoglie il Vangelo come Parola che salva (54), lo traduce normalmente in questi gesti sacramentali: adesione alla Chiesa, accoglimento dei Sacramenti, che manifestano e sostengono questa adesione mediante la grazia, che conferiscono.
FA SORGERE UN NUOVO APOSTOLATO
24. Finalmente, chi è stato evangelizzato a sua volta evangelizza. Qui è la prova della verità, la pietra di paragone dell'evangelizzazione: è impensabile che un uomo abbia accolto la Parola e si sia dato al Regno, senza diventare uno che a sua volta testimonia e annunzia. Al termine di queste considerazioni sul senso dell'evangelizzazione, occorre presentare un'ultima osservazione, che Noi stimiamo illuminante per le riflessioni che seguono.
L'Evangelizzazione, abbiamo detto, è un processo complesso e dagli elementi vari: rinnovamento dell'umanità, testimonianza, annuncio esplicito, adesione del cuore, ingresso nella comunità, accoglimento dei segni, iniziative di apostolato.
Questi elementi possono apparire contrastanti e persino esclusivi. Ma in realtà sono complementari e si arricchiscono vicendevolmente. Bisogna sempre guardare ciascuno di essi integrandolo con gli altri. Il merito del recente Sinodo sta nell'averci costantemente invitati a comporre questi elementi, più che ad opporli tra di loro, al fine di avere la piena comprensione dell'attività evangelizzatrice della Chiesa.
È questa visione globale, che ora vogliamo esporre nell'esaminare il contenuto dell'evangelizzazione, i mezzi per evangelizzare, e nel precisare a chi si indirizza l'annuncio evangelico e chi ne ha oggi l'incarico.
III. Il contenuto dell'evangelizzazione
CONTENUTO ESSENZIALE ED ELEMENTI SECONDARI
25. Nel messaggio che la Chiesa annunzia, ci sono certamente molti elementi secondari. La loro presentazione dipende molto dalle circostanze mutevoli. Essi pure cambiano. Ma c'è il contenuto essenziale, la sostanza viva, che non si può modificare né passare sotto silenzio, senza snaturare gravemente la stessa evangelizzazione.
TESTIMONIANZA RESA ALL'AMORE DEL PADRE
26. Non è superfluo ricordarlo: evangelizzare è anzitutto testimoniare, in maniera semplice e diretta, Dio rivelato da Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Testimoniare che nel suo Figlio ha amato il mondo; che nel suo Verbo incarnato ha dato ad ogni cosa l'essere ed ha chiamato gli uomini alla vita eterna. Questa attestazione di Dio farà raggiungere forse a molti il Dio ignoto (55), che essi adorano senza dargli un nome, o che cercano per una ispirazione segreta del cuore allorquando fanno l'esperienza della vacuità di tutti gli idoli. Ma è pienamente evangelizzatrice quando manifesta che, per l'uomo, il Creatore non è una potenza anonima e lontana: è il Padre. «Siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!» (56) e siamo dunque fratelli gli uni gli altri in Dio.
AL CENTRO DEL MESSAGGIO: LA SALVEZZA IN GESÙ CRISTO
27. La evangelizzazione conterrà sempre anche - come base, centro e insieme vertice del suo dinamismo - una chiara proclamazione che, in Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, morto e risuscitato, la salvezza è offerta ad ogni uomo, come dono di grazia e misericordia di Dio stesso (57). E non già una salvezza immanente, a misura dei bisogni materiali o anche spirituali che si esauriscono nel quadro dell'esistenza temporale e si identificano totalmente con i desideri, le speranze, le occupazioni, le lotte temporali, ma altresì una salvezza che oltrepassa tutti questi limiti per attuarsi in una comunione con l'unico Assoluto, quello di Dio: salvezza trascendente, escatologica, che ha certamente il suo inizio in questa vita, ma che si compie nell'eternità.
SOTTO IL SEGNO DELLA SPERANZA
28. La evangelizzazione, di conseguenza, non può non contenere l'annuncio profetico di un al di là, vocazione profonda e definitiva dell'uomo, in continuità e insieme in discontinuità con la situazione presente: al di là del tempo e della storia, al di là della realtà di questo mondo la cui figura passa, e delle cose di questo mondo, del quale un giorno si manifesterà una dimensione nascosta; al di là dell'uomo stesso, il cui vero destino non si esaurisce nel suo aspetto temporale, ma sarà rivelato nella vita futura (58). L'evangelizzazione contiene dunque anche la predicazione della speranza nelle promesse fatte da Dio nella nuova Alleanza in Gesù Cristo; la predicazione dell'amore di Dio verso di noi e del nostro amore verso Dio; la predicazione dell'amore fraterno per tutti gli uomini - capacità di dono e di perdono, di abnegazione, di aiuto ai fratelli - che, derivando dall'amore di Dio, è il nucleo del Vangelo; la predicazione del mistero del male e della ricerca attiva del bene. Predicazione, ugualmente - e questa è sempre urgente - della ricerca di Dio stesso attraverso a preghiera principalmente adorante e riconoscente, ma anche attraverso la comunione con quel segno visibile dell'incontro con Dio che è la Chiesa di Gesù Cristo, e questa comunione si esprime a sua volta mediante la realizzazione di quegli altri segni del Cristo, vivente ed operante nella Chiesa, quali sono i Sacramenti. Vivere in tal modo i Sacramenti, sì da portare la loro celebrazione ad una vera pienezza, non significa, come taluno pretenderebbe, mettere un ostacolo o accettare una deviazione dell'evangelizzazione, ma darle invece la sua completezza. Perché l'evangelizzazione nella sua totalità, oltre che nella predicazione di un messaggio, consiste nell'impiantare la Chiesa, la quale non esiste senza questo respiro, che è la vita sacramentale culminante nell'Eucaristia (59).
MESSAGGIO CHE COINVOLGE TUTTA LA VITA
29. Ma l'evangelizzazione non sarebbe completa se non tenesse conto del reciproco appello, che si fanno continuamente il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale, dell'uomo. Per questo l'evangelizzazione comporta un messaggio esplicito, adattato alle diverse situazioni, costantemente attualizzato, sui diritti e sui doveri di ogni persona umana, sulla vita familiare senza la quale la crescita personale difficilmente è possibile (60), sulla vita in comune nella società, sulla vita internazionale, la pace, la giustizia, lo sviluppo; un messaggio, particolarmente vigoroso nei nostri giorni, sulla liberazione.
UN MESSAGGIO DI LIBERAZIONE
30. È noto in quali termini ne abbiano parlato, al recente Sinodo, numerosi Vescovi di tutti i Continenti, soprattutto i Vescovi del Terzo Mondo, con un accento pastorale in cui vibrava la voce di milioni di figli della Chiesa che formano quei popoli. Popoli impegnati, Noi lo sappiamo, con tutta la loro energia, nello sforzo e nella lotta di superare tutto ciò che li condanna a restare ai margini della vita: carestie, malattie croniche, analfabetismo, pauperismo, ingiustizia nei rapporti internazionali e specialmente negli scambi commerciali, situazioni di neo-colonialismo economico e culturale talvolta altrettanto crudele quanto l'antico colonialismo politico. La Chiesa, hanno ripetuto i Vescovi, ha il dovere di annunziare la liberazione di milioni di esseri umani, essendo molti di essi figli suoi; il dovere di aiutare questa liberazione a nascere, di testimoniare per essa, di fare sì che sia totale. Tutto ciò non è estraneo all'evangelizzazione.
IN LEGAME NECESSARIO CON LA PROMOZIONE UMANA
31. Tra evangelizzazione e promozione umana - sviluppo, liberazione - ci sono infatti dei legami profondi. Legami di ordine antropologico, perché l'uomo da evangelizzare non è un essere astratto, ma è condizionato dalle questioni sociali ed economiche. Legami di ordine teologico, poiché non si può dissociare il piano della creazione da quello della Redenzione che arriva fino alle situazioni molto concrete dell'ingiustizia da combattere e della giustizia da restaurare. Legami dell'ordine eminentemente evangelico, quale è quello della carità: come infatti proclamare il comandamento nuovo senza promuovere nella giustizia e nella pace la vera, l'autentica crescita dell'uomo? Noi abbiamo voluto sottolineare questo ricordando che è impossibile accettare che «nell'evangelizzazione si possa o si debba trascurare l'importanza dei problemi, oggi così dibattuti, che riguardano la giustizia, la liberazione, lo sviluppo e la pace nel mondo. Sarebbe dimenticare la lezione che ci viene dal Vangelo sull'amore del prossimo sofferente e bisognoso»(61).
Ebbene, le medesime voci che con zelo, intelligenza e coraggio hanno affrontato nel corso del citato Sinodo questo tema cruciale, hanno offerto, con nostra grande gioia, i principii illuminanti per cogliere la portata e il senso profondo della liberazione quale l'ha annunziata e realizzata Gesù di Nazareth, e quale la predica la Chiesa.
SENZA RIDUZIONE NÉ AMBIGUITÀ
32. Non dobbiamo nasconderci, infatti, che molti cristiani, anche generosi e sensibili alle questioni drammatiche che racchiude il problema della liberazione, volendo impegnare la Chiesa nello sforzo di liberazione, hanno spesso la tentazione di ridurre la sua missione alle dimensioni di un progetto semplicemente temporale; i suoi compiti a un disegno antropologico; la salvezza, di cui essa è messaggera e sacramento, a un benessere materiale; la sua attività, trascurando ogni preoccupazione spirituale e religiosa, a iniziative di ordine politico o sociale. Ma se così fosse, la Chiesa perderebbe la sua significazione fondamentale. Il suo messaggio di liberazione non avrebbe più alcuna originalità e finirebbe facilmente per essere accaparrato e manipolato da sistemi ideologici e da partiti politici.
Essa non avrebbe più autorità per annunziare, come da parte di Dio, la liberazione. Per questo Noi abbiamo voluto sottolineare nella medesima allocuzione all'inizio della terza Assemblea Sinodale «la necessità di riaffermare chiaramente la finalità specificamente religiosa dell'evangelizzazione. Questa perderebbe la sua ragion d'essere se si scostasse dall'asse religioso che la governa: il Regno di Dio prima di ogni altra cosa, nel suo senso pienamente teologico» (62).
LA LIBERAZIONE EVANGELICA
33. Circa la liberazione, che l'evangelizzazione annunzia e si sforza di realizzare, bisogna dire piuttosto:
- essa non può limitarsi alla semplice e ristretta dimensione economica, politica, sociale o culturale, ma deve mirare all'uomo intero, in ogni sua dimensione, compresa la sua apertura verso l'assoluto, anche l'Assoluto di Dio;
- è dunque radicata in una certa concezione dell'uomo, in una antropologia, che non può mai sacrificare alle esigenze di una qualsivoglia strategia, di una prassi o di una efficacia a breve scadenza.
FONDATA SUL REGNO DI DIO
34. Per questo, col predicare la liberazione e con l'associarsi a coloro che operano e soffrono per essa, la Chiesa - senza accettare di circoscrivere la propria missione al solo campo religioso, disinteressandosi dei problemi temporali dell'uomo - riafferma il primato della sua vocazione spirituale, rifiuta di sostituire l'annuncio del Regno con la proclamazione delle liberazioni umane, e sostiene che anche il suo contributo alla liberazione è incompleto se trascura di annunziare la salvezza in Gesù Cristo.
SU UNA VISIONE EVANGELICA DELL'UOMO
35. La Chiesa collega ma non identifica giammai liberazione umana e salvezza in Gesù Cristo, perché sa per rivelazione, per esperienza storica e per riflessione di fede, che non ogni nozione di liberazione è necessariamente coerente e compatibile con una visione evangelica dell'uomo, delle cose e degli avvenimenti; sa che non basta instaurare la liberazione, creare il benessere e lo sviluppo, perché venga il Regno di Dio.
Ben più, la Chiesa ha la ferma convinzione che ogni liberazione temporale, ogni liberazione politica - anche se si sforza di trovare la propria giustificazione in questa o in quella pagina dell'Antico o del Nuovo Testamento, anche se rivendica per i suoi postulati ideologici e per le sue norme di azione l'autorità dei dati e delle conclusioni teologiche, anche se pretende di essere la teologia per i nostri giorni - porta in se stessa il germe della propria negazione e decade dall'ideale che si propone sia perché i suoi motivi non sono quelli della giustizia nella carità, sia perché lo slancio che la trascina non ha una dimensione veramente spirituale e perché il suo scopo finale non è la salvezza e la beatitudine in Dio.
ESIGE UNA NECESSARIA CONVERSIONE
36. La Chiesa reputa certamente importante ed urgente edificare strutture più umane, più giuste, più rispettose dei diritti della persona, meno oppressive e meno coercitive, ma è cosciente che le migliori strutture, i sistemi meglio idealizzati diventano presto inumani se le inclinazioni inumane del cuore dell'uomo non sono risanate, se non c'è una conversione del cuore e della mente di coloro che vivono in queste strutture o le dominano.
ESCLUDE LA VIOLENZA
37. La Chiesa non può accettare la violenza, soprattutto la forza delle armi - incontrollabile quando si 'scatena - né la morte di chicchessia, come cammino di liberazione, perché sa che la violenza chiama sempre la violenza e genera irresistibilmente nuove forme di oppressione e di schiavitù più pesanti di quelle dalle quali essa pretendeva liberare. Lo dicemmo chiaramente nel nostro viaggio in Colombia: «Vi esortiamo a non porre la vostra fiducia nella violenza, né nella rivoluzione; tale atteggiamento è contrario allo spirito cristiano e può anche ritardare, e non favorire, l'elevazione sociale alla quale legittimamente aspirate» (63); «dobbiamo dire e riaffermare che la violenza non è né cristiana né evangelica e che i mutamenti bruschi o violenti delle strutture sarebbero fallaci, inefficaci in se stessi e certamente non conformi alla dignità del popolo» (64).
CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA CHIESA
38. Detto questo, Noi siamo lieti che la Chiesa prenda coscienza sempre più viva della maniera propria, fondamentalmente evangelica, che essa ha di collaborare alla liberazione degli uomini. E che cosa fa? Cerca sempre più di suscitare numerosi cristiani che si dedichino alla liberazione degli altri. Offre a questi cristiani «liberatori» una ispirazione di fede, una motivazione di amore fraterno, un insegnamento sociale al quale il vero cristiano non può non essere attento, ma che deve porre alla base della sua sapienza, della sua esperienza per tradurlo concretamente in categorie di azione, di partecipazione e di impegno. Tutto questo, senza confondersi con atteggiamenti tattici né col servizio di un sistema politico, deve caratterizzare lo slancio del cristiano impegnato. La Chiesa si sforza di inserire sempre la lotta cristiana per la liberazione nel disegno globale della salvezza che essa stessa annunzia.
Ciò che Noi abbiamo qui ricordato emerge più di una volta dai dibattiti del Sinodo. Noi abbiamo d'altronde voluto consacrare a questo tema alcune parole di chiarificazione nel Discorso indirizzato ai Padri alla chiusura dell'Assemblea (65).
Tutte queste considerazioni dovrebbero aiutare, bisogna sperarlo, ad evitare l'ambiguità che riveste troppo spesso la parola «liberazione» nelle ideologie, nei sistemi o nei gruppi politici. La liberazione che proclama e prepara l'evangelizzazione è quella che il Cristo stesso ha annunziato e donato all'uomo mediante il suo sacrificio.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA
39. Da questa giusta liberazione legata all'evangelizzazione, che mira ad ottenere strutture salvaguardanti le libertà umane, non può essere separata l'assicurazione di tutti i fondamentali diritti dell'uomo, fra i quali la libertà religiosa occupa un posto di primaria importanza. Abbiamo recentemente parlato dell'attualità di tale questione, mettendo in rilievo «quanti cristiani, ancora oggi, perché cristiani, perché cattolici vivono soffocati da una sistematica oppressione! Il dramma della fedeltà a Cristo, e della libertà di religione, se pure mascherato da categoriche dichiarazioni in favore dei diritti della persona e della socialità umana, continua!» (66).
IV. Le vie dell'evangelizzazione
ALLA RICERCA DEI MEZZI ADATTI
40. L'importanza evidente del contenuto dell'evangelizzazione non deve nasconderne l'importanza delle vie e dei mezzi.
Questo problema del «come evangelizzare» resta sempre attuale perché i modi variano secondo le circostanze di tempo, di luogo, di cultura, e lanciano pertanto una certa sfida alla nostra capacità di scoperta e di adattamento.
A noi specialmente, Pastori nella Chiesa, incombe la cura di ricreare con audacia e saggezza, in piena fedeltà al suo contenuto, i modi più adatti e più efficaci per comunicare il messaggio evangelico agli uomini del nostro tempo. Ci basti, in questa riflessione, ricordare alcune vie che, per una ragione o per l'altra, hanno un'importanza fondamentale.
LA TESTIMONIANZA DELLA VITA
41. Ed anzitutto, senza ripetere tutto quello che abbiamo già sopra ricordato, è bene sottolineare questo: per la Chiesa, la testimonianza di una vita autenticamente cristiana, abbandonata in Dio in una comunione che nulla deve interrompere, ma ugualmente donata al prossimo con uno zelo senza limiti, è il primo mezzo di evangelizzazione. «L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, - dicevamo lo scorso anno a un gruppo di laici - o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni» (67). S Pietro esprimeva bene ciò quando descriveva lo spettacolo di una vita casta e rispettosa che «conquista senza bisogno di parole quelli che si rifiutano di credere alla Parola» (68). È dunque mediante la sua condotta, mediante la sua vita, che la Chiesa evangelizzerà innanzitutto il mondo, vale a dire mediante la sua testimonianza vissuta di fedeltà al Signore Gesù, di povertà e di distacco, di libertà di fronte ai poteri di questo mondo, in una parola, di santità.
UNA PREDICAZIONE VIVENTE
42. Non è superfluo sottolineare, inoltre, l'importanza e la necessità della predicazione. «Come potranno credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? . . . La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo» (69). Questa legge posta un giorno dall'Apostolo Paolo conserva ancor oggi tutta la sua forza.
Sì, è sempre indispensabile la predicazione, questa proclamazione verbale di un messaggio. Sappiamo bene che l'uomo moderno sazio di discorsi si mostra spesso stanco di ascoltare e, peggio ancora, immunizzato contro la parola. Conosciamo anche le idee di numerosi psicologi e sociologi, i quali affermano che l'uomo moderno ha superato la civiltà della parola, ormai inefficace ed inutile, e vive oggi nella civiltà dell'immagine. Questi fatti dovrebbero spingerci, certo, a mettere in opera nella trasmissione del messaggio evangelico i mezzi moderni escogitati da tale civiltà. Tentativi molto validi, d'altronde, sono stati già compiuti in tal senso. Noi non possiamo che lodarli ed incoraggiarli perché si sviluppino ancora di più. La fatica che provocano al giorno d'oggi tanti discorsi vuoti, e l'attualità di molte altre forme di comunicazione non debbono tuttavia diminuire la forza permanente della parola, né far perdere fiducia in essa. La parola resta sempre attuale, soprattutto quando è portatrice della potenza di Dio (70) Per questo resta ancora attuale l'assioma di S. Paolo: «La fede dipende dalla predicazione» (71): è appunto la Parola ascoltata che porta a credere.
LITURGIA DELLA PAROLA
43. Questa predicazione evangelizzatrice assume parecchie forme, che lo zelo ispirerà a ricreare quasi all'infinito. Sono effettivamente innumerevoli gli avvenimenti della vita e le situazioni umane che offrono l'occasione di un annuncio discreto, ma incisivo, di ciò che il Signore ha da dire in questa circostanza. Basta una vera sensibilità spirituale per saper leggere negli avvenimenti il messaggio di Dio. Ma, dal momento che la liturgia rinnovata dal Concilio ha molto valorizzato la «Liturgia della Parola», sarebbe un errore non vedere nell'omelia uno strumento valido ed adattissimo di evangelizzazione. Bisogna certo conoscere e mettere a profitto le esigenze e le possibilità dell'omelia perché essa acquisti tutta la sua efficacia pastorale. Bisogna, però, soprattutto esserne convinti e dedicarvisi con amore. Questa predicazione particolarmente inserita nella celebrazione eucaristica da cui riceve forza e vigore particolari, ha certamente un ruolo speciale nell'evangelizzazione, nella misura in cui esprime la fede profonda del ministro sacro che predica, ed è impregnata di amore. I fedeli riuniti per formare una Chiesa pasquale, che celebra la festa del Signore presente in mezzo ad essi, si attendono molto da questa predicazione, e ne ricavano frutto purché essa sia semplice, chiara, diretta, adatta, profondamente radicata nell'insegnamento evangelico e fedele al Magistero della Chiesa, animata da un ardore apostolico equilibrato che le viene dal suo proprio carattere, piena di speranza, nutriente per la fede, generatrice di pace e di unità. Molte comunità parrocchiali o di altro tipo vivono e si consolidano grazie alla omelia di ogni domenica, quando essa ha tali qualità.
Aggiungiamo che, grazie al medesimo rinnovamento liturgico, la celebrazione eucaristica non è il solo momento appropriato per l'omelia. Questa trova il suo posto e non deve essere trascurata nella celebrazione di tutti i Sacramenti, o ancora nel corso di para-liturgie, nell'ambito di assemblee di fedeli. Sarà sempre un'occasione privilegiata per comunicare la Parola del Signore.
LA CATECHESI
44. Una via da non trascurare nella evangelizzazione è quella dell'insegnamento catechetico. L'intelligenza, soprattutto quella dei fanciulli e degli adolescenti, ha bisogno di apprendere, mediante un insegnamento religioso sistematico, i dati fondamentali, il contenuto vivo della verità che Dio ha voluto trasmetterci e che la Chiesa ha cercato di esprimere in maniera sempre più ricca, nel corso della sua lunga storia. Che questo insegnamento debba essere impartito per formare abitudini di vita cristiana e non per rimanere solamente intellettuale, nessuno lo contesterà. Certamente, lo sforzo di evangelizzazione trarrà un grande profitto, sul piano dell'insegnamento catechetico dato in chiesa, nelle scuole, là dove è possibile, in ogni caso nelle famiglie cristiane, se i catechisti dispongono di testi appropriati, aggiornati con saggezza e competenza, sotto l'autorità dei Vescovi. 1 metodi dovranno essere adattati all'età, alla cultura, alla capacità delle persone, nella costante ricerca di fissare nella memoria, nella intelligenza e nel cuore le verità essenziali che dovranno impregnare la vita intera. Bisogna soprattutto preparare buoni catechisti - catechisti parrocchiali, istitutori, genitori - preoccupati di perfezionarsi in questa arte superiore, indispensabile ed esigente dell'insegnamento religioso. D'altronde, senza che si rischi di trascurare in qualunque cosa la formazione dei fanciulli, si osserva che le condizioni attuali rendono sempre più urgente l'insegnamento catechistico sotto la forma di un catecumenato, per numerosi giovani e adulti, che, toccati dalla grazia, scoprono a poco a poco il volto di Cristo e provano il bisogno di donarsi a lui.
UTILIZZAZIONE DEI «MASS MEDIA»
45. Nel nostro secolo, contrassegnato dai mass media o strumenti di comunicazione sociale, il primo annuncio, la catechesi o l'approfondimento ulteriore della fede, non possono fare a meno di questi mezzi come abbiamo già sottolineato.
Posti al servizio del Vangelo, essi sono capaci di estendere quasi all'infinito il campo di ascolto della Parola di Dio, e fanno giungere la Buona Novella a milioni di persone. La Chiesa si sentirebbe colpevole di fronte al suo Signore se non adoperasse questi potenti mezzi, che l'intelligenza umana rende ogni giorno più perfezionati; servendosi di essi la Chiesa «predica sui tetti» (72) il messaggio di cui è depositaria; in loro essa trova una versione moderna ed efficace del pulpito. Grazie ad essi riesce a parlare alle moltitudini.
Tuttavia l'uso degli strumenti di comunicazione sociale per l'evangelizzazione presenta una sfida: il messaggio evangelico dovrebbe, per il loro tramite, giungere a folle di uomini, ma con la capacità di penetrare nella coscienza di ciascuno, di depositarsi nel cuore di ciascuno come se questi fosse l'unico, con tutto ciò che egli ha di più singolare e personale, e di ottenere a proprio favore un'adesione, un impegno del tutto personale.
INDISPENSABILE CONTATTO PERSONALE
46. Perciò, accanto alla proclamazione fatta in forma generale del Vangelo, l'altra forma della sua trasmissione, da persona a persona, resta valida ed importante. Il Signore l'ha spesso praticata - come ad esempio attestano le conversazioni con Nicodemo, Zaccheo, la Samaritana, Simone il fariseo e con altri - ed anche gli Apostoli. C'è forse in fondo, una forma diversa di esporre il Vangelo, che trasmettere ad altri la propria esperienza di fede? Non dovrebbe accadere che l'urgenza di annunziare la Buona Novella a masse di uomini facesse dimenticare questa forma di annuncio mediante la quale la coscienza personale di un uomo è raggiunta, toccata da una parola del tutto straordinaria che egli riceve da un altro. Noi non potremmo lodare a sufficienza quei sacerdoti che, attraverso il Sacramento della Penitenza o attraverso il dialogo pastorale, si mostrano pronti a guidare le persone nelle vie del Vangelo, a confermarle nei loro sforzi, a rialzarle se sono cadute, ad assisterle sempre con discernimento e disponibilità.
IL RUOLO DEI SACRAMENTI
47. Peraltro non si insisterà mai abbastanza sul fatto che l'evangelizzazione non si esaurisce nella predicazione e nell'insegnamento di una dottrina. Essa deve raggiungere la vita: la vita naturale alla quale dà un senso nuovo, grazie alle prospettive evangeliche che le apre; e la vita soprannaturale, che non è la negazione, ma la purificazione e la elevazione della vita naturale. Questa vita soprannaturale trova la sua espressione vivente nei sette Sacramenti e nella loro mirabile irradiazione di grazia e di santità.
L'evangelizzazione dispiega così tutta la sua ricchezza quando realizza il legame più intimo e, meglio ancora, una intercomunicazione ininterrotta, tra la Parola e i Sacramenti. In un certo senso, è un equivoco l'opporre, come si fa talvolta, l'evangelizzazione e la sacramentalizzazione. È vero che un certo modo di conferire i Sacramenti, senza un solido sostegno della catechesi circa questi medesimi Sacramenti e di una catechesi globale, finirebbe per privarli in gran parte della loro efficacia. Il compito dell'evangelizzazione è precisamente quello di educare nella fede in modo tale che essa conduca ciascun cristiano a vivere i Sacramenti come veri Sacramenti della fede, e non a riceverli passivamente, o a subirli.
LA PIETÀ POPOLARE
48. Qui noi tocchiamo un aspetto dell'evangelizzazione che non può lasciare insensibili. Vogliamo parlare di quella realtà che si designa spesso oggi col termine di religiosità popolare.
Sia nelle regioni in cui la Chiesa è impiantata da secoli, sia là dove essa è in via di essere impiantata, si trovano presso il popolo espressioni particolari della ricerca di Dio e della fede. Per lungo tempo considerate meno pure, talvolta disprezzate, queste espressioni formano oggi un po' dappertutto l'oggetto di una riscoperta. I Vescovi ne hanno approfondito il significato, nel corso del recente Sinodo, con un realismo pastorale e uno zelo notevoli.
La religiosità popolare, si può dire, ha certamente i suoi limiti. È frequentemente aperta alla penetrazione di molte deformazioni della religione, anzi di superstizioni. Resta spesso a livello di manifestazioni cultuali senza impegnare un'autentica adesione di fede. Può anche portare alla formazione di sètte e mettere in pericolo la vera comunità ecclesiale.
Ma se è ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di evangelizzazione, è ricca di valori. Essa manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio fino all'eroismo, quando si tratta di manifestare la fede; comporta un senso acuto degli attributi profondi di Dio: la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti interiori raramente osservati altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione. A motivo di questi aspetti, Noi la chiamiamo volentieri «pietà popolare», cioè religione del popolo, piuttosto che religiosità.
La carità pastorale deve suggerire a tutti quelli, che il Signore ha posto come capi di comunità ecclesiali, le norme di comportamento nei confronti di questa realtà, così ricca e insieme così vulnerabile. Prima di tutto, occorre esservi sensibili, saper cogliere le sue dimensioni interiori e i suoi valori innegabili, essere disposti ad aiutarla a superare i suoi rischi di deviazione. Ben orientata, questa religiosità popolare può essere sempre più, per le nostre masse popolari, un vero incontro con Dio in Gesù Cristo.
V. I destinatari dell'evangelizzazione
UNA DESTINAZIONE UNIVERSALE
49. Le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Marco conferiscono alla evangelizzazione, di cui il Signore incarica gli Apostoli, una universalità senza frontiere: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura» (73).
I Dodici e la prima generazione dei cristiani hanno ben compreso la lezione di questo testo e di altri simili; ne hanno fatto un programma di azione. La stessa persecuzione, disperdendo gli Apostoli, ha contribuito a disseminare la Parola e a far impiantare la Chiesa in regioni sempre più lontane. L'ammissione di Paolo al rango degli Apostoli e il suo carisma di predicatore ai pagani - non giudei - della venuta di Gesù Cristo ha ulteriormente sottolineato questo universalismo.
NONOSTANTE TUTTI GLI OSTACOLI
50. Lungo venti secoli di storia, le generazioni cristiane hanno affrontato periodicamente diversi ostacoli, che si frapponevano a questa missione universalistica. Da un lato, la tentazione, da parte degli stessi evangelizzatori, di limitare con differenti pretesti il loro campo di azione missionaria. Dall'altro, le resistenze, spesso umanamente insuperabili, di coloro ai quali si indirizza l'evangelizzatore. D'altronde, Noi dobbiamo costatare con tristezza che l'opera evangelizzatrice della Chiesa è fortemente contrastata, se non impedita, da poteri pubblici. Avviene, anche ai nostri giorni, che annunziatori della Parola di Dio siano privati dei loro diritti, perseguitati, minacciati, eliminati per il solo fatto di predicare Gesù Cristo e il suo Vangelo. Ma Noi abbiamo fiducia che, malgrado queste prove dolorose, alla fin fine l'opera di questi apostoli non verrà meno in nessuna regione del mondo.
Nonostante tali avversità, la Chiesa ravviva sempre la sua ispirazione più profonda, quella che le viene direttamente dal Maestro: A tutto il mondo! A tutte le creature! Fino agli estremi confini della terra! Essa lo ha fatto di nuovo nel recente Sinodo, come un appello a non imprigionare l'annuncio evangelico limitandolo a un settore dell'umanità, o a una classe di uomini, o a un solo tipo di cultura. Altri esempi potrebbero essere rivelatori.
PRIMO ANNUNCIO AI LONTANI
51. Rivelare Gesù Cristo e il suo Vangelo a quelli che non li conoscono, questo è, fin dal mattino della Pentecoste, il programma fondamentale che la Chiesa ha assunto come ricevuto dal suo Fondatore. Tutto il Nuovo Testamento, e in modo speciale gli Atti degli Apostoli, testimoniano un momento privilegiato e, in un certo senso, esemplare di questo sforzo missionario che si riscontrerà poi lungo tutta la storia della Chiesa.
Questo primo annuncio di Gesù Cristo, essa lo realizza mediante un'attività complessa e diversificata, che si designa talvolta col nome di «pre-evangelizzazione», ma che è già, a dire il vero, l'evangelizzazione, benché al suo stadio iniziale ed ancora incompleto. Una gamma quasi infinita di mezzi, la predicazione esplicita, certamente, ma anche l'arte, l'approccio scientifico, la ricerca filosofica, il ricorso legittimo ai sentimenti del cuore umano possono essere adoperati a questo scopo.
ANNUNCIO AL MONDO SCRISTIANIZZATO
52. Se questo primo annuncio si rivolge specialmente a coloro, che non hanno mai inteso la Buona Novella di Gesù, oppure ai fanciulli, esso si dimostra ugualmente sempre più necessario, a causa delle situazioni di scristianizzazione frequenti ai nostri giorni, per moltitudini di persone che hanno ricevuto il battesimo ma vivono completamente al di fuori della vita cristiana, per gente semplice che ha una certa fede ma ne conosce male i fondamenti, per intellettuali che sentono il bisogno di conoscere Gesù Cristo in una luce diversa dall'insegnamento ricevuto nella loro infanzia, e per molti altri.
LE RELIGIONI NON CRISTIANE
53. Esso si rivolge anche a immense porzioni di umanità che praticano religioni non cristiane, che la Chiesa rispetta e stima perché sono l'espressione viva dell'anima di vasti gruppi umani. Esse portano in sé l'eco di millenni di ricerca di Dio, ricerca incompleta, ma realizzata spesso con sincerità e rettitudine di cuore. Posseggono un patrimonio impressionante di testi profondamente religiosi. Hanno insegnato a generazioni di persone a pregare. Sono tutte cosparse di innumerevoli «germi del Verbo» (74) e possono costituire una autentica «preparazione evangelica» per riprendere una felice espressione del Concilio Vaticano II tratta da Eusebio di Cesarea.
Tale situazione suscita, certamente, questioni complesse e delicate, che conviene studiare alla luce della Tradizione cristiana e del Magistero della Chiesa per offrire ai missionari di oggi e di domani nuovi orizzonti nei loro contatti con le religioni non cristiane. Vogliamo rilevare, soprattutto oggi, che né il rispetto e la stima verso queste religioni, né la complessità dei problemi sollevati sono per la Chiesa un invito a tacere l'annuncio di Cristo di fronte ai non cristiani. Al contrario, essa pensa che queste moltitudini hanno il diritto di conoscere la ricchezza del mistero di Cristo (76), nella quale noi crediamo che tutta l'umanità può trovare, in una pienezza insospettabile, tutto ciò che essa cerca a tentoni su Dio, sull'uomo e sul suo destino, sulla vita e sulla morte, sulla verità. Anche di fronte alle espressioni religiose naturali più degne di stima, la Chiesa si basa dunque sul fatto che la religione di Gesù, che essa annunzia mediante l'evangelizzazione, mette oggettivamente l'uomo in rapporto con il piano di Dio, con la sua presenza vivente, con la sua azione; essa fa così incontrare il mistero della Paternità divina che si china sull'umanità; in altri termini, la nostra religione instaura effettivamente con Dio un rapporto autentico e vivente, che le altre religioni non riescono a stabilire, sebbene esse tengano, per così dire, le loro braccia tese verso il cielo.
Per questo la Chiesa mantiene vivo il suo slancio missionario, e vuole altresì intensificarlo nel nostro momento storico. Essa si sente responsabile di fronte a popoli interi. Non ha riposo fin quando non abbia fatto del suo meglio per proclamare la Buona Novella di Gesù Salvatore. Prepara sempre nuove generazioni di apostoli. Lo costatiamo con gioia nel momento in cui non mancano di quelli che pensano ed anche dicono che l'ardore e lo slancio apostolico si sono esauriti, e che l'epoca delle Missioni è ormai tramontata. Il Sinodo ha risposto che l'annuncio missionario non si inaridisce e che la Chiesa sarà sempre tesa verso il suo adempimento.
SOSTEGNO DELLA FEDE DEI FEDELI
54. Tuttavia la Chiesa non si sente dispensata da una attenzione altrettanto infaticabile nei confronti di coloro che hanno ricevuto la fede e che, spesso da generazioni, sono a contatto col Vangelo. Essa cerca così di approfondire, consolidare, nutrire, rendere sempre più matura la fede di coloro che si dicono già fedeli e credenti, affinché lo siano maggiormente.
Questa fede è quasi sempre, oggi, posta a confronto col secolarismo, anzi con l'ateismo militante: è una fede esposta alle prove e minacciata: di più, una fede assediata e combattuta. Essa rischia di perire per asfissia o per inedia se non è continuamente alimentata e sostenuta. Evangelizzare comporta dunque, molto spesso, comunicare alla fede dei credenti - particolarmente mediante una catechesi piena di linfa evangelica e corredata da un linguaggio adatto ai tempi e alle persone - questo necessario alimento e questo sostentamento.
La Chiesa cattolica ha egualmente una viva sollecitudine per i cristiani che non sono in piena comunione con essa: mentre prepara con loro l'unità voluta dal Cristo, e precisamente per realizzare l'unità nella verità, è consapevole che mancherebbe gravemente al suo dovere se non testimoniasse presso di loro la pienezza della rivelazione, di cui custodisce il deposito.
NON CREDENTI
55. Significativa è anche la preoccupazione, manifestatasi nel citato Sinodo, nei riguardi delle due sfere molto differenti l'una dall'altra, e tuttavia molto vicine per la sfida che, ciascuna a suo modo, lancia all'evangelizzazione.
La prima è quella che si può chiamare il progressivo aumento della non credenza nel mondo moderno. Il Sinodo ha cercato di descrivere questo mondo moderno: sotto questo nome generico, quante correnti di pensiero, valori e contro-valori, aspirazioni latenti o semi di distruzione, convinzioni antiche che scompaiono e convinzioni nuove che si impongono! Dal punto di vista spirituale, questo mondo moderno sembra dibattersi in quello che un autore contemporaneo ha chiamato «il dramma dell'umanesimo ateo» (77).
Da una parte, si è obbligati a costatare nel cuore stesso di questo mondo contemporaneo il fenomeno che diviene quasi la sua nota più sorprendente: il secolarismo. Noi non parliamo della secolarizzazione, che è lo sforzo in sé giusto e legittimo, per nulla incompatibile con la fede o con la religione, di scoprire nella creazione, in ogni cosa o in ogni evento dell'universo, le leggi che li reggono con una certa autonomia, nell'intima convinzione che il Creatore vi ha posto queste leggi. Il recente Concilio ha affermato, in questo senso la legittima autonomia della cultura e particolarmente delle scienze (78). Noi vediamo qui un vero secolarismo: una concezione del mondo, nella quale questo si spiega da sé senza che ci sia bisogno di ricorrere a Dio, divenuto in tal modo superfluo ed ingombrante. Un simile secolarismo, per riconoscere il potere dell'uomo, finisce dunque col fare a meno di Dio ed anche col negarlo.
Nuove forme di ateismo - un ateismo antropocentrico, non più astratto e metafisico ma pragmatico, programmatico e militante - sembrano derivarne. In connessione con questo secolarismo ateo, ci vengono proposti tutti i giorni, sotto le forme più svariate, la civiltà dei consumi, l'edonismo elevato a valore supremo, la volontà di potere e di dominio, discriminazioni di ogni tipo: altrettante inclinazioni inumane di questo umanesimo.
In questo stesso mondo moderno d'altra parte, paradossalmente, non si può negare l'esistenza di veri addentellati cristiani, di valori evangelici, per lo meno sotto forma di un vuoto o di una nostalgia. Non sarebbe esagerato parlare di una possente e tragica invocazione ad essere evangelizzato.
NON PRATICANTI
56. Una seconda sfera è quella dei non praticanti, oggi un gran numero di battezzati che, in larga misura, non hanno rinnegato formalmente il loro Battesimo, ma ne sono completamente al margine, e non lo vivono. Il fenomeno dei non praticanti è molto antico nella storia del cristianesimo, è legato ad una debolezza naturale, ad una profonda incoerenza che, purtroppo, ci portiamo dentro di noi. Esso presenta tuttavia oggi delle caratteristiche nuove. Si spiega spesso mediante gli sradicamenti tipici della nostra epoca. Nasce anche dal fatto che i cristiani oggi vivono a fianco con i non credenti e ricevono continuamente i contraccolpi della non credenza. D'altronde, i non praticanti contemporanei, più di quelli di altri tempi, cercano di spiegare e di giustificare la loro posizione in nome di una religione interiore, dell'autonomia o dell'autenticità personali.
Atei e non credenti da una parte, non praticanti dall'altra, oppongono dunque all'evangelizzazione resistenze non trascurabili. I primi, la resistenza di un certo rifiuto, l'incapacità di cogliere il nuovo ordine delle cose, il nuovo senso del mondo, della vita, della storia, che non è possibile se non si parte dall'Assoluto di Dio. Gli altri, la resistenza dell'inerzia, l'atteggiamento un po' ostile di qualcuno che si sente di casa, che afferma di saper tutto, di aver gustato tutto, di non credervi più. Secolarismo ateo e assenza di pratica religiosa si trovano presso gli adulti e presso i giovani, presso l'élite e nelle masse, in tutti i settori culturali, nelle antiche come nelle giovani Chiese. L'azione evangelizzatrice della Chiesa, che non può ignorare questi due mondi né arrestarsi di fronte ad essi, deve cercare costantemente i mezzi e il linguaggio adeguati per proporre o riproporre loro la rivelazione di Dio e la fede in Gesù Cristo.
NEL CUORE DELLE MASSE
57. Come Cristo durante il tempo della sua predicazione, come i Dodici al mattino della Pentecoste, anche la Chiesa vede davanti a sé una immensa folla umana che ha bisogno del Vangelo e vi ha diritto, perché Dio «vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità» (79).
Conscia del suo dovere di predicare la salvezza a tutti, sapendo che il messaggio evangelico non è riservato a un piccolo gruppo di iniziati, di privilegiati o di eletti, ma destinato a tutti, la Chiesa fa propria l'angoscia di Cristo di fronte alle folle sbandate e sfinite «come pecore senza pastore» e ripete spesso la sua parola: «Sento compassione di questa folla» (80). Ma è anche cosciente che, per l'efficacia della predicazione evangelica, nel cuore delle masse, essa deve indirizzare il suo messaggio a comunità di fedeli, la cui azione può e deve giungere agli altri.
LE COMUNITÀ ECCLESIALI DI BASE
58. Il recente Sinodo si è molto occupato di queste piccole comunità o «comunità di base», perché nella Chiesa d'oggi sono spesso menzionate. Che cosa sono e per quale motivo queste sarebbero destinatarie speciali di evangelizzazione e, nello stesso tempo, evangelizzatrici?
Fiorendo un po' dappertutto nella Chiesa, secondo le differenti testimonianze sentite al Sinodo, esse differiscono molto fra di loro, in seno alla stessa regione e, più ancora, da una regione all'altra.
In alcune regioni sorgono e si sviluppano, salvo eccezioni, all'interno della Chiesa, solidali con la sua vita, nutrite del suo insegnamento, unite ai suoi pastori. In questo caso, nascono dal bisogno di vivere ancora più intensamente la vita della Chiesa; oppure dal desiderio e dalla ricerca di una dimensione più umana, che comunità ecclesiali più vaste possono difficilmente offrire, soprattutto nelle metropoli urbane contemporanee che favoriscono la vita di massa e insieme l'anonimato. Esse possono soltanto prolungare, a modo loro, a livello spirituale e religioso - culto, approfondimento della fede, carità fraterna, preghiera, comunione con i Pastori - la piccola comunità sociologica, villaggio o simili.
Oppure esse vogliono riunire per l'ascolto e la meditazione della Parola, per i Sacramenti e il vincolo dell'Agape, gruppi che l'età, la cultura, lo stato civile o la situazione sociale rendono omogenei, coppie, giovani, professionisti, eccetera; persone che la vita trova già riunite nella lotta per la giustizia, per l'aiuto fraterno ai poveri, per la promozione umana. Oppure, infine, esse radunano i cristiani là dove la penuria dei sacerdoti non favorisce la vita normale di una comunità parrocchiale. Tutto questo è supposto all'interno delle comunità costituite della Chiesa, soprattutto delle Chiese particolari e delle parrocchie.
In altre regioni, al contrario, comunità di base si radunano in uno spirito di critica acerba nei confronti della Chiesa, che esse stimmatizzano volentieri come «istituzionale» e alla quale si oppongono come comunità carismatiche, libere da strutture, ispirate soltanto al Vangelo.
Esse hanno dunque come caratteristica un evidente atteggiamento di biasimo e di rifiuto nei riguardi delle espressioni della Chiesa: la sua gerarchia, i suoi segni. Contestano radicalmente questa Chiesa. In tale linea, la loro ispirazione diviene molto presto ideologica, ed è raro che non diventino quindi preda di una opzione politica, di una corrente, quindi di un sistema, anzi di un partito, con tutto il rischio, che ciò comporta, di esserne strumentalizzate.
La differenza è già notevole: le comunità che per il loro spirito di contestazione si tagliano fuori dalla Chiesa, di cui d'altronde danneggiano l'unità, possono sì intitolarsi «comunità di base», ma è questa una designazione strettamente sociologica. Esse non potrebbero chiamarsi, senza abuso di linguaggio, comunità ecclesiali di base, anche se, rimanendo ostili alla Gerarchia, hanno la pretesa di perseverare nell'unità della Chiesa. Questa qualifica appartiene alle altre, a quelle che si radunano nella Chiesa per far crescere la Chiesa.
Queste ultime comunità saranno un luogo di evangelizzazione, a beneficio delle comunità più vaste, specialmente delle Chiese particolari, e saranno una speranza per la Chiesa universale, come abbiamo detto al termine del menzionato Sinodo, nella misura in cui:
- cercano il loro alimento nella Parola di Dio e non si lasciano imprigionare dalla polarizzazione politica o dalle ideologie di moda, pronte sempre a sfruttare il loro immenso potenziale umano;
- evitano la tentazione sempre minacciosa della contestazione sistematica e dello spirito ipercritico, col pretesto di autenticità e di spirito di collaborazione;
- restano fermamente attaccate alla Chiesa particolare, nella quale si inseriscono, e alla Chiesa universale, evitando così il pericolo - purtroppo reale! - di isolarsi in se stesse, di credersi poi l'unica autentica Chiesa di Cristo, e quindi di anatematizzare le altre comunità ecclesiali;
- conservano una sincera comunione con i Pastori che il Signore dà alla sua Chiesa e col Magistero, che lo Spirito del Cristo ha loro affidato;
- non si considerano giammai come l'unico destinatario o l'unico artefice di evangelizzazione - anche l'unico depositario del Vangelo! -; ma, consapevoli che la Chiesa è molto più vasta e diversificata, accettano che questa Chiesa si incarni anche in modi diversi da quelli, che avvengono in esse;
- crescono ogni giorno in consapevolezza, zelo, impegno, ed irradiazione missionari;
- si mostrano in tutto universalistiche e non mai settarie.
Alle suddette condizioni, certamente esigenti ma esaltanti, le comunità ecclesiali di base corrisponderanno alla loro fondamentale vocazione: ascoltatrici del Vangelo, che è ad esse annunziato, e destinatarie privilegiate dell'evangelizzazione, diverranno senza indugio annunciatrici del Vangelo.
VI. Gli operai dell'evangelizzazione
CHIESA TUTTA INTERA MISSIONARIA
59. Se vi sono uomini che proclamano nel mondo il Vangelo della salvezza, lo fanno per ordine, nel nome e con la grazia del Cristo Salvatore. «Come lo annunzieranno, senza essere prima inviati?» (81) scriveva colui che fu indubbiamente uno dei più grandi evangelizzatori. Nessuno può esercitare tale compito senza esservi stato inviato.
Ma chi ha, dunque, la missione di evangelizzare?
Il Concilio Vaticano II ha risposto con chiarezza: alla Chiesa «per mandato divino incombe l'obbligo di andare nel mondo universo a predicare il Vangelo ad ogni creatura» (82). E in un altro testo: «Tutta la Chiesa è missionaria, e l'opera evangelizzatrice è un dovere fondamentale del Popolo di Dio . . . » (83).
Abbiamo già accennato a questo intimo legame tra Chiesa ed evangelizzazione. Quando la Chiesa annunzia il Regno di Dio e lo edifica, essa stessa affonda le radici nel cuore del mondo come segno e strumento di questo Regno che è presente e che viene. Il Concilio ha riportato questa espressione molto significativa di Sant'Agostino sull'attività missionaria dei Dodici: «Generarono le Chiese predicando la parola di verità» (84).
UN ATTO ECCLESIALE
60. La constatazione che la Chiesa è inviata e destinata all'evangelizzazione, dovrebbe suscitare in noi due convinzioni.
La prima: evangelizzare non è mai per nessuno un atto individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale. Allorché il più sconosciuto predicatore, catechista o pastore, nel luogo più remoto, predica il Vangelo, raduna la sua piccola comunità o amministra un Sacramento, anche se si trova solo compie un atto di Chiesa, e il suo gesto è certamente collegato mediante rapporti istituzionali, ma anche mediante vincoli invisibili e radici profonde dell'ordine della grazia, all'attività evangelizzatrice di tutta la Chiesa. Ciò presuppone che egli agisca non per una missione arrogatasi, né in forza di un'ispirazione personale, ma in unione con la missione della Chiesa e in nome di essa. Come conseguenza, la seconda convinzione: se ciascuno evangelizza in nome della Chiesa, la quale a sua volta lo fa in virtù di un mandato del Signore, nessun evangelizzatore è padrone assoluto della propria azione evangelizzatrice, con potere discrezionale di svolgerla secondo criteri e prospettive individualistiche, ma deve farlo in comunione con la Chiesa e con i suoi Pastori. La Chiesa, l'abbiamo già rilevato, è tutta intera evangelizzatrice. Ciò significa che, per il mondo nel suo insieme e per ogni singola parte del mondo ove si trovi, la Chiesa si sente responsabile del compito di diffondere il Vangelo.
LA PROSPETTIVA DELLA CHIESA UNIVERSALE
61. A questo punto della nostra riflessione sostiamo con voi, Fratelli e Figli, su d'una questione oggi particolarmente importante. I primi cristiani esprimevano volentieri - nella celebrazione liturgica, nella loro testimonianza davanti ai giudici e ai carnefici, nei loro testi apologetici - una fede profonda nella Chiesa, indicandola come diffusa in tutto l'universo. Avevano pienamente coscienza di appartenere ad una grande comunità che né lo spazio né il tempo potrebbero limitare: «Dal giusto Abele fino all'ultimo eletto» (85) «fino agli estremi confini della terra» (86) «fino alla fine del mondo» (87) .
Così il Signore ha voluto la sua Chiesa: universale, grande albero fra i cui rami si annidano gli uccelli del cielo (88) rete che raccoglie ogni sorta di pesci (89) o che Pietro trae a riva piena di centocinquantatré grossi pesci (90), gregge portato al pascolo da un solo pastore (91). Chiesa universale senza confini né frontiere eccetto, purtroppo, quelle del cuore e dello spirito del peccatore.
LA PROSPETTIVA DELLA CHIESA PARTICOLARE
62. Tuttavia questa Chiesa universale si incarna di fatto nelle Chiese particolari, costituite a loro volta dall'una o dall'altra concreta porzione di umanità, che parlano una data lingua, che sono tributarie di un loro retaggio culturale, di un determinato sostrato umano. L'apertura alle ricchezze della Chiesa particolare risponde ad una specifica sensibilità dell'uomo contemporaneo.
Ma dobbiamo ben guardarci dal concepire la Chiesa universale come la somma o, se così si può dire, la federazione più o meno eteroclita di Chiese particolari essenzialmente diverse. Secondo il pensiero del Signore, è la stessa Chiesa che, essendo universale per vocazione e per missione, quando getta le sue radici nella varietà dei terreni culturali, sociali, umani, assume in ogni parte del mondo fisionomie ed espressioni esteriori diverse.
In tal modo ogni Chiesa particolare, che si separasse volontariamente dalla Chiesa universale, perderebbe il suo riferimento al disegno di Dio, si impoverirebbe nella sua dimensione ecclesiale. D'altra parte, la Chiesa «toto orbe diffusa» diventerebbe un'astrazione se non prendesse corpo e vita precisamente attraverso le Chiese particolari. Solo una permanente attenzione ai due poli della Chiesa ci consentirà di percepire la ricchezza di questo rapporto tra Chiesa universale e Chiese particolari.
ADATTAMENTO E FEDELTÀ DEL LINGUAGGIO
63. Le Chiese particolari profondamente amalgamate non solo con le persone, ma anche con le aspirazioni, le ricchezze e i limiti, i modi di pregare, di amare, di considerare la vita e il mondo, che contrassegnano un determinato ambito umano, hanno il compito di assimilare l'essenziale del messaggio evangelico, di trasfonderlo, senza la minima alterazione della sua verità fondamentale, nel linguaggio compreso da questi uomini e quindi di annunziarlo nel medesimo linguaggio.
La trasposizione dev'essere fatta - con il discernimento, la serietà, il rispetto e la competenza che la materia esige - nel campo delle espressioni liturgiche (92), della catechesi, della formulazione teologica, delle strutture ecclesiali secondarie, dei ministeri. E il termine «linguaggio» deve essere qui inteso meno nel senso semantico o letterario che in quello che si può chiamare antropologico e culturale.
La questione è indubbiamente delicata. La evangelizzazione perde molto della sua forza e della sua efficacia se non tiene in considerazione il popolo concreto al quale si rivolge, se non utilizza la sua lingua, i suoi segni e simboli, se non risponde ai problemi da esso posti, se non interessa la sua vita reale. Ma d'altra parte l'evangelizzazione rischia di perdere la propria anima e di svanire, se il suo contenuto resta svuotato o snaturato col pretesto di tradurlo o se, volendo adattare una realtà universale ad uno spazio locale, si sacrifica questa realtà e si distrugge l'unità senza la quale non c'è universalità. Orbene, soltanto una Chiesa che conservi la consapevolezza della propria universalità e che dimostri di essere effettivamente universale, può avere un messaggio da tutti comprensibile, al di là dei confini regionali.
Del resto una legittima attenzione alle Chiese particolari non può che arricchire la Chiesa. È anzi indispensabile e urgente. Corrisponde alle aspirazioni più profonde dei popoli e delle comunità umane di scoprire sempre maggiormente la propria fisionomia.
APERTURA ALLA CHIESA UNIVERSALE
64. Ma questo arricchimento esige che le Chiese particolari si conservino profondamente aperte verso la Chiesa universale. Bisogna ben rilevare, del resto, che i cristiani più semplici, più fedeli al Vangelo, più aperti al senso vero della Chiesa, hanno una spontanea sensibilità circa questa dimensione universale, ne sentono istintivamente e molto fortemente il bisogno, si riconoscono facilmente in essa, vibrano all'unisono con essa e soffrono nel più intimo di se stessi quando, in nome di teorie che non comprendono, li si vuole comprimere in una Chiesa priva di questa universalità, chiesa regionalista, senza orizzonte.
D'altronde, come la storia ben dimostra, ogni volta che l'una o l'altra Chiesa particolare, pur con le migliori intenzioni, con argomenti teologici, sociologici, politici o pastorali, o anche nel desiderio d'una certa libertà di movimento e d'azione, si è tagliata fuori dalla Chiesa universale e dal suo centro vitale e visibile, molto difficilmente è sfuggita, quando vi è sfuggita, a due pericoli ugualmente gravi: da una parte il pericolo dell'isolazionismo disseccante, e in seguito, in breve tempo, del disgregamento, poiché ciascuna delle sue cellule si separava da essa, com'essa s'era separata dal nucleo centrale; e d'altra parte, il pericolo di perdere la propria libertà quando, staccata dal centro e dalle altre Chiese che le comunicavano forza ed energia, si è trovata, essendo sola, in preda alle forze più diverse di asservimento e di sfruttamento.
Quanto più una Chiesa particolare è unita con solidi legami di comunione alla Chiesa universale - nella carità e nella fedeltà, nell'apertura al magistero di Pietro, nell'unità della «Lex orandi» che è anche «Lex credendi», nella sollecitudine dell'unità con tutte le altre Chiese che costituiscono l'universalità - tanto più questa stessa Chiesa sarà capace di tradurre il tesoro della fede nella legittima varietà delle espressioni della professione di fede, della preghiera e del culto, della vita del comportamento cristiani, dell'influsso spirituale del popolo nel quale è inserita; tanto più, ancora, essa sarà veramente evangelizzatrice, cioè capace di attingere nel patrimonio universale a profitto del suo popolo, come pure di comunicare alla Chiesa universale l'esperienza e la vita dello stesso popolo, a beneficio di tutti.
L'INALTERABILE DEPOSITO DELLA FEDE
65. Precisamente in questo senso abbiamo voluto dire, alla chiusura della terza Assemblea Generale del Sinodo, una parola chiara e piena di paterno affetto, insistendo sul ruolo del Successore di Pietro come principio visibile, vivente e dinamico dell'unità fra le Chiese, e quindi dell'universalità dell'unica Chiesa (93). Insistevamo anche sulla grave responsabilità che Ci incombe, ma che condividiamo con i Nostri Fratelli nell'episcopato, di conservare inalterabile il contenuto della fede cattolica, che il Signore ha affidato agli Apostoli: anche se tradotto in tutti i linguaggi, questo contenuto non dev'essere né intaccato né mutilato; pur se rivestito dei simboli propri di ciascun popolo, esplicitato mediante formulazioni teologiche che tengano conto degli ambienti culturali, sociali ed anche razziali diversi, deve restare il contenuto della fede cattolica, quale il Magistero ecclesiale l'ha ricevuto e lo trasmette.
COMPITI DIVERSIFICATI
66. Tutta la Chiesa è dunque chiamata ad evangelizzare, e tuttavia vi sono da adempiere attività tra loro differenti nel suo ambito di evangelizzazione. Questa diversità di servizi nell'unità della stessa missione costituisce la ricchezza e la bellezza dell'evangelizzazione. Ricordiamo brevemente questi compiti.
Prima di tutto Ci sia permesso di segnalare l'insistenza con la quale il Signore, nelle pagine del Vangelo, affida agli Apostoli la funzione di annunziare la Parola. Egli li ha scelti (94), li ha formati durante diversi anni di familiarità (95), li ha costituiti (96) e mandati (97) come testimoni e maestri autorizzati del messaggio della salvezza. E i Dodici hanno a loro volta inviato i loro successori, i quali continuano a predicare la Buona Novella sulla linea apostolica.
IL SUCCESSORE DI PIETRO
67. Così il Successore di Pietro è investito, per volontà di Cristo, del ministero preminente di insegnare la verità rivelata. Il Nuovo Testamento mostra spesso Pietro «pieno di Spirito Santo» che prende la parola a nome di tutti (98). Per questo san Leone Magno parla di Pietro come di colui che ha meritato il primato dell'apostolato (99). Per questo, inoltre, la voce della Chiesa presenta il Papa «al vertice più alto - in apice, in specula - dell'apostolato» (100). Il Concilio Vaticano II ha voluto ribadirlo dichiarando che «il comando di Cristo di predicare il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Marc. 16, 15), riguarda innanzitutto e immediatamente proprio loro (i vescovi), insieme con Pietro e sotto la guida di Pietro» (101).
La potestà piena, suprema e universale (102) che Cristo ha conferito al suo Vicario per il governo pastorale della Chiesa, consiste dunque specialmente nell'attività, esercitata dal Papa, di predicare e di far predicare la Buona Novella della salvezza.
VESCOVI E SACERDOTI
68. Uniti al Successore di Pietro, i Vescovi, successori degli Apostoli, ricevono, in forza dell'ordinazione episcopale, l'autorità per insegnare nella Chiesa la verità rivelata. Essi sono i maestri della fede.
Ai Vescovi sono associati nel ministero dell'evangelizzazione, come responsabili a titolo speciale, coloro che mediante l'ordinazione sacerdotale «agiscono in persona di Cristo» (103), in quanto educatori del Popolo di Dio nella fede, predicatori, fungendo in pari tempo da ministri del- l'Eucaristia e degli altri Sacramenti.
Pertanto tutti noi Pastori siamo invitati, più di qualunque altro membro della Chiesa, a prendere coscienza di questo dovere. Ciò che costituisce la singolarità del nostro servizio sacerdotale, ciò che dà un'unità profonda alle mille occupazioni che ci sollecitano durante tutto il corso della nostra vita, ciò che conferisce alle nostre attività una nota specifica, è questa finalità presente in ogni nostra azione: «Annunziare il Vangelo di Dio» (104).
Ecco un tratto della nostra identità che nessun dubbio dovrebbe mai incrinare, nessuna obiezione mai eclissare: come Pastori, siamo stati scelti dalla misericordia del sovrano Pastore (105) nonostante la nostra insufficienza, per proclamare con autorità la Parola di Dio, per radunare il Popolo di Dio che era disperso, per nutrire questo popolo con i segni dell'azione di Cristo, che sono i Sacramenti, per condurlo sulla via della salvezza, per conservarlo in quella unità di cui noi stessi siamo, a differenti livelli, strumenti attivi e vitali, per animare incessantemente questa comunità raccolta attorno al Cristo secondo la sua più intima vocazione. E quando, nella misura dei nostri limiti umani e secondo la grazia di Dio, adempiamo tutto questo, noi realizziamo un'opera di evangelizzazione: Noi come Pastore della Chiesa universale, i Nostri Fratelli nell'episcopato alla guida delle Chiese particolari, i sacerdoti e i diaconi uniti con i propri Vescovi, di cui sono collaboratori, mediante una comunione che ha la sua sorgente nel Sacramento dell'Ordine sacro e nella carità della Chiesa.
RELIGIOSI
69. I religiosi, a loro volta, trovano nella vita consacrata un mezzo privilegiato per una evangelizzazione efficace. Con la stessa intima natura del loro essere si collocano nel dinamismo della Chiesa, assetata dell'Assoluto di Dio, chiamata alla santità. Di questa santità essi sono testimoni. Incarnano la Chiesa in quanto desiderosa di abbandonarsi al radicalismo delle beatitudini. Con la loro vita sono il segno della totale disponibilità verso Dio, verso la Chiesa, verso i fratelli.
In questo essi rivestono un'importanza speciale nel contesto di una testimonianza che, come abbiamo affermato, è primordiale nell'evangelizzazione. Questa silenziosa testimonianza di povertà e di distacco, di purezza e di trasparenza, di abbandono nell'ubbidienza, può diventare, oltre che una provocazione al mondo e alla Chiesa stessa, anche una predicazione eloquente, capace di impressionare anche i non cristiani di buona volontà, sensibili a certi valori.
In questa prospettiva, si intuisce il ruolo svolto nell'evangelizzazione da religiosi e religiose consacrati alla preghiera, al silenzio, alla penitenza, al sacrificio. Altri religiosi, in grandissimo numero, si dedicano direttamente all'annuncio del Cristo. La loro azione missionaria dipende evidentemente dalla gerarchia e deve essere coordinata con la pastorale che questa vuol mettere in opera. Ma chi non considera l'apporto immenso che essi hanno dato e che continuano a dare all'evangelizzazione? Grazie alla loro consacrazione religiosa, essi sono per eccellenza volontari e liberi per lasciare tutto e per andare ad annunziare il Vangelo fino ai confini del mondo. Essi sono intraprendenti, e il loro apostolato è spesso contrassegnato da una originalità, una genialità che costringono all'ammirazione. Sono generosi: li si trova spesso agli avamposti della missione, ed assumono i più grandi rischi per la loro salute e per la loro stessa vita. Sì, veramente, la Chiesa deve molto a loro.
LAICI
70. I laici, che la loro vocazione specifica pone in mezzo al mondo e alla guida dei più svariati compiti temporali, devono esercitare con ciò stesso una forma singolare di evangelizzazione.
Il loro compito primario e immediato non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale - che è il ruolo specifico dei Pastori - ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia; così pure della cultura, delle scienze e delle arti, della vita internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà particolarmente aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la famiglia, l'educazione dei bambini e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza. Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dover sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una dimensione trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesù Cristo.
FAMIGLIA
71. Nell'ambito dell'apostolato di evangelizzazione proprio dei laici, è impossibile non rilevare l'azione evangelizzatrice della famiglia. Essa ha ben meritato, nei diversi momenti della storia della Chiesa, la bella definizione di «Chiesa domestica», sancita dal Concilio Vaticano II (106). Ciò significa che, in ogni famiglia cristiana, dovrebbero riscontrarsi i diversi aspetti della Chiesa intera. Inoltre la famiglia, come la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia.
Dunque nell'intimo di una famiglia cosciente di questa missione, tutti i componenti evangelizzano e sono evangelizzati. I genitori non soltanto comunicano ai figli il Vangelo, ma possono ricevere da loro lo stesso Vangelo profondamente vissuto. E una simile famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie e dell'ambiente nel quale è inserita. Anche le famiglie sorte da un matrimonio misto hanno il dovere di annunziare Cristo alla prole nella pienezza delle implicazioni del comune Battesimo; esse hanno inoltre il non facile compito di rendersi artefici di unità.
GIOVANI
72. Le circostanze ci invitano a rivolgere un'attenzione tutta speciale ai giovani. Il loro aumento numerico e la loro presenza crescente nella società, i problemi che li assillano devono risvegliare in tutti la preoccupazione di offrire loro, con zelo e con intelligenza, l'ideale evangelico da conoscere e da vivere. Ma d'altra parte occorre che i giovani, ben formati nella fede e nella preghiera, diventino sempre più gli apostoli della gioventù. La Chiesa fa molto affidamento sul loro apporto e Noi stessi, a diverse riprese, abbiamo manifestato la Nostra piena fiducia verso di essi.
MINISTERI DIVERSIFICATI
73. Così acquista tutta la sua importanza la presenza attiva dei laici nelle realtà temporali. Non bisogna tuttavia trascurare o dimenticare l'altra dimensione: i laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i loro Pastori nel servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vitalità della medesima, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia e i carismi che il Signore vorrà loro dispensare.
Non senza provare nel Nostro intimo una grande gioia osserviamo una legione di Pastori, di religiosi e di laici i quali, appassionati della loro missione evangelizzatrice, cercano modi sempre più adatti di annunziare efficacemente il Vangelo. Noi incoraggiamo l'apertura che, in questa linea e con questa sollecitudine, la Chiesa sta oggi realizzando. Innanzitutto apertura alla riflessione, poi a ministeri ecclesiastici capaci di ringiovanire e di rafforzare il suo dinamismo evangelizzatore. Certamente, accanto ai ministeri ordinati, grazie ai quali alcuni sono annoverati tra i Pastori e si consacrano in maniera particolare al servizio della comunità, la Chiesa riconosce il ruolo di ministeri non ordinati ma adatti ad assicurare speciali servizi della Chiesa stessa.
Uno sguardo alle origini della Chiesa è molto illuminante e permette di usufruire di un'antica esperienza, tanto più valida in quanto ha permesso alla Chiesa di consolidarsi, di crescere, e di espandersi. Ma questa attenzione alle fonti dev'essere completata da quella dovuta alle necessità presenti dell'umanità e della Chiesa. Dissetarsi a queste sorgenti sempre ispiratrici, nulla sacrificare di questi valori e sapersi adattare alle esigenze e ai bisogni attuali: queste sono le linee maestre che permetteranno di ricercare con saggezza e di valorizzare i ministeri, di cui la Chiesa ha bisogno e che molti suoi membri saranno lieti di abbracciare per la maggiore vitalità della comunità ecclesiale. Questi ministeri avranno un autentico valore pastorale nella misura in cui si stabiliranno nell'assoluto rispetto dell'unità, attenendosi all'orientamento dato dai Pastori, che sono appunto i responsabili e gli artefici dell'unità della Chiesa.
Tali ministeri, nuovi in apparenza ma molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza, - per esempio quelli di catechista, di animatori della preghiera e del canto, di cristiani dedicati al servizio della Parola di Dio o all'assistenza dei fratelli bisognosi, quelli infine dei capi di piccole comunità, dei responsabili di movimenti apostolici, o di altri responsabili - sono preziosi per la «plantatio», la vita e la crescita della Chiesa e per una capacità di irradiazione intorno a se stessa e verso coloro che sono lontani. Noi dobbiamo anche la nostra particolare stima a tutti i laici che accettano di consacrare una parte del loro tempo, delle loro energie, e talvolta la loro vita intera, al servizio delle missioni.
Per tutti gli operai dell'evangelizzazione è necessaria una seria preparazione. Lo è ancor più per coloro che si dedicano al ministero della Parola. Animati dalla convinzione continuamente approfondita della grandezza e della ricchezza della Parola di Dio, quelli che hanno il compito di trasmetterla devono manifestare la più grande attenzione alla dignità, alla precisione, all'adattamento del loro linguaggio. Tutti sanno che l'arte di parlare ha oggi una grandissima importanza. Come potrebbero trascurarla i predicatori e i catechisti?
Noi auspichiamo vivamente che, in ciascuna Chiesa particolare, i Vescovi vigilino alla formazione adeguata di tutti i ministri della Parola. Questa seria preparazione accrescerà in questi la sicurezza indispensabile ma anche l'entusiasmo per annunziare Gesù Cristo oggi.
VII. Lo spirito dell'evangelizzazione
PRESSANTE APPELLO
74. Non vorremmo terminare questo colloquio con i Nostri Fratelli e Figli amatissimi, senza un pressante appello riguardante le attitudini interiori che devono animare gli operai dell'evangelizzazione.
Nel nome del Signore Gesù Cristo, e nel nome degli Apostoli Pietro e Paolo, Noi esortiamo tutti coloro che, grazie ai carismi dello Spirito Santo e al mandato della Chiesa, sono veri evangelizzatori, ad essere degni di questa vocazione, ad esercitarla senza le reticenze del dubbio e della paura, e a non trascurare le condizioni che renderanno tale evangelizzazione non soltanto possibile ma anche attiva e fruttuosa. Ecco le condizioni fondamentali che, fra molte altre, Noi desideriamo mettere in rilievo.
AL SOFFIO DELLO SPIRITO SANTO
75. L'evangelizzazione non sarà mai possibile senza l'azione dello Spirito Santo. Su Gesù di Nazareth, lo Spirito discende nel momento del battesimo, quando la voce del Padre - «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» (107) - manifesta in modo sensibile la sua elezione e la sua missione. «Condotto dallo Spirito», egli vive nel deserto la lotta decisiva e la prova suprema prima di iniziare tale missione (108). «Con la potenza dello Spirito» (109) egli ritorna in Galilea, e a Nazareth dà inizio alla sua predicazione, applicando a se stesso il brano di Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me». «Oggi - egli proclama - si è adempiuta questa Scrittura» (110). Ai discepoli quando è sul punto di inviarli, dice alitando su di loro: «Ricevete lo Spirito Santo» (111).
Di fatto, soltanto dopo la discesa dello Spirito Santo, nel giorno della Pentecoste, gli apostoli partono verso tutte le direzioni del mondo per cominciare la grande opera di evangelizzazione della Chiesa, e Pietro spiega l'evento come realizzazione della profezia di Gioele: «Io effonderò il mio Spirito» (112). Pietro è ricolmato di Spirito Santo per parlare al popolo su Gesù, Figlio di Dio (113). Paolo a sua volta, è riempito di Spirito Santo (114) prima di dedicarsi al suo ministero apostolico, come pure lo è Stefano quando è scelto per esercitare la diaconia, e più tardi per la testimonianza del martirio (115). Lo stesso Spirito che fa parlare Pietro, Paolo o gli altri Apostoli, ispirando loro le parole da dire, discende anche «sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso» (116).
«Colma del conforto dello Spirito Santo», la Chiesa «cresce» (117). Lo Spirito è l'anima di questa Chiesa. È lui che spiega ai fedeli il significato profondo dell'insegnamento di Gesù e del suo mistero. È lui che, oggi come agli inizi della Chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, predisponendo nello stesso tempo l'animo di chi ascolta perché sia aperto ad accogliere la Buona Novella e il Regno annunziato.
Le tecniche dell'evangelizzazione sono buone, ma neppure le più perfette tra di esse potrebbero sostituire l'azione discreta dello Spirito. Anche la preparazione più raffinata dell'evangelizzatore, non opera nulla senza di lui. Senza di lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui, i più elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi di valore.
Noi stiamo vivendo nella Chiesa un momento privilegiato dello Spirito. Si cerca da per tutto di conoscerlo meglio, quale è rivelato dalle Sacre Scritture. Si è felici di porsi sotto la sua mozione. Ci si raccoglie attorno a lui e ci si vuol lasciar guidare da lui. Ebbene, se lo Spirito di Dio ha un posto eminente in tutta la vita della Chiesa, egli agisce Soprattutto nella missione evangelizzatrice: non a caso il grande inizio dell'evangelizzazione avvenne il mattino di Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito.
Si può dire che lo Spirito Santo è l'agente principale dell'evangelizzazione: è lui che spinge ad annunziare il Vangelo e che nell'intimo delle coscienze fa accogliere e comprendere la parola della salvezza (118). Ma si può parimente dire che egli è il termine dell'evangelizzazione: egli solo suscita la nuova creazione, l'umanità nuova a cui l'evangelizzazione deve mirare, con quella unità nella varietà che l'evangelizzazione tende a provocare nella comunità cristiana. Per mezzo di lui il Vangelo penetra nel cuore del mondo, perché egli guida al discernimento dei segni dei tempi - segni di Dio - che l'evangelizzazione discopre e mette in valore nella storia.
Il Sinodo dei Vescovi del 1974, che ha molto insistito sul ruolo dello Spirito Santo nell'evangelizzazione, ha espresso anche il voto che Pastori e teologi - e Noi aggiungeremo anche i fedeli, segnati dal sigillo dello Spirito per mezzo del Battesimo - studino meglio la natura e il modo di agire dello Spirito Santo nell'odierna evangelizzazione. Facciamo nostro questo voto, mentre esortiamo in pari tempo gli evangelizzatori - chiunque essi siano - a pregare incessantemente lo Spirito Santo con fede e fervore, e a lasciarsi prudentemente guidare da lui quale ispiratore decisivo dei loro programmi, delle loro iniziative, della loro attività evangelizzatrice.
TESTIMONI AUTENTICI
76. Consideriamo ora la persona stessa degli evangelizzatori. Si ripete spesso, oggi, che il nostro secolo ha sete di autenticità. Soprattutto a proposito dei giovani, si afferma che hanno orrore del fittizio, del falso, e ricercano sopra ogni cosa la verità e la trasparenza.
Questi «segni dei tempi» dovrebbero trovarci all'erta. Tacitamente o con alte grida, ma sempre con forza, ci domandano: Credete veramente a quello che annunziate? Vivete quello che credete? Predicate veramente quello che vivete? La testimonianza della vita è divenuta più che mai una condizione essenziale per l'efficacia profonda della predicazione. Per questo motivo, eccoci responsabili, fino ad un certo punto, della riuscita del Vangelo che proclamiamo.
«Che ne è della Chiesa a dieci anni dalla fine del Concilio?», ci domandavamo all'inizio di questa meditazione. È veramente radicata nel cuore del mondo, e tuttavia abbastanza libera e indipendente per interpellare il mondo? Rende testimonianza della propria solidarietà verso gli uomini, e nello stesso tempo verso l'Assoluto di Dio? È più ardente nella contemplazione e nell'adorazione, e in pari tempo più zelante nell'azione missionaria, caritativa, di liberazione? È sempre più impegnata nello sforzo di ricercare il ristabilimento della piena unità dei cristiani, che rende più efficace la testimonianza comune «affinché il mondo creda»? (119) Siamo tutti responsabili delle risposte che si potrebbero dare a questi interrogativi.
Noi esortiamo dunque i nostri Fratelli nell'episcopato, posti dallo Spirito Santo a governare la Chiesa (120). Esortiamo i sacerdoti e i diaconi, collaboratori dei Vescovi nel radunare il popolo di Dio e nell'animazione spirituale delle comunità locali. Esortiamo i religiosi, testimoni d'una Chiesa chiamata alla santità, e quindi partecipi essi stessi di una vita che esprime le beatitudini evangeliche. Esortiamo i laici: famiglie cristiane, giovani e adulti, quanti esercitano un mestiere, i dirigenti, senza dimenticare i poveri spesso ricchi di fede e di speranza, tutti i laici consapevoli del loro ruolo di evangelizzazione al servizio della Chiesa o in mezzo alla società e al mondo. Lo diciamo a tutti: bisogna che il nostro zelo per l'evangelizzazione scaturisca da una vera santità di vita, e che la predicazione, alimentata dalla preghiera e soprattutto dall'amore all'Eucaristia, a sua volta - come ci ricorda il Concilio Vaticano II - faccia crescere in santità colui che predica (121).
Il mondo, che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosamente il bisogno, reclama evangelizzatori che gli parlino di un Dio, che essi conoscano e che sia a loro familiare, come se vedessero l'Invisibile (122). Il mondo esige e si aspetta da noi semplicità di vita, spirito di preghiera, carità verso tutti e specialmente verso i piccoli e i poveri, ubbidienza e umiltà, distacco da noi stessi e rinuncia. Senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda.
ARTEFICI DI UNITÀ
77. La forza dell'evangelizzazione risulterà molto diminuita se coloro che annunziano il Vangelo sono divisi tra di loro da tante specie di rotture. Non starebbe forse qui uno dei grandi malesseri dell'evangelizzazione oggi? Infatti, se il Vangelo che proclamiamo appare lacerato da discussioni dottrinali, da polarizzazioni ideologiche o da condanne reciproche tra cristiani in balìa delle loro diverse teorie sul Cristo e sulla Chiesa, ed anche a causa delle loro diverse concezioni su la società e le istituzioni umane, come potrebbero coloro a cui è rivolta la nostra predicazione non sentirsene turbati, disorientati, se non addirittura scandalizzati?
Il testamento spirituale del Signore ci dice che l'unità tra i suoi seguaci non è soltanto la prova che noi siamo suoi, ma anche che egli è l'inviato del Padre, criterio di credibilità dei cristiani e del Cristo medesimo. In quanto evangelizzatori, noi dobbiamo offrire ai fedeli di Cristo l'immagine non di uomini divisi e separati da litigi che non edificano affatto, ma di persone mature nella fede, capaci di ritrovarsi insieme al di sopra delle tensioni concrete, grazie alla ricerca comune, sincera e disinteressata della verità. Sì, la sorte dell'evangelizzazione è certamente legata alla testimonianza di unità data dalla Chiesa. È questo un motivo di responsabilità ma anche di conforto.
A questo punto vogliamo sottolineare il segno dell'unità tra tutti i cristiani come via e strumento di evangelizzazione. La divisione dei cristiani è un grave stato di fatto che perviene ad intaccare la stessa opera di Cristo. Il Concilio Vaticano II afferma con lucidità e fermezza che essa «è di grave pregiudizio alla santa causa della predicazione del Vangelo a tutti gli uomini e impedisce a molti di abbracciare la fede» (123). Per questo, nell'indire l'Anno Santo abbiamo creduto necessario ricordare a tutti i fedeli del mondo cattolico che «la riconciliazione di tutti gli uomini con Dio, nostro Padre, dipende dal ristabilimento della comunione di coloro che già hanno riconosciuto ed accolto nella fede Gesù Cristo come il Signore della misericordia che libera gli uomini e li unisce nello Spirito di amore e di verità» (124).
È con un forte sentimento di speranza che Noi guardiamo agli sforzi che si fanno nel mondo cristiano per tale ristabilimento della piena unità voluta da Cristo. S. Paolo ce ne assicura: «la speranza non delude» (125).
Mentre lavoriamo ancora per ottenere dal Signore la piena unità, vogliamo intensificata la preghiera. Inoltre facciamo Nostro il voto dei Padri della terza Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, che si collabori con maggiore impegno con i fratelli cristiani, basandoci sul fondamento del Battesimo e sul patrimonio di fede che ci è comune, per rendere sin d'ora, nella stessa opera di evangelizzazione, una più larga testimonianza comune a Cristo di fronte al mondo. Ci spinge a ciò il Comando di Cristo, lo richiede il dovere di predicare e di rendere testimonianza al Vangelo.
SERVITORI DELLA VERITÀ
78. Il Vangelo che ci è stato affidato è anche parola di verità. Una verità che rende liberi (126) e che sola può donare la pace del cuore: questo cercano gli uomini quando annunziamo loro la Buona Novella. Verità su Dio, verità sull'uomo e sul suo destino misterioso, verità sul mondo. Verità difficile che ricerchiamo nella Parola di Dio ma di cui non siamo, lo ripetiamo, né padroni né arbitri, ma i depositari, gli araldi, i servitori.
Da ogni evangelizzatore ci si attende che abbia il culto della verità, tanto più che la verità da lui approfondita e comunicata è la verità rivelata e quindi - più d'ogni altra - parte della verità primordiale, che è Dio stesso. Il predicatore del Vangelo sarà dunque colui che, anche a prezzo della rinuncia personale e della sofferenza, ricerca sempre la verità che deve trasmettere agli altri. Egli non tradisce né dissimula mai la verità per piacere agli uomini, per stupire o sbalordire, né per originalità o desiderio di mettersi in mostra. Egli non rifiuta la verità; non offusca la verità rivelata per pigrizia nel ricercarla, per comodità o per paura. Non trascura di studiarla; la serve generosamente senza asservirla. In quanto pastori del popolo fedele, il nostro servizio pastorale ci sprona a custodire, difendere e comunicare la verità senza badare a sacrifici. Numerosi eminenti e santi Pastori ci hanno lasciato l'esempio di questo amore - in molti casi eroico - della verità. Il Dio di verità attende che noi ne siamo i difensori vigilanti e i predicatori devoti. Quanti siete dottori, teologi, esegeti, studiosi di storia: l'opera di evangelizzazione ha bisogno del vostro indefesso lavoro di ricerca, nonché della vostra attenzione e delicatezza nella trasmissione della verità a cui i vostri studi vi avvicinano, ma che è sempre più grande del cuore dell'uomo, perché è la verità stessa di Dio.
Genitori c maestri, il vostro compito - che i molteplici conflitti attuali non rendono certo facile - consiste nell'aiutare i vostri figli e i vostri alunni nella scoperta della verità, compresa la verità religiosa e spirituale.
ANIMATI DALL'AMORE
79. L'opera dell'evangelizzazione suppone nell'evangelizzatore un amore fraterno sempre crescente verso coloro che egli evangelizza. L'Apostolo Paolo, modello di ogni evangelizzatore, scriveva ai Tessalonicesi queste parole. che sono un programma per tutti noi: «Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari» (127). Quale è questa affezione? Ben più di quella di un pedagogo, essa è quella di un padre; e ancor più: quella di una madre (128). Il Signore attende da ciascun predicatore del Vangelo e da ogni costruttore della Chiesa tale affezione. Un segno d'amore sarà la cura di donare la verità e di introdurre nell'unità. Un segno d'amore sarà parimente dedicarsi senza riserve, né sotterfugi all'annuncio di Gesù Cristo. Aggiungiamo qualche altro segno di questo amore.
Il primo è il rispetto della situazione religiosa e spirituale delle persone che vengono evangelizzate, Rispetto del loro ritmo, che non si ha diritto di forzare oltre misura. Rispetto della loro coscienza e delle loro convinzioni, senza alcuna durezza.
Un altro segno è l'attenzione a non ferire l'altro, soprattutto se egli è debole nella fede (129), con affermazioni che possono essere chiare per gli iniziati, ma diventare per i fedeli fonte di turbamento e di scandalo, come una ferita nell'anima.
Un segno d'amore sarà anche lo sforzo di trasmettere ai cristiani, non dubbi e incertezze nati da una erudizione male assimilata, ma al, cune certezze solide, perché ancorate nella Parola di Dio. I fedeli hanno bisogno di queste certezze per la loro vita cristiana, ne hanno diritto in quanto sono figli di Dio che, tra le sue braccia, s'abbandonano interamente alle esigenze dell'amore.
COL FERVORE DEI SANTI
80. Il Nostro appello si ispira qui al fervore dei più grandi predicatori ed evangelizzatori, la cui vita fu dedicata all'apostolato: e tra essi Ci piace particolarmente mettere in rilievo quelli che Noi, in questo Anno Santo, abbiamo proposto alla venerazione dei fedeli. Essi hanno saputo superare tanti ostacoli alla evangelizzazione.
Tra tali ostacoli, che sono anche dei nostri tempi, Noi ci limiteremo a segnalare la mancanza di fervore, tanto più grave perché nasce dal di dentro; essa si manifesta nella negligenza e soprattutto nella mancanza di gioia e di speranza. Noi, pertanto, esortiamo tutti quelli che hanno, a qualche titolo e a qualche livello, il compito dell'evangelizzazione ad alimentare il fervore dello spirito (130). Questo fervore esige prima di tutto che sappiamo sottrarci agli alibi che possono sviare dall'evangelizzazione. I più insidiosi sono certamente quelli per i quali si pretende di trovare appoggio nel tale o tal altro insegnamento del Concilio.
Avviene così che si sente dire troppo spesso, sotto diverse forme: imporre una verità, sia pure quella del Vangelo, imporre una via, sia pure quella della salvezza, non può essere che una violenza alla libertà religiosa. Del resto, aggiungono, perché annunziare il Vangelo dal momento che tutti sono salvati dalla rettitudine del cuore? Se, d'altra parte, il mondo e la storia sono pieni dei «germi del Verbo», non è una illusione pretendere di portare il Vangelo là dove esso già si trova nei semi, che il Signore stesso vi ha sparsi?
Chiunque si prenda cura di approfondire, nei documenti conciliari, le domande che questi alibi vi attingono troppo superficialmente, troverà tutt'altra visione della realtà.
Sarebbe certo un errore imporre qualcosa alla coscienza dei nostri fratelli. Ma proporre a questa coscienza la verità evangelica e la salvezza in Gesù Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto delle libere opzioni che essa farà - senza «spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti» (131) - lungi dall'essere un attentato alla libertà religiosa, è un omaggio a questa libertà, alla quale è offerta la scelta di una via, che gli stessi non credenti stimano nobile ed esaltante. È dunque un crimine contro la libertà altrui proclamare nella gioia una Buona Novella che si è appresa per misericordia del Signore? (132) E perché solo la menzogna e l'errore, la degradazione e la pornografia avrebbero il diritto di essere proposti e spesso, purtroppo, imposti dalla propaganda distruttiva dei mass media, dalla tolleranza delle leggi, dalla timidezza dei buoni e dalla temerità dei cattivi? Questo modo rispettoso di proporre il Cristo e il suo Regno, più che un diritto, è un dovere dell'evangelizzatore. Ed è parimente un diritto degli uomini suoi fratelli di ricevere da lui l'annuncio della Buona Novella della salvezza. Questa salvezza Dio la può compiere in chi egli vuole attraverso vie straordinarie che solo lui conosce (133). Peraltro se il Figlio è venuto, ciò è stato precisamente per rivelarci, mediante la sua parola e la sua vita, i sentieri ordinari della salvezza. E ci ha ordinato di trasmettere agli altri questa rivelazione con la sua stessa autorità. Non sarà inutile che ciascun cristiano e ciascun evangelizzatore approfondisca nella preghiera questo pensiero: gli uomini potranno salvarsi anche per altri sentieri, grazie alla misericordia di Dio, benché noi non annunziamo loro il Vangelo; ma potremo noi salvarci se, per negligenza, per paura, per vergogna - ciò che S. Paolo chiamava «arrossire del Vangelo» (134) - o in conseguenza di idee false, trascuriamo di annunziarlo? Perché questo sarebbe allora tradire la chiamata di Dio che, per bocca dei ministri del Vangelo, vuole far germinare la semente; dipenderà da noi che questa diventi un albero e produca tutto il suo frutto.
Conserviamo dunque il fervore dello spirito. Conserviamo la dolce e confortante gioia d'evangelizzare, anche quando occorre seminare nelle lacrime. Sia questo per noi - come lo fu per Giovanni Battista, per Pietro e Paolo, per gli altri Apostoli, per una moltitudine di straordinari evangelizzatori lungo il corso della storia della Chiesa - uno slancio interiore che nessuno, né alcuna cosa potrà spegnere. Sia questa la grande gioia del1e nostre vite impegnate. Possa il mondo del nostro tempo, che cerca ora nell'angoscia, ora nella speranza, ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo, la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo, e accettino di mettere in gioco la propria vita affinché il Regno sia annunziato e la Chiesa sia impiantata nel cuore del mondo.
Conclusione
LA CONSEGNA DELL'ANNO SANTO
81. Ecco dunque, Fratelli e Figli, il grido che sale dal fondo del Nostro cuore, in eco alla voce dei Nostri Fratelli riuniti per la terza Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. Ecco la consegna che abbiamo voluto dare alla fine di un Anno Santo, che Ci ha permesso di percepire più che mai la necessità e le invocazioni di una moltitudine di fratelli, cristiani e non cristiani, che attendono dalla Chiesa la Parola della salvezza. Possa la luce dell'Anno Santo, che si è levata nelle Chiese particolari e a Roma per milioni di coscienze riconciliate con Dio, irradiarsi egualmente dopo il Giubileo attraverso un programma di azione pastorale, di cui l'evangelizzazione è l'aspetto fondamentale, per questi anni che segnano la vigilia di un nuovo secolo, la vigilia anche del terzo millennio del cristianesimo.
MARIA, STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE
82. Tale è il voto che siamo lieti di deporre nelle mani e nel cuore della Santissima Vergine Maria, l'Immacolata, in questo giorno che Le è particolarmente consacrato, nel decimo anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II. Al mattino della Pentecoste, Ella ha presieduto con la sua preghiera all'inizio dell'evangelizzazione sotto l'azione dello Spirito Santo: sia lei la Stella dell'evangelizzazione sempre rinnovata che la Chiesa, docile al mandato del suo Signore, deve promuovere e adempiere, soprattutto in questi tempi difficili ma pieni di speranza! Nel nome di Cristo, benediciamo voi, le vostre comunità, le vostre famiglie, tutti coloro che vi sono cari, con le parole che San Paolo rivolgeva ai Filippesi: «Ringrazio il mio Dio ogni volta ch'io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo . . . Vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, . . . nella difesa e nel consolidamento del Vangelo. Infatti, Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù» (135).
Dato a Roma, presso S. Pietro, l'8 dicembre, nella Solennità dell'Immacolata Concezione della B. V. Maria, dell'anno 1975, XIII del Nostro Pontificato.
PAOLO PP. VI
PER SCARICARE L'ESORTAZIONE APOSTOLICA "EVANGELII NUNTIANDI" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO
ISTRUZIONE " POSTQUAM APOSTOLI "
I. PROEMIO
Insegnamento del concilio Vaticano II
234
1. Dopo che agli apostoli venne affidata da Cristo Signore, prima della sua ascensione al cielo, la missione di essere testimoni "fino agli estremi confini della terra" (At 1,8), tutte le loro fatiche e sollecitudini non ebbero altro scopo che la fedele esecuzione del mandato di Cristo: "Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura" (Mc 16,15). La chiesa, come attesta la storia, lungo il corso dei secoli non ha mai cessato di impegnarsi con fedeltà e slancio per l’attuazione pratica di tale mandato. E anche recentemente circa lo stesso mandato, i successori degli apostoli radunati da tutto il mondo nel concilio ecumenico Vaticano II insistettero con queste parole: "(I pastori) si dimostrino solleciti di quelle parti del mondo, dove la parola di Dio non è stata ancora annunziata o dove, specialmente a motivo dello scarso numero di sacerdoti, i fedeli sono in pericolo di allontanarsi dalla pratica della vita cristiana, anzi di perdere la stessa fede". Per questo motivo i vescovi abbiano cura "di preparare degni sacerdoti e ausiliari sia religiosi che laici, non solo per le missioni, ma anche per le regioni che hanno scarsezza di clero".(1)
Istituzione di una commissione per la distribuzione del clero
235
2. Per dare pratica attuazione a tale intenzione del concilio, il sommo pontefice Paolo VI, con il motuproprio Ecclesiae sanctae, volle che fosse istituita presso la Santa Sede una speciale commissione "con il compito di emanare principi generali per una migliore distribuzione del clero, tenendo conto delle necessità delle varie chiese".(2) La sede di tale commissione, come ha stabilito la cost. apost. Regimini ecclesiae universae, si trova presso la Congregazione per il clero. (3)
Su tale materia questo sacro dicastero ha già consultato le conferenze episcopali e ha celebrato un congresso internazionale a Malta nel 1970. (4) Inoltre dopo aver convocato spesso i suoi membri e udito più volte il parere degli altri organi della curia romana, questo stesso dicastero, ben ponderando l’importanza e l’opportunità della cosa, si è impegnato per la preparazione di norme direttive che ora, con l’approvazione del sommo pontefice, promulga per mezzo del presente documento.
II. NECESSITÀ DI ADEMPIERE IL MANDATO DI CRISTO
Tutta la chiesa È chiamata ad evangelizzare
236
3. Il mezzo con cui la chiesa deve adempiere il mandato di Cristo è l’evangelizzazione, sull’esempio del suo fondatore, che è stato il primo evangelizzatore. Essa, infatti, ha ritenuto sempre suo specifico e principale compito l’evangelizzazione. Esiste anzi soltanto per questo compito, come ebbero a dichiarare i vescovi nel sinodo del 1974: "Vogliamo nuovamente confermare che il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della chiesa".(5)
237
Ne segue che nessun battezzato e cresimato nella chiesa può esimersi da tale dovere, come ha ammonito il concilio Vaticano II: "Essendo tutta la chiesa missionaria ed essendo l’opera dell’evangelizzazione dovere fondamentale del popolo di Dio, il sacro concilio invita tutti ad un profondo rinnovamento interiore, affinché abbiano una viva coscienza della propria responsabilità in ordine alla diffusione del vangelo".(6)
Sebbene ogni cristiano debba collaborare nella missione della chiesa per la parte che gli spetta, considerata tuttavia la diversità dei membri per quanto concerne i compiti da adempiere, (7) diverso sarà il ruolo del vescovo, del presbitero, del religioso, come pure del laico.
Il ruolo del vescovo
238
4. Il dovere dell’evangelizzazione spetta anzitutto ai vescovi, i quali - "con Pietro e sotto Pietro" (8) - devono non solo curare l’opera dell’evangelizzazione per i fedeli della loro diocesi, ma sentire altresì la responsabilità per la salvezza del mondo intero. Infatti essi "in quanto membri del collegio episcopale e legittimi successori degli apostoli, sono tenuti per istituzione e precetto di Cristo (9) ad avere per tutta la chiesa una sollecitudine che, sebbene non esercitata con atti di giurisdizione, tuttavia sommamente contribuisce al bene della chiesa universale".(10)
239
Compito del vescovo è curare con ogni sforzo che nei fedeli venga istillato sin dalla prima infanzia e mantenuto in vita un autentico senso cattolico, (11) per amare tutto il corpo mistico di Cristo, specialmente nelle sue membra più povere, sofferenti e perseguitate a causa della giustizia. (12) Egli deve inoltre promuovere lo zelo missionario in mezzo al suo popolo, affinché agli operai del vangelo in terra di missione non vengano a mancare gli aiuti sia spirituali che materiali; deve incoraggiare le vocazioni dei giovani per le missioni, come pure indirizzare l’attenzione dei candidati al sacerdozio alla dimensione universale della loro missione, e quindi alla loro disponibilità a servire anche fuori diocesi. (13)
Il dovere dei presbiteri
240
5. I presbiteri, che insieme con i vescovi agiscono "in nome e nella persona di Cristo capo",(14) collaborano in modo eminente per la dilatazione del regno di Dio sulla terra con il loro ufficio di pastori di anime, con la predicazione della parola di Dio e con l’amministrazione dei sacramenti della nuova legge. (15) Essi, perciò, per mezzo del loro ministero "rendono visibile nella loro sede la chiesa universale". (16)
D’altra parte la stessa comunità cristiana per sua essenza necessita della presenza dei sacerdoti, perché essa non è formata veramente se non mediante il sacrificio di Cristo che "per le loro mani e in nome di tutta la chiesa viene offerto nell’eucaristia in modo incruento e sacramentale";(17) e tale azione liturgica costituisce il centro della comunità dei fedeli. (18) Pertanto molto giustamente fu dichiarato dal sinodo dei vescovi nel 1971 a riguardo del sacerdozio ministeriale: "Se venisse a mancare la presenza e l’azione del suo ministero (del sacerdote)... la chiesa non potrebbe avere la piena certezza della sua fedeltà e della sua continuità visibile".(19)
241
Sennonché tale dono spirituale che i presbiteri ricevono nella sacra ordinazione "non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza fino agli ultimi confini della terra, dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli".(20)
Cosicché tutti i sacerdoti devono alimentare tale disponibilità d’animo nel loro cuore, e se qualcuno ottiene dallo Spirito del Signore una particolare vocazione, con il consenso del suo vescovo, non rifiuterà di recarsi in un’altra diocesi per continuare il suo ministero. Comunque, tutti i sacerdoti devono essere sensibili ai bisogni della chiesa universale, e quindi informarsi sia sullo stato delle missioni, sia su quello delle chiese particolari che si trovano in qualche particolare difficoltà, affinché possano esortare i fedeli a partecipare ai bisogni della chiesa. (21)
La partecipazione dei religiosi
242
6. I religiosi e le religiose già in virtù della professione dei voti sono intimamente legati al mistero della chiesa, e quindi dall’indole stessa particolare della loro vita segue il dovere di adoperarsi affinché "il regno di Cristo sia radicato e consolidato negli animi e dilatato in ogni parte del mondo".(22) Di conseguenza il concilio Vaticano II non solo li esorta a mantenere lo spirito missionario, ma invita altresì gli istituti, salvo il loro specifico scopo, ad aggiornarsi per corrispondere alle situazioni odierne, in modo che "l’evangelizzazione nelle missioni diventi sempre più efficace".(23)
243
I religiosi e le religiose, poi, che appartengono a istituti missionari, furono e sono tuttora modelli di vita dedita interamente alla causa di Cristo. In essi è da ammirare quella prontezza che scaturisce dalla loro consacrazione a Dio, per cui essi sono disponibili in tutto per servire Dio, la chiesa e i fratelli; infatti "grazie alla loro consacrazione religiosa essi sono per eccellenza volontari e liberi per lasciare tutto e andare ad annunziare il vangelo fino ai confini del mondo".(24)
Essendo, infine, lo stato religioso un "dono speciale", esso è ordinato a favore di tutta la chiesa, la cui missione salvifica in nessun modo può prescindere dalla partecipazione dei religiosi. (25)
La chiamata dei laici
244
7. Tutti i laici, in virtù del battesimo e della cresima, sono chiamati dal Signore ad un effettivo apostolato: "La vocazione cristiana è per sua natura anche vocazione all’apostolato".(26) L’apostolato dei laici, sebbene si eserciti principalmente nelle parrocchie, dev’essere tuttavia esteso anche a livello interparrocchiale, diocesano, nazionale e internazionale. Essi, anzi, devono avere a cuore "le necessità del popolo di Dio in tutta la terra"; il che potrà effettuarsi aiutando le opere missionarie sia con sussidi materiali sia con servizi personali. (27)
245
I laici, inoltre, possono essere chiamati dalla gerarchia a una cooperazione più diretta e immediata all’apostolato. La chiesa, infatti, negli ultimi decenni ha scoperto le ricche possibilità e le vaste risorse che la collaborazione dei laici può offrire alla sua missione di salvezza. L’esortazione apostolica "Evangelii nuntiandi", già in base alle recenti esperienze, enumera varie mansioni, come quella di catechista, quella di cristiani dedicati al servizio della parola di Dio o alle opere di carità, quella di capi di piccole comunità, ecc. Tale collaborazione dei laici, utile dovunque, è utile soprattutto in terra di missione per la fondazione, l’animazione e lo sviluppo della chiesa. (28)
246
Tutti i membri della chiesa, adunque, siano essi pastori, laici o religiosi, partecipano, ciascuno a modo suo, alla natura missionaria della chiesa. La diversità dei membri, dovuta alla varietà dei ministeri o dei carismi, come l’apostolo ci insegna, deve essere intesa nel senso che "queste membra non hanno tutte le medesime funzioni", ma servendo gli uni agli altri, formano un solo corpo di Cristo (Rm 12,4) per poter meglio adempiere il proprio mandato; tutta la chiesa, infatti, è spinta dallo Spirito santo a cooperare affinché si realizzi il piano di Dio. (29)
III. L’ADEMPIMENTO DEL MANDATO DI CRISTO NEL NOSTRO TEMPO
Dati statistici della popolazione mondiale
247
8. Ora, se rivolgiamo la nostra attenzione al mondo da evangelizzare e, più precisamente, alla popolazione non cristiana, non può non colpirci l’insufficienza dei mezzi di cui oggi la chiesa dispone per affrontare l’immenso problema. Infatti, nel 1977, il nostro pianeta contava 4.094.110.000 abitanti, di cui soltanto 739.127.000 cattolici, ossia appena il 18% della popolazione mondiale. (30) Se poi vogliamo considerare il numero dei sacerdoti, paragonandolo con il numero degli abitanti del mondo, abbiamo questo quadro: per ogni 100.000 abitanti si hanno in Asia 2, in Africa 4, in America latina 13, in Oceania 26, nell’America del nord 29, in Europa 37 sacerdoti.
Disuguaglianza delle forze di apostolato nell’interno della chiesa
248
9. Inoltre, se si esamina la distribuzione dei sacri ministri fra gli stessi cattolici, i dati statistici mostrano questo quadro: per ogni 100.000 cattolici nell’America latina si trovano 16 sacerdoti, 33 in Africa del sud e in Estremo Oriente 43, in Europa 93, in Oceania 104, nell’America del nord 120, e 133 nel Medio-Oriente Asiatico. Da quanto si è detto si avverte questa grande sproporzione: mentre in Europa e in America del nord si trova il 45% dei cattolici del mondo, assistiti dal 77, 2% di tutti i sacerdoti della chiesa cattolica, nell’America latina e nelle Isole Filippine, invece, dove pure abita il 45% dei cattolici del mondo, soltanto 12, 62% dei preti prestano la loro assistenza spirituale. In altri termini, la proporzione dei sacerdoti, per lo stesso numero di fedeli, è di 4 a 1, a favore dell’Europa e dell’America del nord in confronto dell’America latina e delle Filippine. È da notare che quasi la stessa disuguaglianza si trova nelle medesime aree geografiche se si considera il numero dei diaconi, dei religiosi laici e delle religiose.
249
È vero che il problema di una miglior distribuzione del clero non si risolve semplicemente con il metodo numerico, poiché bisogna tener conto dell’evoluzione storica, delle specifiche condizioni delle chiese particolari più sviluppate, le quali, naturalmente, richiedono un maggior numero di ministri. Tuttavia i dati statistici, di cui sopra, conservano il loro peso che fa riflettere e presenta gravi problemi per coloro che hanno a cuore una sana evoluzione della chiesa e, soprattutto, per coloro che hanno autorità nella chiesa, come si dirà più avanti.
Il più grande ostacolo deriva dalla scarsità del clero
250
10. Per obbedire oggi alla volontà di Cristo in ordine alla evangelizzazione, il più grande ostacolo sembra derivare dalla forte diminuzione delle vocazioni sacerdotali e religiose; fenomeno, che negli ultimi decenni affligge molte, anche se non tutte, le regioni di antica tradizione cristiana, o per il numero esiguo dei candidati, o per la dolorosa defezione di alcuni, o per l’età media piuttosto alta dei sacerdoti.
251
Ma non bisogna dimenticare che tale penuria, se si guarda alle condizioni delle diocesi che si trovano in stato di maggior bisogno, è molto relativa, come si è visto nel numero precedente. In realtà la scarsezza del clero in sé non dovrebbe ostacolare la generosità. "Le diocesi che soffrono la scarsezza del clero - come già Pio XII ammoniva - non dovrebbero rifiutare di ascoltare le istanze supplichevoli provenienti dalle missioni che chiedono aiuto. L’obolo della vedova, secondo la parola del Signore, sia un esempio da seguire: se una diocesi povera soccorre un’altra povera, non potrà seguire un suo maggior impoverimento, poiché non si può mai vincere il Signore in generosità". (31)
252
Ogni chiesa particolare dovrebbe meditare la profezia messianica: "Saranno evangelizzati i poveri" (Lc7,28), affinché la prudenza troppo umana o terrestre non soffochi quei sentimenti di generosità che spingono ad offrire il dono della fede a tutti coloro che oggi potrebbero essere in qualche modo chiamati "poveri". Dobbiamo, pertanto, convincerci che il mandato di Cristo non potrà mai essere adempiuto, se una chiesa particolare volesse offrire alle chiese più povere soltanto il superfluo delle sue forze.
Il piano di Dio e l’esiguità delle forze umane
253
11. Se confrontiamo il numero dei cattolici con quello dei non cattolici, e nello stesso tempo riflettiamo sulla missione affidata oggi alla chiesa per l’adempimento del mandato di Cristo, facilmente potremmo essere presi dallo scoraggiamento, tanto più sapendo che tale sproporzione forse peggiorerà nel prossimo futuro, e che l’indifferentismo di moltissimi cattolici va aumentando, anche in conseguenza di altri mali, come il secolarismo, il naturalismo, il materialismo, ecc., che hanno invaso il tenore di vita nei paesi di antica tradizione cristiana.
254
Non dobbiamo però dimenticare che la chiesa - qualora si considerino i soli mezzi umani - mai si è trovata alla pari della grandezza della sua vocazione nel mondo. Anzi tale insufficienza fu prevista dallo stesso suo Fondatore, il quale designando i discepoli, diceva ad essi: "La messe è molta, ma gli operai sono pochi"; ed aggiungeva: "Pregate adunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe" (Lc 10,2), volendo con ciò inculcare nella mente dei discepoli che il mezzo più efficace per superare gli ostacoli è la preghiera, giacché qui non si tratta di un tentativo o impresa sul piano umano, ma della realizzazione di un disegno divino. Con la preghiera, infatti, per mezzo della quale ci riconosciamo bisognosi dell’aiuto di Dio, non solo assumiamo le nostre responsabilità nell’esecuzione del disegno divino e ci rendiamo così disponibili ad essere "inviati", ma, quel che più conta, esercitiamo altresì un influsso diretto sull’aumento stesso delle vocazioni, poiché il Signore ci ha espressamente avvertito che il numero degli operai dipende dalla preghiera.
255
Ci è stato bensì rivelato il disegno divino di salvezza per tutti gli uomini, ma rimane oscuro e misterioso quando il regno messianico giungerà alla sua pienezza: "Non sta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato in suo potere" (At 1,7). Con tali parole pare si dica anche che il mandato di Cristo, per potere essere realizzato, necessita del tempo. Invero la storia della chiesa ci dimostra che col passare dei secoli si verificarono momenti di grazia, quando moltitudini di popoli ricevevano il seme della parola di Dio; ma bisogna riconoscere che vi furono, ed anche ora vi sono tempi meno favorevoli, particolarmente per certe popolazioni. (32)
256
Scoprire i momenti e l’ora della grazia, e stabilire quali siano i popoli maturi per il vangelo, è compito di coloro che, illuminati dalla luce di Cristo, sono in grado di leggere i segni dei tempi, e soprattutto di coloro che lo Spirito santo ha posto a reggere la sua chiesa (At 20,28). Al riguardo, piace riferire l’esempio di papa Pio XII, che nell’enciclica "Fidei donum", aveva raccomandato a tutti i figli della chiesa la terra d’Africa, come continente già maturo per l’evangelizzazione. (33)
Testimonianza della chiesa primitiva
257
12. Quanto si è affermato concorda perfettamente con la storia della chiesa primitiva. Gli Atti degli apostoli dimostrano con evidenza (34) che i nostri antenati nella fede pensavano in questo modo. Il loro metodo apostolico era proprio questo: inviare i messaggeri del vangelo in altre regioni, senza preoccuparsi che la comunità locale fosse, nella sua totalità, convertita alla fede di Cristo. In questa maniera gli apostoli e i loro collaboratori obbedivano al comando di Cristo: "Andate e insegnate a tutte le genti" (Mt 28,19), riponendo tutta la loro fiducia nella volontà di Dio che vuole "che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità" (1Tm 2,4). Il concilio Vaticano II raccomanda lo stesso metodo: "È assai conveniente che le giovani chiese partecipino quanto prima, di fatto, alla missione universale della chiesa, inviando anch’esse missionari a predicare dappertutto il vangelo, anche se soffrono per la scarsezza del clero". E ne dà la ragione: "La comunione con la chiesa universale raggiungerà in un certo modo la sua perfezione solo quando anch’esse prenderanno parte attiva allo sforzo missionario diretto verso le altre nazioni". (35)
IV. COMPITI E DOVERI DELLE CHIESE PARTICOLARI
La chiesa particolare come comunità
258
13. La diocesi, come chiesa particolare, è una porzione del popolo di Dio che è affidata al vescovo con la collaborazione del presbiterio, per essere governata, e santificata. (36) Ma perché si formi una vera e viva comunità diocesana, è necessario che le strutture di base, e specialmente le parrocchie, coltivino il senso della diocesi e si sentano come cellule vive in essa, e così si inseriscano nella chiesa universale. (37) Perciò il concilio esorta i parroci a svolgere la loro funzione in modo che "i fedeli e le comunità parrocchiali si sentano realmente membri non solo della diocesi, ma anche della chiesa universale".(38)
In questa chiesa particolare "è veramente presente e agisce la chiesa, una, santa, cattolica e apostolica".(39) Ne segue che la diocesi deve riprodurre alla perfezione la chiesa universale nell’ambiente concreto; e bisogna che diventi un segno tale da poter additare Cristo a tutti coloro che con lei hanno un qualche rapporto. (40)
La chiesa particolare in rapporto con le altre chiese
259
14. Siccome la chiesa particolare è stata formata "secondo l’immagine della chiesa universale", (41) nel suo seno si rispecchia la speranza e l’angoscia, la gioia e la tristezza di tutta la chiesa. È vero che la chiesa particolare deve innanzitutto evangelizzare la porzione del popolo di Dio a lei affidata, ossia quelli che hanno perduto la fede oppure non la praticano più; (42) ad essa, tuttavia, incombe anche il sacrosanto dovere di "promuovere tutta l’attività che è comune alla chiesa universale".(43)
260
Ne segue che la chiesa particolare non può chiudersi in se stessa, ma, come parte viva della chiesa universale, deve aprirsi alle necessità delle altre chiese. Pertanto la sua partecipazione alla missione evangelizzatrice universale non è lasciata al suo arbitrio, anche se generoso, ma deve considerarsi come una fondamentale legge di vita; diminuirebbe, infatti, il suo slancio vitale, se essa, concentrandosi unicamente sui propri problemi, si chiudesse alle necessità delle altre chiese. Riprende invece nuovo vigore, tutte le volte che si allargano i suoi orizzonti verso gli altri. Tale dovere della chiesa particolare è chiaramente sottolineato dal concilio Vaticano II, in quanto afferma che il rinnovamento, anzi la sana riforma della chiesa particolare, dipende dal grado di carità ecclesiale con cui essa si sforza di portare il dono della fede alle altre chiese: "La grazia del rinnovamento non può crescere nelle comunità, se ciascuna di esse non allarga gli spazi della carità sino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per coloro che sono suoi membri".(44)
Il significato della collaborazione reciproca
261
15. La chiesa universale conseguirà un grande profitto, se le comunità diocesane si sforzeranno di sviluppare reciproci rapporti, scambiandosi aiuti e beni; sorgerà così quella comunione e cooperazione delle chiese fra di loro che oggi è quanto mai necessaria perché possa felicemente proseguire il lavoro della evangelizzazione. (45)
Parlando di questo argomento, si usano sovente espressioni, come quelle di "diocesi ricche" o "diocesi povere"; espressioni che potrebbero indurre in errore, come se una chiesa dia soltanto aiuto, e l’altra soltanto lo riceva. Invece la questione sta in altri termini: si tratta, infatti, di una scambievole collaborazione, perché esiste una vera reciprocità fra le due chiese, in quanto la povertà di una chiesa che riceve aiuto, rende più ricca la chiesa che si priva nel donare, e lo fa sia rendendo più vigoroso lo zelo apostolico della comunità più ricca, sia soprattutto comunicando le sue esperienze pastorali, che spesso sono utilissime e possono riguardare un metodo più semplice ma più efficace di lavoro pastorale, o gli ausiliari laici nell’apostolato, o le piccole comunità, ecc.
262
Gli artefici di questa comune collaborazione saranno gli stessi ministri, scelti dal vescovo, i quali si sentiranno come messaggeri della propria comunità, fungendo da ambasciatori di Cristo presso l’altra comunità. Per rendere, poi, più intenso e vivo questo reciproco scambio di esperienze pastorali, la diocesi, oppure anche una grande comunità parrocchiale, potrà fare un gemellaggio con un’altra comunità povera, alla quale oltre i sussidi materiali potrà inviare anche sacri ministri come collaboratori. Tale genere di cooperazione reciproca, come dimostra l’esperienza, potrà giovare moltissimo ad ambedue le comunità. (46)
Necessità di ascoltare le grida di aiuto
263
16. Stando così le cose, le chiese particolari devono sempre più prendere coscienza della loro comune responsabilità, e facendosi sensibili alle grida di aiuto, si dimostrino pronte ad aiutare coloro che ne hanno bisogno. Fra queste, sono anzitutto meritevoli di aiuto le chiese novelle che soffrono per la grave scarsezza di sacerdoti e per la mancanza di mezzi materiali; ma bisogna porgere aiuto anche a quelle chiese che, pur esistendo da antica data, per diverse circostanze si trovano in uno stato di grande debolezza. (47)
264
È chiaro che le chiese più bisognose possono essere grandemente aiutate con l’invio di sacerdoti e altri collaboratori. Lo scopo di tale aiuto non sarà, come è ovvio, di coprire semplicemente le lacune esistenti, ma piuttosto quello di inviare ministri tali che, una volta inseriti fra le forze dell’apostolato locale, diventino, a guisa di pedagoghi, veri educatori nella fede; di modo che le chiese locali, conservando il loro carattere autoctono, siano messe in condizione di diventare gradatamente più sviluppate e forti, onde provvedere in seguito con i propri mezzi alle loro necessità. Ciò spiega perché i vescovi e gli altri superiori sono pregati di inviare per questo genere di evangelizzazione "alcuni tra i loro migliori sacerdoti". (48)
Necessità di riformare le strutture ecclesiastiche
265
17. Perché una chiesa particolare possa più adeguatamente svolgere il suo compito di portare aiuto alle altre che si trovano in stato di bisogno, si richiede anzitutto che anche nel seno della stessa chiesa particolare si proceda ad una nuova revisione delle forze e ad una ristrutturazione dei quadri tradizionali. La ragione sta nel fatto che nelle regioni tradizionalmente cristiane si sono verificati fenomeni sociali che già di per sé hanno trasformato le strutture della società; quindi anche le strutture ecclesiastiche dovrebbero essere adattate alla nuova realtà. Basti qui citare fra i fenomeni nuovi: la trasmigrazione della gente nelle regioni industriali; l’urbanesimo con il conseguente spopolamento di altre zone; il problema generale degli emigrati sia per scopo di lavoro, sia per motivi politici; (49) il fenomeno così diffuso del turismo per periodi più o meno lunghi (ad esempio, in occasione delle ferie o di fine settimana). (50) Tali fenomeni richiedono una nuova presenza dei sacerdoti i quali in queste mutate circostanze di vita dovranno affrontare una cura d’anime specializzata.
266
Perciò s’impone il problema se e come rinnovare le strutture che una volta soddisfacevano bene al bisogno spirituale del popolo di Dio. Certamente tale revisione non è facile e richiede molta prudenza e circospezione. Il vescovo, con l’aiuto dei consigli sia presbiterale che pastorale, dovrebbe elaborare un progetto organico per un miglior impiego di coloro che partecipano effettivamente nella cura di anime. Rinviare tale problema non pare più possibile senza che la chiesa non abbia a soffrire danni. Infatti, non è raro il fatto che, nonostante la lamentata scarsezza del clero, vi siano sacerdoti i quali si sentono frustrati per un impegno che non riempie le loro giornate, e per conseguenza giustamente desidererebbero di lavorare più intensamente.
267
Il vescovo nell’intento di provvedere meglio alle necessità crescenti della cura di anime, ha il dovere di interessare i sacerdoti religiosi che, del resto, "sono da considerarsi in certo qual senso, come appartenenti al clero diocesano"; come pure tutti gli altri religiosi, uomini e donne, anche se esenti, i quali vivono e operano nel seno del popolo di Dio, perché anch’essi "sotto un particolare aspetto appartengono alla famiglia diocesana"; in ambedue i casi è da tener conto dell’indole propria di ciascun istituto religioso. (51) A questo proposito, la Congregazione per i vescovi, unitamente a quella per i religiosi e gli istituti secolari hanno pubblicato recentemente sapienti norme per una cordiale collaborazione sul piano formativo, operativo, e organizzativo. (52)
268
Negli ultimi tempi i pastori chiamano sempre più frequentemente laici al servizio delle comunità ecclesiali; ed essi, volentieri accettando varie mansioni, dedicano le loro energie al servizio della chiesa a tempo pieno o parziale. Così ai tempi, di oggi si riprende la prassi della chiesa dei primi tempi, quando i laici si impegnavano nei diversi servizi secondo le loro inclinazioni e carismi, e secondo i bisogni e l’utilità del popolo di Dio "per la crescita e la vitalità della comunità ecclesiale".(53)
V. GLI ORGANI DELLA COLLABORAZIONE FRA LE CHIESE PARTICOLARI
Le conferenze episcopali
269
18. Il ruolo principale e indispensabile per una più efficace collaborazione fra le chiese particolari spetta alle conferenze episcopali, le quali hanno come scopo specifico quello di coordinare la pastorale d’insieme. Al riguardo, il sommo pontefice Paolo VI così ha disposto nel motuproprio "Ecclesiae sanctae": "Spetterà ai sinodi patriarcali e alle conferenze episcopali, tenendo presente quanto prescritto dalla sede apostolica, stabilire ordinanze ed emettere norme per i vescovi, per ottenere un’opportuna distribuzione del clero sia del proprio territorio, sia di quello che provenga da altre regioni; con tale distribuzione si provveda alle necessità di tutte le diocesi del proprio territorio, e si pensi anche al bene delle chiese in terra di missione e nelle nazioni che soffrono per scarsezza del clero".(54)
270
Adunque, oltre a provvedere ai bisogni della cura pastorale nel proprio territorio, altre due necessità vengono raccomandate alle conferenze episcopali, e cioè il primo annuncio del vangelo in terra di missione e l’aiuto alle chiese più deboli in genere. Ambedue i compiti gravano su ciascuna chiesa particolare; tuttavia, affinché la cosa sia ben regolata, si richiede la collaborazione di tutti i vescovi della stessa nazione o del medesimo territorio. Per provvedere a queste necessità ciascuna conferenza episcopale deve costituire due commissioni: una per la miglior distribuzione del clero e un’altra per le missioni. (55) Poiché l’istituzione di quest’ultima intende promuovere lo zelo missionario ed ambedue hanno, in certo qual modo, uno scopo simile, pare sia necessaria la collaborazione fra le due commissioni, anzi, in qualche caso sembra più conveniente l’unificazione delle medesime.
Sollecitudine per i territori di missione
271
19. Per quanto riguarda il primo annuncio del vangelo, cioè le missioni, la direzione suprema delle relative questioni spetta alla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, che "ha competenza sulle cose che riguardano tutte le missioni istituite per diffondere dappertutto il regno di Cristo, e perciò sulla costituzione e sul cambiamento dei ministri necessari e delle circoscrizioni ecclesiastiche; nel proporre le persone che le reggano; nel promuovere in modo più efficiente il clero autoctono, al quale gradualmente vengano affidati più alti incarichi e il governo; nel dirigere e coordinare tutta l’attività missionaria in ogni parte della terra, riguardo sia ai missionari stessi, sia alla cooperazione missionaria dei fedeli". (56)
272
In questo contesto, spetta alle conferenze episcopali promuovere la fattiva partecipazione del clero diocesano all’apostolato nelle missioni; stabilire un determinato contributo in danaro per le opere missionarie; intensificare sempre più i rapporti con gli istituti missionari e collaborare affinché siano eretti o aiutati i seminari che servono alle missioni. (57)
Sempre in ordine alle opere missionarie, la commissione episcopale, costituita presso ogni conferenza episcopale, deve incrementare l’attività missionaria e la conveniente collaborazione fra le diocesi; perciò dovrà tenere rapporti con le altre conferenze e adoperarsi affinché nella ripartizione degli aiuti alle missioni, per quanto è possibile, sia mantenuta una giusta proporzione. (58)
Sollecitudine per le chiese particolari più bisognose
273
20. Come è stato detto sopra, ogni conferenza episcopale deve istituire un’altra commissione episcopale che abbia per compito "di indagare sulle necessità delle varie diocesi del suo territorio e sulle loro possibilità di offrire ad altre chiese alcuni elementi del proprio clero, e di fare eseguire le decisioni stabilite e approvate dalla conferenza, che interessano la distribuzione del clero, riferendole ai vescovi di quei territori".(59)
Il compito, pertanto, di tale commissione è duplice. Anzitutto quello di rimuovere gli eventuali squilibri nel proprio territorio. Non di rado, infatti, si nota una grande sproporzione circa il numero dei sacerdoti, essendovi alcune diocesi con abbondanza di clero e altre invece dove la scarsità di sacerdoti mette in pericolo la conservazione stessa della fede.
274
L’altro compito riguarda la sollecitudine verso le chiese particolari che si trovano fuori del proprio territorio, per aiutarle in forza di quel vincolo di comunione che esiste fra le chiese particolari stesse, di cui sopra si è parlato. Tale lavoro deve svolgersi con l’indagare anzitutto sulle necessità delle diocesi, tenendo conto della proporzione fra il numero dei fedeli e quello dei pastori; in seguito, si presenti alla conferenza episcopale un esposto sulle necessità più urgenti e sulle possibilità di aiutare le chiese più bisognose. Per quanto riguarda questo secondo compito della commissione, già sono state intraprese lodevoli iniziative che in questo campo producono lieti frutti. (60)
Collaborazione con i consigli dei superiori maggiori
275
21. Per il coordinamento delle attività di ministero e delle opere di apostolato nel territorio della medesima conferenza episcopale, si richiede una più stretta collaborazione fra il clero diocesano e gli istituti religiosi. La promozione di questo lavoro in comune spetta alla conferenza episcopale. Ma poiché una proficua cooperazione dipende molto da un atteggiamento che, mettendo in secondo ordine gli interessi particolari, mira unicamente al bene generale della chiesa, conviene che i vescovi e i superiori religiosi tengano delle riunioni, in tempi stabiliti, per esaminare il da farsi in comune nei rispettivi territori. (61) Per questo motivo il motuproprio "Ecclesiae sanctae" prescrive che si formi una commissione mista fra la conferenza episcopale e il consiglio nazionale dei superiori maggiori per le questioni che concernono l’una e l’altra parte. (62) L’argomento principale delle sedute di tale commissione mista dovrà riguardare proprio una migliore e più conveniente distribuzione delle forze di apostolato, determinando le priorità e le opzioni nel comune sforzo di promuovere un apostolato d’insieme. (63) Le deliberazioni di tale commissione dovranno essere poi sottoposte per competenza al giudizio della conferenza episcopale e del consiglio dei superiori religiosi. (64)
L’animazione dei fedeli
276
22. Non si può abbastanza sottolineare il primo e principale compito che incombe ad ambedue le commissioni, che è quello di tenere continuamente bene informata l’opinione pubblica dei fedeli sia sulle necessità delle missioni, sia sulla situazione delle chiese particolari che si trovano in difficoltà. Esse, perciò, devono utilizzare tutti i mezzi di comunicazione sociale, devono aiutare e diffondere riviste e altre pubblicazioni del genere, come pure intervenire nella preparazione ed esecuzione di programmi ben precisi, in modo da tenere in evidenza i problemi relativi. Scopo di tutto questo, oltre a una buona e rapida informazione, è quello di rendere sempre più coscienti i fedeli delle loro responsabilità e sviluppare in essi il senso della cattolicità attraverso una matura e fattiva collaborazione delle chiese particolari. (65)
VI. MINISTRI SACRI INVIATI IN ALTRE DIOCESI
Necessità di una vocazione speciale
277
23. Benché tutti i fedeli a modo loro debbano partecipare all’opera di evangelizzazione, tuttavia chi desidera esplicare il sacro ministero in un’altra diocesi, necessita di una vocazione speciale. In realtà, tutta la comunità, sotto la guida del vescovo, è tenuta con preghiere e opere di penitenza ad impetrare dallo Spirito santo il dono delle vocazioni, onde siano disponibili sacerdoti, religiosi e laici i quali, lasciata la patria, vadano ad espletare in un altro campo il mandato di Cristo. (66)
Per quanto concerne la preparazione degli animi giovanili, sin dalla prima età è necessario inculcare nei medesimi una mentalità veramente cattolica; per quel che riguarda poi i candidati al sacerdozio, durante la loro formazione occorre far sì che essi, oltre a coltivare l’amore verso la diocesi per il cui servizio sono ordinati, abbiano anche ad interessarsi di tutta la chiesa. (67)
Idoneità dei ministri
278
24. Questa speciale vocazione presuppone, tuttavia, una indole adatta e doti naturali particolari. Tra le qualità psichiche, si ritengono necessari fortezza d’animo e sincero spirito di servizio. Pertanto, nella direzione delle anime i superiori usino grande diligenza per trovare atti e idonei candidati. E poiché è da augurarsi che i vescovi destinino per quest’opera ottimi sacerdoti, questi non solo debbono essere abbondantemente forniti di una sicura dottrina sacra, ma devono anche distinguersi per fede robusta, speranza incrollabile e zelo per le anime, (68) affinché, per quanto sta in loro, possano veramente generare negli altri la fede.
La necessaria preparazione
279
25. Tutti i ministri che vanno in un’altra diocesi, hanno bisogno di un’adeguata preparazione per ciò che riguarda la formazione umana, l’ortodossia della dottrina e lo stile di vita apostolico. Coloro poi che si recheranno in una diocesi di altra nazione per annunciare il vangelo, devono ricevere una formazione speciale, debbono cioè conoscere la cultura e la religione di quel popolo; fare gran conto della lingua e dei costumi; acquisire pratica della lingua insieme alla comprensione delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini; esaminare infine con cura l’ordinamento morale e le intime convinzioni che quel popolo, secondo le sue sacre tradizioni, si è formato su Dio, sul mondo e sull’uomo. (69)
Convenzione richiesta per il passaggio
280
26. Il passaggio dei ministri, soprattutto se sacerdoti, da una diocesi all’altra, bisogna che avvenga ordinatamente. L’ordinario "a quo" fornisca all’ordinario "ad quem" notizie esatte e chiare su coloro che devono essere inviati, specialmente se i motivi del trasferimento diano adito a sospetti. È assolutamente necessario che i diritti e i doveri dei sacerdoti che spontaneamente si offrono a tale passaggio, vengano accuratamente definiti in una convenzione scritta tra il vescovo a quo e il vescovo "ad quem"; (70) detta convenzione, stilata anche con l’intervento del sacerdote, affinché abbia valore normativo, deve essere accettata e sottoscritta dal sacerdote stesso; copia della convenzione, poi, venga conservata presso il sacerdote e presso le due curie. Simile convenzione si faccia anche con gli ausiliari laici; per i religiosi, occorre osservare le costituzioni dell’istituto di provenienza. Il medesimo principio, fatta la proporzione, vale anche per i numeri seguenti.
Oggetto della convenzione
281
27. In questa convenzione bisogna definire: a) la durata del servizio; b) le mansioni del sacerdote e il luogo del ministero e dell’abitazione, tenuto conto delle condizioni di vita nella regione dove il sacerdote si reca; c) gli aiuti di vario genere e chi deve prestarli; d) le assicurazioni sociali in caso di malattia, di inabilità e di vecchiaia. Se sarà il caso, si potrà utilmente contemplare anche la possibilità di rivedere la patria dopo un certo periodo di tempo. Detta convenzione non può essere mutata, se non vi sia il consenso degli interessati. Rimane fermo il diritto del vescovo "ad quem" di rimandare il sacerdote nella propria diocesi, preavvisato il vescovo "a quo" e osservata l’equità naturale e canonica, qualora il suo ministero sia divenuto nocivo.
I doveri del vescovo "a quo" e "ad quem" verso i sacerdoti
282
28. Il vescovo "a quo" abbia, per quanto possibile, una speciale sollecitudine verso i sacerdoti che esercitano il sacro ministero fuori della propria diocesi, e li consideri come membri della sua comunità che operano lontano; e faccia ciò sia per lettera, sia visitandoli personalmente o tramite altri, sia aiutandoli secondo il tenore della convenzione. Il vescovo "ad quem" poi, il quale si avvantaggia dell’aiuto di questi sacerdoti, rimane il garante della loro vita sia materiale che spirituale, sempre secondo la convenzione.
I sacerdoti membri del presbiterio dell’altra diocesi
283
29. In regioni che differiscono notevolmente per lingua, costumi, condizioni sociali, salvo urgente necessità, non si inviino ordinariamente singoli sacerdoti, ma piuttosto in gruppo, affinché si prestino vicendevolmente aiuto. (71) Detto gruppo nondimeno si sforzi di inserirsi talmente in seno al clero locale da non arrecare minimamente pregiudizio ad una fraterna collaborazione.
I sacerdoti arrivati nell’altra diocesi riveriscano il vescovo del luogo e gli prestino obbedienza secondo la convenzione. Per quanto attiene al sistema di vita, si adattino alle condizioni dei sacerdoti autoctoni e si sforzino di coltivarne l’amicizia, poiché tutti formano un solo presbiterio sotto l’autorità del vescovo. (72) Perciò devono inserirsi nella comunità locale come se fossero membri nativi di quella chiesa particolare; il che esige una disponibilità di animo non comune e un profondo spirito di servizio. Essendo ministri aggregati ad una nuova famiglia, si astengano dall’esprimere giudizi e critiche sulla chiesa locale, lasciando il compito di svolgere tale ufficio profetico al vescovo, al quale spetta la piena responsabilità del governo della chiesa particolare.
Ritorno dei sacerdoti in patria
284
30. I sacerdoti che desiderano ritornare nella propria diocesi allo scadere del tempo stabilito nella convenzione, siano accolti volentieri; tale ritorno, allo stesso modo della missione, richiede una preparazione. Essi abbiano a godere di tutti i diritti nella diocesi di origine, cui rimasero incardinati, come se vi fossero stati impegnati senza interruzione nel sacro ministero. (73) Con le varie esperienze acquisite, i medesimi possono arrecare non lieve vantaggio spirituale alla propria diocesi. Inoltre, a quelli che ritornano, per assumere nuovi incarichi, sia concesso un periodo di tempo sufficiente, in modo da potere adattarsi alle mutate situazioni che fossero avvenute nel frattempo.
Incardinazione nella diocesi ospite
285
31. Circa l’incardinazione dei sacerdoti in altre diocesi, rimangono ancora in vigore le prescrizioni del Codice di diritto canonico. Tuttavia, per il conseguimento della medesima in forza della legge il motuproprio "Ecclesiae sanctae" ha emanato una nuova norma con la quale si tiene conto del servizio prestato: "Il chierico che passa legittimamente dalla propria diocesi ad un’altra, trascorsi cinque anni, sarà incardinato di diritto a quest’ultima diocesi se avrà manifestato per iscritto tale volontà sia all’ordinario della diocesi ospite, sia all’ordinario proprio, né entro quattro mesi abbia ricevuto da nessuno dei due un parere contrario".(74)
CONCLUSIONE
286
L’odierna situazione della chiesa, soprattutto per quanto riguarda l’insufficienza del clero per i bisogni più urgenti dell’evangelizzazione, potrebbe indurre molti ad una visione pessimistica delle cose e creare così un certo senso di scoraggiamento circa il futuro della chiesa. Un tal modo di pensare non è da cristiani, né tanto meno si addice a pastori d’anime. Questo, infatti, non è che un aspetto, non tutta la realtà ecclesiale, se la guardiamo non in maniera esteriore e superficiale, ma cristianamente, cioè con l’occhio della fede, la cui luce soprannaturale ci fa scorgere, attraverso l’intreccio degli avvenimenti umani, la presenza viva e operante dello Spirito santo che anima la chiesa e la conduce infallibilmente verso quel disegno di salvezza che Dio ha concepito per l’uomo e che realizza nonostante le violentissime opposizioni con cui si cerca di ostacolare il cammino della chiesa.
287
Pertanto, come sappiamo che lungo tutto il corso della storia della chiesa l’agente principale dell’evangelizzazione è lo Spirito santo, che opera sia muovendo i cristiani a far progredire il regno di Dio, sia aprendo i cuori degli uomini alla parola divina, così pure dobbiamo credere che sotto la direzione dello stesso Spirito è posto l’avvenire della chiesa. Nel frattempo, dovere di noi tutti è di pregarlo insistentemente e lasciarci fiduciosamente guidare da lui, adoperandoci con tutte le nostre forze affinché tra i fedeli permanga viva la convinzione della natura missionaria della chiesa, e cresca sempre più la consapevolezza della responsabilità che i singoli cristiani e soprattutto i pastori d’anime hanno verso la chiesa universale. Tale sforzo cerchiamo di compierlo e vivificarlo guidati e animati sempre dalla speranza cristiana "che non delude" (Rm 5,5), perché fondata sulle parole di Cristo, che in procinto di lasciare i suoi discepoli tra le insidie e le forze ostili di questo mondo, promise: "Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo" (Mt 28,20), "Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo" (Gv 16,33).
Roma, palazzo della Congregazione per il clero, 25 marzo 1980, solennità dell’annunciazione del Signore.
SILVIO card. ODDI,
prefetto.
MAXIMINO ROMERO DE LEMA,
arcivescovo tit. di Cittanova,
segretario.
PER SCARICARE L'ISTRUZIONE "POSTQUAM APOSTOLI" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

SLAVORUM APOSTOLI
DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II
AI VESCOVI, AI SACERDOTI,
ALLE FAMIGLIE RELIGIOSE,
A TUTTI I FEDELI CRISTIANI
NEL RICORDO
DELL'OPERA EVANGELIZZATRICE
DEI SANTI CIRILLO E METODIO
DOPO UNDICI SECOLI
I
INTRODUZIONE
1. Gli Apostoli degli Slavi, i santi Cirillo e Metodio, rimangono nella memoria della Chiesa insieme alla grande opera di evangelizzazione che hanno realizzato. Si può anzi affermare che il loro ricordo si è fatto particolarmente vivo ed attuale ai nostri giorni.
Considerando la venerazione piena di gratitudine, della quale i santi Fratelli di Salonicco (l'anticaTessalonica) godono da secoli, specialmente tra le Nazioni slave, e memore dell'inestimabile contributo da loro dato all'opera, dell'annuncio del Vangelo fra quelle genti e, al tempo stesso, alla causa della riconciliazione, dell'amichevole convivenza, dello sviluppo umano e del rispetto dell'intrinseca dignità di ogni Nazione, con la Lettera Apostolica Egregiae virtutis [1] in data 31 dicembre 1980 proclamai i santi Cirillo e Metodio compatroni d'Europa. Ripresi in tal modo la linea tracciata dai miei Predecessori e, segnatamente, da Leone XIII, il quale oltre cento anni fa, il 30 settembre 1880, estese a tutta la Chiesa il culto dei due Santi con l'Epistola enciclica Grande munus[2], e da Paolo VI, che, con la Lettera Apostolica Pacis nuntius [3] del 24 ottobre 1964, proclamò san Benedetto patrono d'Europa.
2. Il Documento di cinque anni fa mirava a ravvivare la consapevolezza di questi atti solenni della Chiesa ed intendeva richiamare l'attenzione dei cristiani e di tutti gli uomini di buona volontà, ai quali stanno a cuore il bene, la concordia e l'unità dell'Europa, all'attualità sempre viva delle eminenti figure di Benedetto, di Cirillo e di Metodio, come concreti modelli e sostegni spirituali per i cristiani della nostra età e, specialmente, per le Nazioni del continente europeo, le quali, già da tempo, soprattutto grazie alla preghiera e all'opera di questi Santi, si sono radicate consapevolmente ed originalmente nella Chiesa e nella tradizione cristiana.
La pubblicazione della citata mia Lettera Apostolica nel 1980, dettata dalla ferma speranza di un graduale superamento in Europa e nel mondo di tutto ciò che divide le Chiese, le Nazioni, i popoli si collegava a tre circostanze, che costituirono l'oggetto della mia preghiera e riflessione. La prima fu l'XI centenario della Lettera pontificia Industriae tuae [4], con la quale Giovanni VIII nell'anno 880 approvò l'uso della lingua slava nella liturgia tradotta dai due santi Fratelli. La seconda era rappresentata dal primo centenario della citata Epistola enciclica Grande munus. La terza fu l'inizio, proprio nell'anno 1980, del felice e promettente dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse nell'isola di Patmos.
3. Nel presente documento desidero fare riferimento in particolare all'Epistola, con la quale papaLeone XIII volle ricordare alla Chiesa e al mondo i meriti apostolici dei entrambi i Fratelli: non solo di Metodio, il quale, secondo la tradizione, concluse la sua vita nell'anno 885 a Velehrad nella Grande Moravia, ma anche di Cirillo che la morte separò dal fratello già nell'869 a Roma, la città che ne accolse e ne custodisce tuttora con commossa venerazione le reliquie nell'antica Basilica di san Clemente.
Ricordando la santa vita ed i meriti apostolici dei due Fratelli di Salonicco, papa Leone XIII fissò la loro festa liturgica al 7 luglio. Dopo il Concilio Vaticano II, a seguito della riforma liturgica, la festa fu trasferita al 14 febbraio, data che dal punto di vista storico segna la nascita al Cielo di san Cirillo [5].
Ad oltre un secolo dalla pubblicazione dell'Epistola leoniana le nuove circostanze, in cui viene a cadere l'undicesima ricorrenza centenaria della beata morte di san Metodio, inducono a dare rinnovata espressione alla memoria che la Chiesa conserva di questo importante anniversario. Ed a ciò si sente particolarmente obbligato il primo papa chiamato alla sede di san Pietro dalla Polonia e, dunque, dal mezzo delle Nazioni slave.
Gli eventi dell'ultimo secolo e, specialmente, degli ultimi decenni hanno contribuito a ravvivare nella Chiesa, col ricordo religioso, l'interesse storico-culturale per i due santi Fratelli, i cui speciali carismi sono divenuti ancor meglio intelligibili alla luce delle situazioni e delle esperienze proprie della nostra epoca. A ciò hanno concorso molti avvenimenti che appartengono, quali autentici segni dei tempi, alla storia del XX secolo e, prima di tutto, quel grande evento che si è verificato nella vita della Chiesamediante il Concilio Vaticano II. Alla luce del magistero e dell'indirizzo pastorale di quel Concilio, noi possiamo riguardare in un modo nuovo - più maturo e profondo - queste due sante Figure, dalle quali ci separano ormai undici secoli, e leggere, altresì, nella loro vita e attività apostolica i contenuti che la sapiente Provvidenza divina vi inscrisse, affinché si svelassero in una nuova pienezza nella nostra epoca e portassero nuovi frutti.
II
CENNI BIOGRAFICI
4. Seguendo l'esempio offerto dall'Epistola Grande munus , desidero ricordare la vita di san Metodio, senza per questo trascurare la vicenda, che tanto strettamente le è unita, del fratello san Cirillo. Ciò farò a grandi linee, lasciando alla ricerca storica le precisazioni e le discussioni intorno ai singoli punti.
La città, che vide nascere i due santi Fratelli, è l'attuale Salonicco, che nel secolo IX costituiva un importante centro di vita commerciale e politica dell'Impero bizantino cd occupava un posto di notevole rilievo nella vita intellettuale e sociale di quella regione dei Balcani. Essendo situata al confine dei territori slavi, essa aveva certamente anche un nome slavo: Solun.
Metodio era il fratello maggiore e verosimilmente il suo nome di battesimo era Michele. Egli nacque tra gli anni 815 e 820. Minore d'età, Costantino, in seguito meglio conosciuto col nome religioso di Cirillo, venne al mondo nell'anno 827 o 828. Il padre era un alto funzionario dell'amministrazione imperiale. Le condizioni sociali della famiglia schiudevano ai due Fratelli una carriera simile, che del resto Metodio intraprese, raggiungendo la carica di arconte, ossia di preposto in una delle province di frontiera, nella quale vivevano molti Slavi. Tuttavia, già verso l'anno 840 egli la interruppe per ritirarsi in uno dei monasteri ai piedi del monte Olimpo in Bitinia, noto allora col nome di Sacra Montagna.
Il fratello Cirillo seguì con particolare profitto gli studi a Bisanzio, dove ricevette gli ordini sacri, dopo avere decisamente rifiutato una brillante affermazione politica. Per le eccezionali doti e conoscenze culturali e religiose egli si vide affidare ancor giovane delicate mansioni ecclesiastiche, come quella di bibliotecario dell'archivio annesso alla grande Chiesa di Santa Sofia in Costantinopoli e, nel contempo, l'incarico prestigioso di segretario del Patriarca di quella stessa città. Ben presto, però, mostrò di volersi esimere da tali uffici, per dedicarsi agli studi e alla vita contemplativa, fuori da ogni mira ambiziosa. Così si rifugiò nascostamente in un monastero sulle coste del Mar Nero. Ritrovato, dopo sei mesi, venne convinto ad accettare l'insegnamento delle discipline filosofiche presso la Scuola superiore di Costantinopoli, guadagnandosi per l'eccellenza del sapere l'epiteto di Filosofo, con cui è tuttora conosciuto. Più tardi fu inviato dall'imperatore e dal Patriarca in missione presso i Saraceni. Portato a termine tale incarico, si ritirò dalla vita pubblica per raggiungere il fratello maggiore Metodio e condividere con lui la vita monastica. Ma nuovamente, insieme con lui, fu incluso in una delegazione bizantina inviata presso i Khazari, in qualità di esperto religioso e culturale. Durante la permanenza in Crimea presso Cherson, essi credettero di individuare la chiesa in cui anticamente era stato sepolto san Clemente, papa romano e martire, già esiliato in quelle lontane regioni, e ne recuperarono e portarono con sé le reliquie [6], che accompagnarono poi i due santi Fratelli nel successivo viaggio missionario verso Occidente, fino al momento in cui essi poterono deporle solennemente a Roma, consegnandole al papa Adriano II.
5. L'evento, che doveva decidere di tutto il corso ulteriore della loro vita, fu la richiesta rivolta dal principe Rastislav della Grande Moravia all'imperatore Michele III, di inviare ai suoi popoli «un Vescovo e maestro... che fosse in grado di spiegare loro la vera fede Cristiana nella loro lingua» [7].
Furono scelti i santi Cirillo e Metodio, i quali prontamente accettarono, poi si misero in viaggio e giunsero nella Grande Moravia - uno Stato comprendente allora diverse popolazioni slave dell'Europa centrale, al crocevia dei reciproci influssi tra Oriente e Occidente - probabilmente già nell'anno 863, intraprendendo tra quei popoli quella missione, alla quale dedicarono entrambi tutto il resto della vita, trascorso tra viaggi, privazioni, sofferenze, ostilità e persecuzioni, che per Metodio giunsero sino ad una crudele prigionia. Tutto essi sopportarono con forte fede ed invincibile speranza in Dio. Si erano, infatti, ben preparati al compito loro affidato: recavano con sé i testi della Sacra Scrittura indispensabili alla celebrazione della sacra liturgia, preparati e tradotti da loro in lingua paleoslava e scritti in un nuovo alfabeto, elaborato da Costantino Filosofo e perfettamente adatto ai suoni di tale lingua. L'attività missionaria dei due Fratelli fu accompagnata da un successo notevole, ma anche dalle comprensibili difficoltà che la precedente, iniziale cristianizzazione, condotta dalle Chiese latine limitrofe, poneva ai nuovi missionari.
Dopo circa tre anni, nel viaggio verso Roma, essi si soffermarono in Pannonia, dove il principe slavo Kocel fuggito dall'importante centro civile e religioso di Nitra offrì loro un'ospitale accoglienza. Da qui, dopo alcuni mesi, ripresero il cammino alla volta di Roma insieme con i loro discepoli, per i quali desideravano ottenere gli ordini sacri. Il loro itinerario passava per Venezia, dove vennero sottoposte a pubblica discussione le premesse innovatrici della missione che stavano svolgendo. A Roma il papa Adriano II, succeduto nel frattempo a Nicola I, li accolse molto benevolmente. Egli approvò i libri liturgici slavi, che ordinò di deporre solennemente sull'altare nella chiesa di Santa Maria ad Praesepe, oggi detta Santa Maria Maggiore, e raccomandò di ordinare Sacerdoti i loro discepoli. Questa fase delle loro fatiche si concluse in modo quanto mai favorevole. Metodio dovette, però, riprendere la tappa successiva da solo, perché il suo fratello minore, gravemente ammalato, fece appena in tempo ad emettere i voti religiosi e a rivestire l'abito monastico, poiché morì poco dopo, il 14 febbraio 869, a Roma .
6. San Metodio rimase fedele alle parole, che Cirillo gli aveva detto sul letto di morte: «Ecco, fratello, condividevamo la stessa sorte, premendo l'aratro sullo stesso solco; io ora cado sul campo al concludersi della mia giornata. Tu ami molto - lo so - la tua Montagna; tuttavia, per la Montagna non abbandonare la tua azione di insegnamento. Dove in verità puoi meglio salvarti?» [8].
Consacrato vescovo per il territorio dell'antica diocesi di Pannonia, nominato legato pontificio «ad gentes» (per le genti slave), egli assunse il titolo ecclesiastico della ristabilita sede vescovile di Sirmio. L'attività apostolica di Metodio, però, fu interrotta in seguito a complicazioni politico-religiose, che culminarono con la sua carcerazione per due anni, sotto l'accusa di aver invaso una giurisdizione episcopale altrui. Venne liberato solo dietro personale intervento del papa Giovanni VIII. Anche il nuovo sovrano della Grande Moravia, il principe Svatopluk, alla fine si mostrò contrario all'opera di Metodio, opponendosi alla liturgia slava ed insinuando a Roma dubbi sull'ortodossia del nuovo arcivescovo. Nell'anno 880 Metodio fu convocato ad limina Apostolorum, per presentare ancora una volta tutta la questione personalmente a Giovanni VIII. Nell'Urbe, assolto da tutte le accuse, egli ottenne dal papa la pubblicazione della bolla Industriae tuae [9], che, almeno nella sostanza, restituiva le prerogative riconosciute alla liturgia in lingua slava dal predecessore Adriano II.
Analogo riconoscimento di perfetta legittimità ed ortodossia Metodio ebbe anche da parte dell'imperatore bizantino e del patriarca Fozio, in quel tempo in piena comunione con Roma, quando nell'anno 881 o 882 si recò a Costantinopoli. Egli dedicò gli ultimi anni della vita soprattutto ad ulteriori traduzioni della Sacra Scrittura e dei libri liturgici, delle opere dei Padri della Chiesa ed anche della raccolta delle leggi ecclesiastiche e civili bizantine, detta Nomocanone. Preoccupato per la sopravvivenza dell'opera che aveva iniziato, designò come proprio successore il discepolo Gorazd. Morì il 6 aprile 885 al servizio della Chiesa instaurata tra i popoli slavi.
7. L'azione lungimirante, la dottrina profonda ed ortodossa, l'equilibrio, la lealtà, lo zelo apostolico, la magnanimità intrepida gli guadagnarono il riconoscimento e la fiducia di Pontefici Romani, di Patriarchi Costantinopolitani, di Imperatori bizantini e di diversi Prìncipi dei nuovi popoli slavi. Perciò, Metodio divenne la guida e il legittimo pastore della Chiesa. che in quell'epoca si radicava in mezzo a quelle Nazioni, ed è unanimamente venerato, insieme col fratello Costantino, quale annunciatore del Vangelo e maestro «da parte di Dio e del santo apostolo Pietro» [10] e come fondamento della piena unità tra le Chiese di recente fondazione e le Chiese più antiche.
Per questo, «uomini e donne, umili e potenti, ricchi e poveri, liberi e servi, vedove ed orfani, stranieri e gente del luogo, sani e malati» [11] costituivano la folla che tra le lacrime ed i canti accompagnava al luogo della sepoltura il buon maestro e pastore, che si era fatto «tutto a tutti per salvare tutti» [12].
A dire il vero, L'opera dei santi Fratelli, dopo la morte di Metodio, subì una grave crisi, e la persecuzione contro i suoi discepoli si acuì talmente, che questi furono costretti ad abbandonare il proprio campo missionario. Ciononostante, la loro seminagione evangelica non cessò di produrre frutti e il loro atteggiamento pastorale, preoccupato di portare la verità rivelata a popoli nuovi - rispettandone l'originalità culturale -, rimane un modello vivo per la Chiesa e per i missionari di tutti i tempi.
III
ARALDI DEL VANGELO
8. Bizantini di cultura, i fratelli Cirillo e Metodio seppero farsi apostoli degli Slavi nel pieno senso della parola. La separazione dalla patria che Dio talvolta esige dagli uomini eletti, accettata per la fede nella sua promessa, è sempre una misteriosa e fertile condizione per lo sviluppo e la crescita del Popolo di Dio sulla terra. Il Signore disse ad Abramo: «Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione» [13].
Durante la visione notturna che san Paolo ebbe a Troade nell'Asia Minore, un Macedone, dunque un abitante del continente europeo, si presentò davanti a lui e lo implorò di recarsi in viaggio nel suo paese per annunziarvi la Parola di Dio: «Passa in Macedonia e aiutaci» [14].
La divina Provvidenza, che per i due santi Fratelli si espresse con la voce e l'autorità dell'imperatore di Bisanzio e del Patriarca della Chiesa di Costantinopoli, indirizzò loro un'esortazione simile, allorché chiese ad essi di recarsi in missione tra gli Slavi. Tale incarico significava per loro abbandonare non solo un posto di onore, ma anche la vita contemplativa; significava uscire dall'àmbito dell'impero bizantino ed intraprendere un lungo pellegrinaggio al servizio del Vangelo, tra popoli che, sotto molti aspetti, restavano lontani da un sistema di convivenza civile basato sull'avanzata organizzazione dello Stato e la raffinata cultura di Bisanzio permeata di princìpi cristiani. Analoga domanda rivolse a tre riprese a Metodio il Pontefice Romano, quando lo inviò come vescovo tra gli Slavi della Grande Moravia, nelle regioni ecclesiastiche dell'antica diocesi di Pannonia.
9. La Vita slava di Metodio presenta con queste parole la richiesta, rivolta dal principe Rastislav all'imperatore Michele III per il tramite dei suoi inviati: «Sono giunti da noi numerosi maestri cristiani dall'Italia, dalla Grecia e dalla Germania, che ci istruiscono in diversi modi. Ma noi Slavi... non abbiamo nessuno che ci indirizzi verso la verità e ci istruisca in modo comprensibile» [15]. È allora che Costantino e Metodio furono invitati a partire. La loro risposta profondamente cristiana all'invito, in questa circostanza e in tutte le occasioni simili, è mirabilmente espressa dalle parole indirizzate da Costantino all'imperatore: «Per quanto stanco e fisicamente provato, io andrò con gioia in quel paese» [16]; «con gioia io parto per la fede cristiana» [17].
La verità è la forza del loro mandato missionario nascevano dal profondo del mistero della Redenzione, e la loro opera evangelizzatrice tra i popoli slavi doveva costituire un importante anello nella missione affidata dal Salvatore fino alla fine dei tempi alla Chiesa universale. Essa fu adempimento - nel tempo e nelle circostanze concrete - delle parole di Cristo, il quale nella potenza della sua Croce e della sua Risurrezione ordinò agli apostoli: «Predicate il Vangelo a ogni creatura»[18]; «andando ammaestrate tutte le nazioni» [19]. Così facendo, gli evangelizzatori e maestri dei popoli slavi si lasciarono guidare dall'ideale apostolico di san Paolo: «Tutti voi, infatti, siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più Giudeo né Greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù» [20].
Accanto ad un grande rispetto per le persone e alla sollecitudine disinteressata per il loro vero bene, i due santi Fratelli ebbero adeguate risorse di energia, di prudenza, di zelo e di carità, indispensabili per portare ai futuri credenti la luce, e per indicare loro, al tempo stesso, il bene, offrendo un concreto aiuto per raggiungerlo. A tale scopo desiderarono diventare simili sotto ogni aspetto a coloro ai quali recavano il Vangelo; vollero diventare parte di quei popoli e condividerne in tutto la sorte.
10. Proprio per tale motivo trovarono naturale prendere una chiara posizione in tutti i conflitti, che allora turbavano le società slave in via di organizzazione, assumendone come proprie le difficoltà e i problemi, inevitabili per dei popoli che difendevano la propria identità sotto la pressione militare e culturale del nuovo Impero romano-germanico, e tentavano di respingere quelle forme di vita che avvertivano come estranee. Era anche l'inizio di più ampie divergenze, destinate malauguratamente ad accentuarsi, tra la cristianità orientale e quella occidentale, ed i due santi missionari vi si trovarono personalmente coinvolti; ma seppero mantenere sempre un'ineccepibile ortodossia ed una coerente attenzione sia al deposito della tradizione che alle novità di vita, proprie dei popoli evangelizzati. Spesso le situazioni di contrasto si imposero in tutta la loro ambigua e dolorosa complessità; non per questo Costantino e Metodio tentarono di sottrarsi alla prova: l'incomprensione, l'aperta malafede e perfino, per san Metodio, le catene, accettate per amore di Cristo, non fecero deflettere né l'uno né l'altro dal tenace proposito di giovare e di servire al bene delle genti slave e all'unità della Chiesa universale. Fu questo il prezzo che dovettero pagare per la diffusione del Vangelo, per l'impresa missionaria, per la coraggiosa ricerca di nuove forme di vita e di vie efficaci per far giungere la Buona Novella alle Nazioni slave che si stavano formando.
Nella prospettiva dell'evangelizzazione - come indicano le loro biografie - i due santi Fratelli si volsero al difficile compito di tradurre i testi della Sacra Scrittura, noti loro in greco, nella lingua di quella stirpe slava che si era stabilita fino ai confini della loro regione e della loro città natale. Avvalendosi della loro padronanza nella lingua greca e della propria cultura per quest'opera ardua e singolare, si prefissero di comprendere e di penetrare la lingua, le usanze e le tradizioni proprie delle genti slave, interpretandone fedelmente le aspirazioni ed i valori umani che in esse sussistevano e si esprimevano.
11. Per tradurre le verità evangeliche in una lingua nuova, essi dovettero preoccuparsi di conoscere bene il mondo interiore di coloro, ai quali avevano intenzione di annunciare la Parola di Dio con immagini e concetti che suonassero loro familiari. Innestare correttamente le nozioni della Bibbia e i concetti della teologia greca in un contesto di esperienze storiche e di pensieri molto diversi, apparve loro una condizione indispensabile per la riuscita dell'attività missionaria. Si trattava di un nuovo metodo di catechesi. Per difenderne la legittimità e dimostrarne la bontà, san Metodio non esitò, prima insieme col fratello e poi da solo, ad accogliere docilmente gli inviti a Roma, ricevuti sia nell'867 dal papa Nicola I, sia nell'anno 879 del papa Giovanni VIII, i quali vollero confrontare la dottrina che essi insegnavano nella Grande Moravia con quella lasciata, insieme col trofeo glorioso delle loro reliquie, dai santi apostoli Pietro e Paolo alla prima Cattedra episcopale della Chiesa.
In precedenza, Costantino ed i suoi collaboratori si erano preoccupati di creare un nuovo alfabeto, perché le verità da annunciare e da spiegare potessero essere scritte nella lingua slava e risultassero in tal modo pienamente comprensibili ed assimilabili dai loro destinatari. Fu uno sforzo veramente degno dello spirito missionario quello di apprendere la lingua e la mentalità dei popoli nuovi, ai quali portare la fede, come fu esemplare la determinazione nell'assimilarle e nell'assumere in proprio tutte le esigenze ed attese dei popoli slavi. La scelta generosa di identificarsi con la stessa loro vita e tradizione, dopo averle purificate ed illuminate con la rivelazione, rende Cirillo e Metodio veri modelli per tutti i missionari, che nelle varie epoche hanno accolto l'invito di san Paolo di farsi tutto a tutti per riscattare tutti e, in particolare, per i missionari che, dall'antichità ai tempi moderni - dall'Europa all'Asia ed oggi in tutti i continenti - hanno lavorato per tradurre nelle lingue vive dei vari popoli la Bibbia ed i testi liturgici, al fine di fare in esse risonare l'unica Parola di Dio, resa così accessibile secondo le forme espressive, proprie di ciascuna civiltà.
La perfetta comunione nell'amore preserva la Chiesa da qualsiasi forma di particolarismo o di esclusivismo etnico o di pregiudizio razziale, come da ogni alterigia nazionalistica. Tale comunione deve elevare e sublimare ogni legittimo sentimento puramente naturale del cuore umano.
IV
IMPIANTARONO LA CHIESA Dl DIO
12. Ma la caratteristica, che desidero in maniera speciale sottolineare nella condotta tenuta dagli apostoli degli Slavi, Cirillo e Metodio, è il loro modo pacifico di edificare la Chiesa, guidati dalla loro visione della Chiesa una, santa ed universale.
Anche se i cristiani slavi, più degli altri, sentono volentieri i santi Fratelli come «Slavi di cuore», questi tuttavia restano uomini di cultura ellenica e di formazione bizantina, uomini cioè in tutto appartenenti alla tradizione dell'Oriente cristiano, sia civile che ecclesiastico.
Già ai loro tempi le differenze tra Costantinopoli e Roma avevano cominciato a profilarsi come pretesti di disunione, anche se la deplorevole scissione tra le due parti della stessa cristianità era ancora lontana. Gli evangelizzatori e maestri degli Slavi si avviarono alla volta della Grande Moravia, compresi di tutta la ricchezza della tradizione e dell'esperienza religiosa che caratterizzava il cristianesimo orientale e che trovava un peculiare riflesso nell'insegnamento teologico e nella celebrazione della sacra liturgia.
Per quanto ormai da tempo tutti gli uffici sacri si celebrassero in greco in tutte le Chiese comprese nei confini dell'impero bizantino, le tradizioni proprie di molte Chiese nazionali d'Oriente - quali la Georgiana e la Siriaca -, che nel servizio divino usavano la lingua del loro popolo, erano ben note alla cultura superiore di Costantinopoli e, specialmente, a Costantino Filosofo grazie agli studi e ai ripetuti contatti che aveva avuto con cristiani di quelle Chiese sia nella capitale che nel corso dei suoi viaggi.
Entrambi i Fratelli, consapevoli dell'antichità e della legittimità di queste sacre tradizioni, non ebbero dunque timore di usare la lingua slava per la liturgia, facendone uno strumento efficace per avvicinare le verità divine a quanti parlavano in tale lingua. Ciò fecero con coscienza aliena da ogni spirito di superiorità o di dominio, per amore di giustizia e con evidente zelo apostolico verso popoli che si stavano sviluppando.
Il cristianesimo occidentale, dopo le migrazioni dei popoli nuovi, aveva amalgamato i gruppi etnici sopraggiunti con le popolazioni latine residenti, estendendo a tutti, nell'intento di unirli, la lingua, la liturgia e la cultura latina, trasmesse dalla Chiesa di Roma. Dall'uniformità così raggiunta derivava a società relativamente giovani ed in piena espansione un sentimento di forza e di compattezza, che contribuiva sia ad una loro più stretta unione, sia ad una loro più energica affermazione in Europa. Si può capire come in tale situazione ogni diversità venisse talvolta intesa come minaccia ad un'unità ancora in fieri, e come potesse diventare grande la tentazione di eliminarla, ricorrendo anche a forme di coercizione.
13. Appare a questo punto singolare ed ammirevole come i santi Fratelli, operando in situazioni tanto complesse e precarie, non tendessero ad imporre ai popoli assegnati alla loro predicazione neppure l'indiscutibile superiorità della lingua greca e della cultura bizantina, o gli usi e i comportamenti della società più progredita, in cui essi erano cresciuti e che necessariamente restavano per loro familiari e cari. Mossi dall'ideale di unire in Cristo i nuovi credenti, essi adattarono alla lingua slava i testi ricchi e raffinati della liturgia bizantina, ed adeguarono alla mentalità ed alle consuetudini dei nuovi popoli le elaborazioni sottili e complesse del diritto greco-romano. Seguendo il medesimo programma di concordia e di pace, rispettarono in ogni momento gli obblighi della loro missione, tenendo conto delle tradizionali prerogative e dei diritti ecclesiastici fissati dai canoni conciliari, cosicché credettero loro dovere - essi sudditi dell'impero d'Oriente e fedeli soggetti al Patriarcato di Costantinopoli - di rendere conto al Romano Pontefice del loro operato missionario e di sottoporre al suo giudizio, per ottenerne l'approvazione, la dottrina che professavano ed insegnavano, i libri liturgici composti in lingua slava e i metodi adottati nell'evangelizzazione di quei popoli.
Avendo intrapreso la loro missione per mandato di Costantinopoli, essi cercarono poi, in un certo senso, che fosse confermata volgendosi alla Sede Apostolica di Roma, centro visibile dell'unità della Chiesa [21]. Essi così edificarono la Chiesa mossi dal senso della sua universalità come Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica. Questo risulta nella forma più trasparente ed esplicita da tutto il loro comportamento. Si può dire che l'invocazione di Gesù nella preghiera sacerdotale - ut unum sint[22]- rappresenti la loro divisa missionaria secondo le parole del Salmista: «Lodate il Signore, tutte le genti, e lodatelo, popoli tutti» [23]. Per noi uomini di oggi il loro apostolato possiede anche l'eloquenza di un appello ecumenico: è un invito a riedificare, nella pace della riconciliazione, l'unità che è stata gravemente incrinata dopo i tempi dei santi Cirillo e Metodio e, in primissimo luogo, l'unità tra Oriente ed Occidente.
La convinzione dei santi Fratelli di Salonicco, secondo cui ogni Chiesa locale è chiamata ad arricchire con i propri doni il «pleroma» cattolico, era in perfetta armonia con la loro intuizione evangelica che le diverse condizioni di vita delle singole Chiese cristiane non possono mai giustificare dissonanze, discordie, lacerazioni nella professione dell'unica fede e nella pratica della carità.
14. Si sa che, secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II, «per movimento ecumenico" si intendono le attività e le iniziative che. a seconda delle varie necessità della Chiesa e l'opportunità dei tempi, sono suscitate e ordinate a promuovere l'unità dei cristiani» [24]. Pertanto, non sembra per nulla anacronistico vedere nei santi Cirillo e Metodio gli autentici precursori dell'ecumenismo, per aver voluto efficacemente eliminare o diminuire ogni divisione vera o anche solo apparente tra le singole Comunità, appartenenti alla stessa Chiesa. Infatti, la divisione, che purtroppo avvenne nella storia della Chiesa e sfortunatamente ancora perdura, «non solo contraddice apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione del Vangelo ad ogni creatura» [25].
La fervente sollecitudine dimostrata da entrambi i Fratelli e, specialmente, da Metodio, in ragione della sua responsabilità episcopale, nel conservare l'unità della fede e dell'amore tra le Chiese, delle quali erano membri, e cioè la Chiesa di Costantinopoli e la Chiesa Romana, da una parte, e le Chiese nascenti nelle terre slave, dall'altra, fu e resterà sempre il loro grande merito. Questo è tanto maggiore, se si tiene presente che la loro missione si svolge negli anni 863-885, dunque negli anni critici, in cui emersero e cominciarono ad approfondirsi il fatale dissidio e l'aspra controversia tra le Chiese dell'Oriente e dell'Occidente. La divisione si accentuò per la questione dell'appartenenza canonica della Bulgaria, che proprio allora aveva accettato ufficialmente il cristianesimo.
In questo periodo burrascoso, segnato anche da conflitti armati tra popoli cristiani confinanti, i santi Fratelli di Salonicco conservarono una fedeltà ferma e piena di vigilanza alla retta dottrina e alla tradizione della Chiesa perfettamente unita e, in particolare, alle «istituzioni divine» e alle «istituzioni ecclesiastiche» [26], sulle quali. secondo i canoni degli antichi Concili, poggiavano la sua struttura e la sua organizzazione. Questa fedeltà permise loro di portare a termine i grandi compiti missionari e di rimanere in piena unità spirituale e canonica con la Chiesa Romana, con la Chiesa di Costantinopoli e con le nuove Chiese, da essi fondate fra i popoli slavi.
15. Metodio specialmente non esitava a far fronte alle incomprensioni, ai contrasti e, persino, alle diffamazioni e persecuzioni fisiche, pur di non mancare alla sua esemplare fedeltà ecclesiale, pur di tener fede ai propri doveri di cristiano e di vescovo e di agli impegni assunti nei riguardi della Chiesa di Bisanzio, che l'aveva generato ed inviato come missionario insieme a Cirillo; nei riguardi della Chiesa di Roma, grazie alla quale adempiva il suo incarico di arcivescovo pro fide nel «territorio di san Pietro» [27]; come pure nei riguardi di quella Chiesa nascente nelle terre slave, che egli accettò come propria e che seppe difendere - convinto del giusto diritto - davanti alle autorità ecclesiastiche e civili, tutelando particolarmente la liturgia in lingua paleoslava e i fondamentali diritti propri delle Chiese nelle diverse Nazioni.
Facendo così, egli ricorreva sempre, come Costantino Filosofo, al dialogo con coloro che erano contrari alle sue idee o alle sue iniziative pastorali e mettevano in dubbio la loro legittimità. In questo modo rimarrà per sempre maestro per tutti coloro che, in qualsiasi tempo, cercano di attenuare i dissidi rispettando la pienezza multiforme della Chiesa, la quale, conformemente alla volontà del suo fondatore Gesù Cristo, deve essere sempre una, santa, cattolica ed apostolica: tale consegna trovò piena risonanza nel Simbolo dei 150 padri del II Concilio ecumenico di Costantinopoli, che costituisce l'intangibile professione di fede di tutti i cristiani.
V
SENSO CATTOLICO DELLA CHIESA
16. Non è soltanto il contenuto evangelico della dottrina annunciata dai santi Cirillo e Metodio, che merita una particolare accentuazione. Molto espressivo ed istruttivo per la Chiesa d'oggi e anche il metodo catechetico e pastorale, che essi applicarono nella loro attività apostolica tra popoli che non avevano ancora sentito celebrare i divini Misteri nella loro lingua natìa, né avevano ancora udito annunciare la parola di Dio in modo pienamente conforme alla propria mentalità e nel rispetto delle concrete condizioni di vita, loro proprie.
Sappiamo che il Concilio Vaticano II, vent'anni fa, ebbe come compitò precipuo quello di risvegliare l'autocoscienza della Chiesa e, mediante il suo rinnovamento interiore, di imprimerle un nuovo impulso missionario in ordine all'annuncio dell'eterno messaggio di salvezza, di pace e di reciproca concordia tra i popoli e le Nazioni, al di là di tutte le frontiere che ancora dividono il nostro pianeta, destinato, per volontà di Dio creatore e redentore, ad essere dimora comune per l'intera umanità. Le minacce, che ai nostri tempi si accumulano sopra di esso, non possono far dimenticare la profetica intuizione di papa Giovanni XXIII, che convocò il Concilio nell'intento e nella convinzione che esso sarebbe stato in grado di preparare e di avviare un periodo di primavera e di rinascita nella vita della Chiesa.
E, in tema di universalità, lo stesso Concilio, tra l'altro, così si è espresso:
«A formare il nuovo Popolo di Dio sono chiamati tutti gli uomini. Perciò, questo Popolo, pur restando uno e unico, si deve estendere a tutto il mondo ed a tutti i secoli, affinché si adempia il proposito della volontà di Dio, il quale in principio creò la natura umana una, e volle alla fine radunare insieme i suoi figli che erano dispersi (cfr. Gv 11, 52)... La Chiesa, cioè il Popolo di Dio, inaugurando questo Regno, nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario favorisce e accoglie le capacità e le risorse e le consuetudini dei popoli, in quanto sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida e le eleva... Questo carattere di universalità, che adorna e distingue il Popolo di Dio, è un dono dello stesso Signore... In virtù di questa cattolicità, le singole parti portano i propri doni alle altre parti ed a tutta la Chiesa, e così il tutto e le singole parti s'accrescono comunicando ognuna con le altre e concordemente operando per la pienezza nell'unità» [28].
17. Possiamo tranquillamente affermare che una tale visione, tradizionale ed insieme estremamente attuale, della cattolicità della Chiesa - sentita come una sinfonia delle varie liturgie in tutte le lingue del mondo, unite in un'unica liturgia, o come un coro armonioso che, sostenuto dalle voci di sterminate moltitudini di uomini, si leva secondo innumerevoli modulazioni, timbri ed intrecci per la lode di Dio da ogni punto del nostro globo, in ogni momento della storia -, corrisponde in modo particolare alla visione teologica e pastorale, che ispirò l'opera apostolica e missionaria di Costantino Filosofo e di Metodio e ne sostenne la missione tra le Nazioni slave.
A Venezia, davanti ai rappresentanti della cultura ecclesiastica, che essendo attaccati ad un concetto piuttosto angusto della realtà ecclesiale, erano contrari a questa visione, san Cirillo la difese con coraggio, indicando il fatto che molti popoli avevano già introdotto in passato e possedevano una liturgia scritta e celebrata nella propria lingua, come «gli Armeni, i Persiani, gli Abasgi, i Georgiani, i Sugdi, i Goti, gli Avari, i Tirsi, i Khazari, gli Arabi, i Copti, i Siriani e molti altri» [29].
Ricordando che Dio fa sorgere il suo sole e fa cadere la pioggia su tutti gli uomini senza eccezione[30], egli diceva: «Non respiriamo forse tutti l'aria nel medesimo modo? E voi non vi vergognate di stabilire tre sole lingue (l'ebraico, il greco e il latino) decidendo che tutti gli altri popoli e stirpi restino ciechi e sordi! Ditemi: sostenete questo, perché considerate Dio tanto debole da non essere in grado di concederlo, oppure tanto invidioso da non volerlo?» [31]. Alle argomentazioni storiche e dialettiche, che gli venivano opposte, il Santo rispondeva facendo ricorso al fondamento ispirato della Sacra Scrittura: «Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore per la gloria di Dio Padre» [32]; «ogni terra ti adori, levi a te canti; inneggi, Altissimo, al tuo nome» [33]; «lodate il Signore, tutte le genti, e lodatelo, popoli tutti» [34].
18. La Chiesa è cattolica anche perché sa presentare in ogni contesto umano la verità rivelata, da essa custodita intatta nel suo contenuto divino, in modo tale da farla incontrare con i pensieri elevati e le giuste attese di ogni uomo e di ogni popolo. Del resto, l'intero patrimonio di bene, che ogni generazione trasmette ai posteri insieme con l'inestimabile dono della vita, costituisce come una variopinta ed immensa quantità di tessere che compongono il vivo mosaico del Pantocrátor, il quale si manifesterà nel suo totale splendore solo al momento della parusia.
Il Vangelo non porta all'impoverimento o allo spegnimento di ciò che ogni uomo, popolo e Nazione, ogni cultura durante la storia riconoscono ed attuano come bene, verità e bellezza. Piuttosto, esso spinge ad assimilare e a sviluppare tutti questi valori: a viverli con magnanimità e gioia ed a completarli con la misteriosa ed esaltante luce della Rivelazione.
La dimensione concreta della cattolicità, inscritta da Cristo Signore nella costituzione stessa della Chiesa, non è qualcosa di statico, astorico e piattamente uniforme, ma sorge e si sviluppa, in un certo senso, quotidianamente come una novità dall'unanime fede di tutti coloro che credono nel Dio uno e trino, rivelato da Gesù Cristo e predicato dalla Chiesa con la forza dello Spirito Santo. Questa dimensione scaturisce del tutto spontaneamente dal reciproco rispetto - proprio della carità fraterna per ogni uomo e ogni Nazione, grande o piccola, e dal riconoscimento leale degli attributi e dei diritti dei fratelli nella fede.
19. La cattolicità della Chiesa si manifesta, altresì, nell'attiva corresponsabilità e nella generosa collaborazione di tutti in favore del bene comune. La Chiesa attua dappertutto la propria universalità accogliendo, unendo ed esaltando nel modo che le è proprio, con premura materna, ogni autentico valore umano. Al tempo stesso, essa si adopera in ogni latitudine e longitudine geografica ed in ogni situazione storica per guadagnare a Dio ciascun uomo e tutti gli uomini, per unirli tra loro e con lui nella sua verità e nel suo amore.
Ogni uomo, ogni Nazione, ogni cultura e civiltà hanno un proprio ruolo da svolgere e un proprio posto nel misterioso piano di Dio e nell' universale storia della salvezza. Era questo il pensiero dei due santi Fratelli: il Dio «misericordioso e benevolo [35], attendendo che tutti gli uomini si pentano, perché tutti si salvino e giungano alla conoscenza della verità [36], non tollera che il genere umano soccomba alla debolezza e perisca cadendo nella tentazione del Nemico, ma in tutti gli anni e tempi non cessa di elargirci una grazia molteplice, dall'origine fino ad oggi allo stesso modo: prima, per il tramite dei patriarchi e dei padri e, dopo di loro, per il tramite dei profeti; ed ancora per il tramite degli apostoli e dei martiri, degli uomini giusti e dei dottori, che egli sceglie in mezzo a questa vita tempestosa» [37].
20. Il messaggio evangelico, che i santi Cirillo e Metodio hanno tradotto per i popoli slavi, attingendo sapientemente dal tesoro della Chiesa «cose antiche e nuove» [38], è stato trasmesso mediante l'annuncio e la catechesi in conformità alle verità eterne e adattandolo, nello stesso tempo, alla concreta situazione storica. Grazie agli sforzi missionari di entrambi i Santi, i popoli slavi poterono per la prima volta prender coscienza della propria vocazione a partecipare all'eterno disegno della Santissima Trinità, nell'universale piano di salvezza del mondo. Con ciò riconoscevano pure il proprio ruolo a vantaggio dell'intera storia dell'umanità creata da Dio Padre, redenta dal Figlio Salvatore e illuminata dallo Spirito Santo. Grazie a questo annuncio, approvato a suo tempo dalle autorità della Chiesa, i Vescovi di Roma e i Patriarchi di Costantinopoli, gli Slavi poterono sentirsi, insieme con le altre Nazioni della terra, discendenti ed eredi della promessa, fatta da Dio ad Abramo [39]. In questo modo, grazie all'organizzazione ecclesiastica creata da san Metodio ed alla consapevolezza della propria identità cristiana, essi presero il posto a loro destinato nella Chiesa, ormai sorta anche in quella parte d'Europa. Per questo, i loro odierni discendenti conservano un grato ed imperituro ricordo di colui che è diventato l'anello che li unisce alla catena dei grandi araldi della divina Rivelazione dell'Antico e del Nuovo Testamento: «Dopo tutti costoro Dio misericordioso, al nostro tempo, suscitò in favore del nostro popolo - di cui nessuno si era mai preoccupato - per la buona impresa il nostro maestro, il beato Metodio, le cui virtù e lotte noi paragoniamo senza arrossire, ad una ad una, a quelle di tali uomini graditi a Dio» [40].
VI
IL VANGELO E LA CULTURA
21. I Fratelli di Salonicco erano eredi non solo della fede, ma anche della cultura della Grecia antica, continuata da Bisanzio. E si sa quale importanza questa eredità abbia per l'intera cultura europea e, direttamente o indirettamente, per quella universale. Nell'opera di evangelizzazione, che essi compirono - come pionieri in territorio abitato da popoli slavi -, è contenuto al tempo stesso un modello di ciò che oggi porta il nome di «inculturazione» - l'incarnazione del Vangelo nelle culture autoctone - ed insieme l'introduzione di esse nella vita della Chiesa.
Incarnando il Vangelo nella peculiare cultura dei popoli che evangelizzavano, i santi Cirillo e Metodio ebbero particolari meriti per la formazione e lo sviluppo di quella stessa cultura o, meglio, di molte culture. Infatti, tutte le culture delle Nazioni slave debbono il proprio «inizio» o il proprio sviluppo all'opera dei Fratelli di Salonicco. Questi, infatti, con la creazione, originale e geniale, di un alfabeto per la lingua slava, diedero un contributo fondamentale alla cultura e alla letteratura di tutte le Nazioni slave.
La traduzione poi dei Libri sacri, eseguita da Cirillo e Metodio unitamente ai loro discepoli. conferì capacità e dignità culturale alla lingua liturgica paleoslava, che divenne per lunghi secoli non solo la lingua ecclesiastica, ma anche quella ufficiale e letteraria, e persino la lingua comune delle classi più colte della maggior parte delle Nazioni slave e, in particolare, di tutti gli Slavi di rito orientale. Essa veniva usata anche nella Chiesa di Santa Croce in Cracovia, presso la quale si erano stabiliti i Benedettini slavi. Qui furono pubblicati i primi libri liturgici, stampati in questa lingua. Fino ad oggi è questa la lingua usata nella liturgia bizantina delle Chiese Orientali slave di rito costantinopolitano sia cattoliche che ortodosse nell'Europa Orientale e Sud-Orientale, nonché in diversi Paesi dell'Europa Occidentale, ed è anche usata nella liturgia romana dei cattolici di Croazia.
22. Nello sviluppo storico degli Slavi di rito orientale tale lingua ebbe un ruolo pari a quello della lingua latina in Occidente. Essa, inoltre, si è conservata più a lungo in parte fino al secolo XIX - ed ha esercitato un influsso molto più diretto sulla formazione delle lingue native letterarie, grazie agli stretti rapporti di parentela con esse.
Questi meriti per la cultura di tutti i popoli e di tutte le Nazioni slave rendono l'opera di evangelizzazione svolta dai santi Cirillo e Metodio, in un certo senso, costantemente presente nella storia e nella vita di questi popoli e di queste Nazioni.
VII
SIGNIFICATO E IRRADIAZIONE
DEL MILLENNIO CRISTIANO
NEL MONDO SLAVO
23. L'attività apostolico-missionaria dei santi Cirillo e Metodio, che cade nella seconda metà del IX secolo, può considerarsi la prima efficace evengelizzazione degli Slavi .
Essa interessò in diverso grado i singoli territori, concentrandosi principalmente su quelli dello stato della Grande Moravia di allora. Prima di tutto, abbracciò le regioni della metropolia, il cui pastore era Metodio, cioè la Moravia, la Slovacchia e la Pannonia, cioè una parte dell'odierna Ungheria. Nell'ambito del più vasto influsso esercitato da questa attività apostolica, specialmente da parte dei missionari preparati da Metodio, si trovarono gli altri gruppi di Slavi occidentali, anzitutto quelli di Boemia. Il primo principe storico della Boemia della dinastia dei Premyslidi, Bozyvoj (Borivoi), fu battezzato probabilmente secondo il rito slavo. Più tardi questo influsso raggiunse le tribù serbolusaziane, nonché i territori della Polonia meridionale. Tuttavia, dal momento della caduta della Grande Moravia (circa 905-906), a questo rito subentrò il rito latino, e la Boemia fu attribuita ecclesiasticamente al Vescovo di Ratisbona ed alla metropolia di Salisburgo. Merita, però, attenzione il fatto che ancora verso la metà del X secolo, ai tempi di san Venceslao, esisteva una forte compenetrazione degli elementi di entrambi i riti con un'avanzata simbiosi di tutte e due le lingue usate nella liturgia: la lingua slava e la lingua latina. Del resto, non era possibile la cristianizzazione del popolo senza servirsi della lingua natìa. E solamente su una tale base potè svilupparsi la terminologia cristiana nella Boemia, e da qui, successivamente, svilupparsi e consolidarsi la terminologia ecclesiastica in Polonia. La notizia sul principe dei Vislani nella Vita di Metodio è il più antico cenno storico riguardante una delle tribù polacche [41]. Mancano i dati sufficienti per poter collegare con questa notizia l'istituzione nelle terre polacche di un'organizzazione ecclesiastica in rito slavo.
24. Il battesimo della Polonia nel 966, nella persona del primo sovrano storico Mieszko, che sposò la principessa boema Dubravka, avvenne principalmente per mezzo della Chiesa boema, e per questa via il cristianesimo giunse in Polonia da Roma nella forma latina. Resta, comunque, il fatto che i primordi del cristianesimo in Polonia si collegano in qualche modo con l'opera dei Fratelli partiti dalla lontana Salonicco.
Tra gli Slavi della penisola Balcanica le sollecitudini dei santi Fratelli fruttificarono in modo ancor più visibile. Grazie al loro apostolato si consolidò il cristianesimo già da tempo radicato in Croazia.
Principalmente per il tramite dei discepoli, espulsi dall'originario terreno di azione, la missione cirillo-metodiana si affermò e sviluppò meravigliosamente in Bulgaria. Qui, grazie a san Clemente da Ocrida, sorsero dinamici centri di vita monastica, e qui trovò sviluppo particolare l'alfabeto cirillico. Da qui pure il cristianesimo passò in altri territori, fino a raggiungere, attraverso la vicina Romania, l'antica Rus' di Kiev ed estendersi quindi da Mosca verso Oriente. Tra alcuni anni, precisamente nell'anno 1988, ricorrerà il millenario del battesimo di san Vladimiro il Grande, principe di Kiev.
25. Giustamente, dunque, i santi Cirillo e Metodio furono presto riconosciuti dalla famiglia dei popoli Slavi come padri tanto del loro cristianesimo, quanto della loro cultura. In molti dei territori già nominati, benché ci fossero stati diversi missionari, la maggioranza della popolazione slava conservava, ancora nel secolo IX, consuetudini e credenze pagane. Solamente sul terreno coltivato dai nostri Santi, o almeno da loro preparato per la coltivazione, il cristianesimo entrò in modo definitivo nella storia degli Slavi durante il secolo successivo.
La loro opera costituisce un contributo eminente per il formarsi delle comuni radici cristiane dell'Europa, quelle radici che per la loro solidità e vitalità configurano uno dei più solidi punti di riferimento, da cui non può prescindere ogni serio tentativo di ricomporre in modo nuovo ed attuale l'unità del continente.
Dopo undici secoli di cristianesimo tra gli Slavi, vediamo chiaro che il retaggio dei Fratelli di Salonicco è e resta per loro più profondo e più forte di qualunque divisione. Entrambe le tradizioni cristiane- l'orientale che deriva da Costantinopoli e l'occidentale che deriva da Roma - sono sorte nel seno dell'unica Chiesa, anche se sulla trama di diverse culture e di un diverso approccio verso gli stessi problemi. Una tale diversità, quando ne sia ben compresa l'origine e siano ben considerati il suo valore e il suo significato, può soltanto arricchire sia la cultura dell'Europa, sia la sua tradizione religiosa, e diventare, altresì, una base adeguata per il suo auspicato rinnovamento spirituale.
26. Fin dal IX secolo, quando nell'Europa cristiana si stava delineando un nuovo assetto, i santi Cirillo e Metodio ci propongono un messaggio che si rivela attualissimo per la nostra epoca, la quale, proprio in ragione dei tanti e complessi problemi di ordine religioso e culturale, civile e internazionale, cerca una vitale unità nella reale comunione di varie componenti. Dei due evangelizzatori si può dire che caratteristico fu il loro amore alla comunione della Chiesa universale sia in Oriente che in Occidente e, in essa, alla Chiesa particolare che stava nascendo nelle nazioni slave. Da essi anche per i cristiani e gli uomini del nostro tempo deriva l'invito a costruire insieme la comunione.
Ma è sul terreno specifico dell'attività missionaria che vale ancor più l'esempio di Cirillo e Metodio. Tale attività, infatti, è compito essenziale della Chiesa, ed è oggi urgente nella forma già accennata dell'«inculturazione». I due Fratelli non solo svolsero la loro missione nel pieno rispetto della cultura già esistente presso i popoli slavi. ma insieme con la religione eminentemente e incessantemente la promossero ed accrebbero. Analogamente, oggi le Chiese di antica data possono e debbono aiutare le Chiese ed i popoli giovani a maturare nella propria identità ed a progredire in essa [42].
27. Cirillo e Metodio sono come gli anelli di congiunzione, o come un ponte spirituale tra la tradizione orientale e la tradizione occidentale, che confluiscono entrambe nell'unica grande Tradizione della Chiesa universale. Essi sono per noi i campioni ed insieme i patroni nello sforzo ecumenico delle Chiese sorelle d'Oriente e d'Occidente, per ritrovare mediante il dialogo e la preghiera l'unità visibile nella comunione perfetta e totale, «l'unità che - come dissi in occasione della mia visita a Bari non è assorbimento e neppure fusione» [43]. L'unità è l'incontro nella verità e nell'amore, che ci sono donati dallo Spirito. Cirillo e Metodio, nella loro personalità e nella loro opera, sono figure che risvegliano in tutti i cristiani una grande «nostalgia per l'unione» e per l'unità tra le due Chiese sorelle dell'Oriente e dell'Occidente [44]. Per la piena cattolicità, ogni Nazione, ogni cultura ha un proprio ruolo da svolgere nell'universale piano di salvezza. Ogni tradizione particolare, ogni Chiesa locale deve rimanere aperta ed attenta alle altre Chiese e tradizioni e, nel contempo, alla comunione universale e cattolica; se rimanesse chiusa in sé, correrebbe il pericolo di impoverirsi anch'essa.
Attuando il proprio carisma, Cirillo e Metodio recarono un contributo decisivo alla costruzione dell'Europa non solo nella comunione religiosa cristiana, ma anche ai fini della sua unione civile e culturale. Nemmeno oggi esiste un'altra via per superare le tensioni e riparare le rotture e gli antagonismi sia nell'Europa che nel mondo, i quali minacciano di provocare una spaventosa distruzione di vite e di valori. Essere cristiani nel nostro tempo significa essere artefici di comunione nella Chiesa e nella società. A questo fine valgono l'animo aperto ai fratelli, la mutua comprensione, la prontezza nella cooperazione mediante lo scambio generoso dei beni culturali e spirituali.
In effetti, una delle aspirazioni fondamentali dell'umanità di oggi è quella di ritrovare l'unità e la comunione per una vita veramente degna dell'uomo a livello planetario. La Chiesa, consapevole di essere segno e sacramento universale di salvezza e di unità del genere umano, si dichiara pronta ad assolvere questo suo dovere «che le condizioni del tempo rendono più urgente, affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti da vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano conseguire anche la piena unità in Cristo» [45].
VIII
CONCLUSIONE
28. Conviene, pertanto, che tutta la Chiesa celebri con solennità e con gioia gli undici secoli trascorsi dalla conclusione dell'opera apostolica del primo arcivescovo ordinato a Roma per i popoli slavi, Metodio, e di suo fratello Cirillo, ricordando l'ingresso di questi popoli sulla scena della storia della salvezza e nel novero delle Nazioni europee che, già durante i secoli precedenti, avevano accolto il messaggio evangelico. Tutti possono comprendere con quale profonda esultanza intende partecipare a questa celebrazione il primo figlio della stirpe slava chiamato, dopo quasi due millenni, ad occupare la sede episcopale che fu di San. Pietro in questa città di Roma.
29. «Nelle tue mani consegno il mio spirito»: noi salutiamo l'XI centenario della morte di san Metodio con le stesse parole, che furono da lui pronunciate - secondo quanto riferisce la sua Vita in lingua paleoslava [6] - prima di morire, mentre stava per riunirsi ai suoi padri nella fede, nella speranza e nella carità: ai patriarchi, ai profeti, agli apostoli, ai dottori, ai martiri. Con la testimonianza della parola e della vita, sostenute dal carisma, dello Spirito, egli dette l'esempio di una vocazione feconda sia per il secolo in cui visse, sia per i secoli successivi e, in modo particolare, per i nostri tempi.
Il suo beato «transito» nella primavera dell'anno 885 dall'incarnazione di Cristo (e secondo il computo bizantino del tempo, nell'anno 6393 dalla creazione del mondo) avvenne in un periodo in cui inquietanti nubi si addensavano sopra Costantinopoli e ostili tensioni minacciavano sempre di più la quiete e la vita delle Nazioni, e persino i sacri vincoli della fratellanza cristiana e della comunione tra le Chiese dell'Oriente e dell'Occidente.
Nella sua Cattedrale, colma di fedeli di stirpi diverse, i discepoli di san Metodio resero solenne omaggio al defunto pastore per il messaggio di salvezza, di pace e di riconciliazione che aveva portato ed al quale aveva dedicato la sua vita: «Celebrarono un ufficio sacro in latino greco e slavo» [47], adorando Dio e venerando il primo arcivescovo della Chiesa, da lui fondata tra gli Slavi, ai quali aveva annunciato il Vangelo insieme al fratello nella loro propria lingua. Questa Chiesa si rafforzò ancora di più, quando per esplicito consenso del Papa ricevette una gerarchia autoctona. radicata nella successione apostolica e collegata in unità di fede e di amore sia con la Chiesa di Roma, sia con quella di Costantinopoli, dalla quale la missione slava aveva preso inizio.
Mentre si compiono undici secoli dalla sua morte, desidero ritrovarmi almeno spiritualmente aVelehrad, dove - come sembra - la Provvidenza permise a Metodio di concludere la sua vita apostolica:
- desidero anche fermarmi nella Basilica di San Clemente a Roma, nel luogo ove fu sepolto san Cirillo;
- e presso le Tombe di entrambi questi Fratelli, apostoli degli Slavi, desidero raccomandare alla Santissima Trinità la loro eredità spirituale con una speciale preghiera .
30. «Nelle tue mani consegno...».
O Dio grande, uno nella Trinità, io ti affido il retaggio della fede delle Nazioni slave: conserva e benedici questa tua opera!
Ricorda, o Padre onnipotente, il momento nel quale, secondo la tua volontà, giunse per questi popoli e per queste Nazioni la «pienezza dei tempi» e i santi missionari di Salonicco adempirono fedelmente il comando che il tuo Figlio Gesù Cristo aveva rivolto ai suoi apostoli; seguendo le loro orme e quelle dei loro successori, essi recarono nelle terre abitate dagli Slavi la luce del Vangelo, la Buona Novella della salvezza, e davanti a loro, testimoniarono:
- che tu sei Creatore dell'uomo, che ci sei Padre ed in te noi uomini siamo tutti fratelli;
- che per mezzo del Figlio, tua Parola eterna, hai donato l'esistenza a tutte le cose ed hai chiamato gli uomini a partecipare alla tua vita senza fine;
- che hai tanto amato il mondo da fargli dono del tuo Figlio unigenito, il quale, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo;
- che, infine, hai inviato lo Spirito della potenza e della consolazione, perché ogni uomo, redento da Cristo, potesse in lui ricevere la dignità di figlio e diventare coerede delle indefettibili promesse, da te fatte all'umanità!
Il tuo piano creatore, o Padre, culminato nella Redenzione, tocca l'uomo vivente e abbraccia l'intera sua vita e la storia di tutti i popoli.
Esaudisci, o Padre, ciò che da te implora oggi tutta la Chiesa e fa' che gli uomini e le Nazioni, che, grazie alla missione apostolica dei santi Fratelli di Salonicco, conobbero ed accolsero te, Dio vero, e mediante il Battesimo entrarono nella santa comunità dei tuoi figli, possano continuare ancora, senza ostacoli, ad accogliere con entusiasmo e fiducia questo programma evangelico ed a realizzare tutte le proprie possibilità umane sul fondamento dei loro insegnamenti!
- Possano essi seguire, in conformità alla propria coscienza, la voce della tua chiamata lungo le vie loro indicate per la prima volta undici secoli or sono!
- La loro appartenenza al Regno del tuo Figlio non possa esser considerata da nessuno in contrasto col bene della patria terrena!
- Possano rendere a te la lode dovuta nella vita privata e in quella pubblica!
- Possano vivere nella verità, nella carità, nella giustizia e nel godimento della pace messianica, che abbraccia i cuori umani, le comunità, la terra e l'intero cosmo!
- Consci della loro dignità di uomini e di figli di Dio, possano avere la forza di superare ogni odio e di vincere il male col bene!
Ma anche a tutta l'Europa, o Trinità Santissima, concedi che per intercessione dei due santi Fratelli senta sempre maggiormente l'esigenza dell'unità religioso-cristiana e della fraterna comunione di tutti i suoi popoli, così che, superata l'incomprensione e la sfiducia reciproca e vinti i conflitti ideologici nella comune coscienza della verità, possa essere per il mondo intero un esempio di giusta e pacifica convivenza, nel mutuo rispetto e nell'inviolata libertà.
31. A te, dunque, Dio Padre onnipotente, Dio Figlio che hai redento il mondo, Dio Spirito che sei sostegno e maestro di ogni santità, desidero affidare l'intera Chiesa di ieri, di oggi e di domani, la Chiesa che è in Europa e che è diffusa su tutta la terra. Nelle tue mani io consegno questa singolare ricchezza, composta da tanti diversi doni, antichi e nuovi, immessi nel tesoro comune da tanti figli diversi.
Tutta la Chiesa ringrazia te, che chiamasti le Nazioni slave alla comunione della fede, per il retaggio e il contributo da esse apportato al patrimonio universale. Ti ringrazia per questo, in modo particolare, il papa di origine slava. Tale contributo non cessi mai di arricchire la Chiesa, il continente europeo e il mondo intero! Non venga meno nell'Europa e nel mondo d'oggi! Non manchi nella coscienza dei nostri contemporanei! Noi desideriamo accogliere integralmente tutto ciò che di originale e di valido le Nazioni slave hanno recato e recano al patrimonio spirituale della Chiesa e dell'umanità. La Chiesa tutta consapevole della comune ricchezza, professa la sua solidarietà spirituale con loro e ribadisce la propria responsabilità verso il Vangelo, per l'opera di salvezza che è chiamata ad attuare anche oggi in tutto il mondo, fino ai confini della terra. È indispensabile risalire al passato per comprendere, alla sua luce, la realtà attuale e presagire il domani. La missione della Chiesa è, infatti, sempre orientata e protesa con indefettibile speranza verso il futuro.
32. Il Futuro! Per quanto possa umanamente apparire gravido di minacce e di incertezze, lo deponiamo con fiducia nelle tue mani, Padre celeste, invocando l'intercessione della Madre del tuo Figlio e Madre della Chiesa, quella dei tuoi apostoli Pietro e Paolo e dei santi Benedetto, Cirillo e Metodio, di Agostino e Bonifacio e di tutti gli altri evangelizzatori dell'Europa, i quali, forti nella fede, nella speranza e nella carità, annunciarono ai nostri padri la tua salvezza e la tua pace, e con le fatiche della semina spirituale dettero inizio alla costruzione della civiltà dell'amore, al nuovo ordine basato sulla tua santa legge e sull'aiuto della tua grazia, che alla fine dei tempi vivificherà tutto e tutti nella Gerusalemme celeste. Amen .
A voi, Fratelli e Sorelle carissimi, la mia Benedizione Apostolica .
Dato a Roma, presso San Pietro, il 2 giugno, Solennità della Santissima Trinità, dell'anno 1985, settimo del mio Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
PER SCARICARE SUL TUO PC L'EPISTOLA ENCICLICA "SLAVORUM APOSTOLI" SUL TUO PC, CLICCA QUI'

|
DEL SOMMO PONTEFICE GIOVANNI PAOLO II CIRCA LA PERMANENTE VALIDITÀ DEL MANDATO MISSIONARIO
Venerati Fratelli, carissimi Figli e Figlie, INTRODUZIONE 1. La missione di Cristo redentore, affidata alla Chiesa, è ancora ben lontana dal suo compimento. Al termine del secondo millennio dalla sua venuta uno sguardo d'insieme all'umanità dimostra che tale missione è ancora agli inizi e che dobbiamo impegnarci con tutte le forze al suo servizio. È lo Spirito che spinge ad annunziare le grandi opere di Dio: «Non è infatti per me un vanto predicare il Vangelo; è per me un dovere: guai a me se non predicassi il Vangelo!» (1 Cor 9,16). A nome di tutta la Chiesa, sento imperioso il dovere di ripetere questo grido di san Paolo. Già dall'inizio del mio pontificato ho scelto di viaggiare fino agli estremi confini della terra per manifestare la sollecitudine missionaria, e proprio il contatto diretto con i popoli che ignorano Cristo mi ha ancor più convinto dell'urgenza di tale attività, a cui dedico la presente Enciclica. Il Concilio Vaticano II ha inteso rinnovare la vita e l'attività della Chiesa secondo le necessità del mondo contemporaneo: ne ha sottolineato la «missionarietà» fondandola dinamicamente sulla stessa missione trinitaria. L'impulso missionario, quindi, appartiene all'intima natura della vita cristiana e ispira anche l'ecumenismo: «Che tutti siano una cosa sola...., perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). 2. Molti sono già stati i frutti missionari del Concilio: si sono moltiplicate le chiese locali fornite di propri Vescovi, clero e personale apostolico; si verifica un più profondo inserimento delle Comunità cristiane nella vita dei popoli; la comunione fra le Chiese porta a un vivace scambio di beni spirituali e di doni; l'impegno evangelizzatore dei laici sta cambiando la vita ecclesiale; le Chiese particolari si aprono all'incontro, al dialogo e alla collaborazione con i membri di altre chiese cristiane e religioni. Soprattutto si sta affermando una coscienza nuova: cioè che la missione riguarda tutti i cristiani, tutte le diocesi e parrocchie, le istituzioni e associazioni ecclesiali. Tuttavia, in questa «nuova primavera» del cristianesimo non si può nascondere una tendenza negativa, che questo Documento vuol contribuire a superare: la missione specifica ad gentes sembra in fase di rallentamento, non certo in linea con le indicazioni del Concilio e del Magistero successivo. Difficoltà interne ed esterne hanno indebolito lo slancio missionario della chiesa verso i non cristiani, ed è un fatto, questo, che deve preoccupare tutti i credenti in Cristo. Nella storia della Chiesa, infatti, la spinta missionaria è sempre stata segno di vitalità, come la sua diminuzione è segno di una crisi di fede 1. A venticinque anni dalla conclusione del Concilio e dalla pubblicazione del Decreto sull'attività missionaria Ad gentes, a quindici anni dall'Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi del pontefice Paolo VI di v.m., desidero invitare la chiesa a un rinnovato impegno missionario, continuando il Magistero dei miei predecessori a tale riguardo 2. Il presente documento ha una finalità interna: il rinnovamento della fede e della vita cristiana. La missione, infatti, rinnova la chiesa, rinvigorisce la fede e l'identità cristiana, dà nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola!La nuova evangelizzazione dei popoli cristiani troverà ispirazione e sostegno nell'impegno per la missione universale. Ma ciò che ancor più mi spinge a proclamare l'urgenza dell'evangelizzazione missionaria è che essa costituisce il primo servizio che la chiesa può rendere a ciascun uomo e all'intera umanità nel mondo odierno, il quale conosce stupende conquiste, ma sembra avere smarrito il senso delle realtà ultime e della stessa esistenza. «Cristo redentore - ho scritto nella prima Enciclica - rivela pienamente l'uomo a se stesso... L'uomo che vuol comprendere se stesso fino in fondo... deve avvicinarsi a Cristo... La redenzione, avvenuta per mezzo della croce, ha ridato definitivamente all'uomo la dignità e il senso della sua esistenza nel mondo» 3. Né mancano altre motivazioni e finalità: rispondere alle molte richieste per un documento di questo genere dissipare dubbi e ambiguità circa la missione ad gentes, confermando nel loro impegno i benemeriti fratelli e sorelle dediti all'attività missionaria e tutti coloro che li aiutano; promuovere le vocazioni missionarie, incoraggiare i teologi ad approfondire ed esporre sistematicamente i vari aspetti della missione; rilanciare la missione in senso specifico, impegnando le chiese particolari specie quelle giovani, a mandare e ricevere missionari, assicurare i non cristiani e, in particolare, le autorità dei paesi verso cui si rivolge l'attività missionaria, che questa ha un unico fine: servire l'uomo rivelandogli l'amore di Dio, che si è manifestato in Gesù Cristo. 3. Popoli tutti, aprite le porte a Cristo! Il suo Vangelo nulla toglie alla libertà dell'uomo, al dovuto rispetto delle culture, a quanto c'è di buono in ogni religione. Accogliendo Cristo, voi vi aprite alla parola definitiva di Dio, a colui nel quale Dio si è fatto pienamente conoscere e ci ha indicato la via per arrivare a lui. Il numero di coloro che ignorano Cristo e non fanno parte della chiesa è in continuo aumento, anzi dalla fine del Concilio è quasi raddoppiato. Per questa umanità immensa, amata dal Padre che per essa ha inviato il suo Figlio, è evidente l'urgenza della missione. D'altra parte, in questo campo il nostro tempo offre nuove occasioni alla chiesa: il crollo di ideologie e di sistemi politici oppressivi; l'apertura delle frontiere e il formarsi di un mondo più unito grazie all'incremento delle comunicazioni, l'affermassi tra i popoli di quei valori evangelici, che Gesù ha incarnato nella sua vita (pace, giustizia, fraternità, dedizione ai più piccoli); un tipo di sviluppo economico e tecnico senz'anima, che pur sollecita a ricercare la verità su Dio, sull'uomo, sul significato della vita. Dio apre alla chiesa gli orizzonti di un'umanità più preparata alla semina evangelica. Sento venuto il momento di impegnare tutte le forze ecclesiali per la nuova evangelizzazione e per la missione ad gentes. Nessun credente in Cristo, nessuna istituzione della chiesa può sottrarsi a questo dovere supremo: annunziare Cristo a tutti i popoli. |
|
Capitolo I GESÙ CRISTO UNICO SALVATORE 4. «Il compito fondamentale della chiesa di tutte le epoche e, in modo particolare, della nostra - ricordavo nella prima Enciclica programmatica - è di dirigere lo sguardo dell'uomo, di indirizzare la coscienza e l'esperienza di tutta l'umanità verso il mistero di Cristo» 4. La missione universale della chiesa nasce dalla fede in Gesù Cristo, come si dichiara nella professione della fede trinitaria: «Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli... Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo» 5. Nell'evento della redenzione è la salvezza di tutti, «perché ognuno è stato compreso nel mistero della redenzione e con ognuno Cristo si è unito, per sempre, attraverso questo mistero» 6. Soltanto nella fede si comprende e si fonda la missione. Eppure, anche a causa dei cambiamenti moderni e del diffondersi di nuove idee teologiche alcuni si chiedono: È ancora attuale la missione tra i non cristiani? Non è forse sostituita dal dialogo inter-religioso? Non è un suo obiettivo sufficiente la promozione umana? Il rispetto della coscienza e della libertà non esclude ogni proposta di conversione? Non ci si può salvare in qualsiasi religione? Perché quindi la missione? |
|
5. Risalendo alle origini della chiesa, troviamo chiaramente affermato che Cristo è l'unico salvatore (Gv 14,6) di tutti colui che solo è in grado di rivelare Dio e di condurre a Dio. Alle autorità religiose giudaiche che interrogano gli apostoli in merito alla guarigione dello storpio, da lui operata, Pietro risponde: «Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo... in nessun altro c'è salvezza: non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati». (At 4,10. 12) Questa affermazione, rivolta al sinedrio, ha un valore universale, poiché per tutti - giudei e gentili - la salvezza non può venire che da Gesù Cristo. L'universalità di questa salvezza in Cristo e affermata in tutto il Nuovo Testamento. San Paolo riconosce in Cristo risorto il Signore: «In realtà - scrive anche se ci sono cosiddetti dèi sia nel cielo sia sulla terra, e difatti ci sono molti dèi e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per lui; e c'è un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui». (1 Cor 8,5-6) L'unico Dio e l'unico Signore sono affermati in contrasto con la moltitudine di «dèi» e «signori» che il popolo ammetteva. Paolo reagisce contro il politeismo dell'ambiente religioso del suo tempo e pone in rilievo la caratteristica della fede cristiana: fede in un solo Dio e in un solo Signore, inviato da Dio. Nel Vangelo di san Giovanni questa universalità salvifica di Cristo comprende gli aspetti della sua missione di grazia, di verità e di rivelazione: «Il Verbo è la luce vera, che illumina ogni uomo». (Gv1,9) E ancora: «Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato». (Gv 1,18; cf. Mt 11,27) La rivelazione di Dio si fa definitiva e completa a opera del suo Figlio unigenito: «Dio, che nei tempi antichi aveva già parlato molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo». (Eb 1,1-2; cf. Gv 14,6) In questa Parola definitiva della sua rivelazione Dio si è fatto conoscere nel modo più pieno: egli ha detto all'umanità chi è. E questa autorivelazione definitiva di Dio è il motivo fondamentale per cui la chiesa è per sua natura missionaria. Essa non può non proclamare il Vangelo, cioè la pienezza della verità che Dio ci ha fatto conoscere intorno a se stesso. Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini: «Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo - dico la verità, non mentisco -, maestro dei pagani nella fede e nella verità». (1 Tm 2,5-7; cf. Eb 4,14-16) Gli uomini, quindi, non possono entrare in comunione con Dio se non per mezzo di Cristo, sotto l'azione dello Spirito. Questa sua mediazione unica e universale, lungi dall'essere di ostacolo al cammino verso Dio, è la via stabilita da Dio stesso, e di ciò Cristo ha piena coscienza. Se non sono escluse mediazioni partecipate di vario tipo e ordine, esse tuttavia attingono significato e valore unicamenteda quella di Cristo e non possono essere intese come parallele e complementari. 6. È contrario alla fede cristiana introdurre una qualsiasi separazione tra il Verbo e Gesù Cristo. San Giovanni afferma chiaramente che il Verbo, che «era in principio presso Dio», è lo stesso che «si fece carne»: (Gv 1,2. 14) Gesù è il Verbo incarnato, persona una e indivisibile. Non si può separare Gesù da Cristo, né parlare di un «Gesù della storia», che sarebbe diverso dal «Cristo della fede». La chiesa conosce e confessa Gesù come «il Cristo, il Figlio del Dio vivente»: (Mt 16,16) Cristo non è altro che Gesù di Nazareth, e questi è il Verbo di Dio fatto uomo per la salvezza di tutti. In Cristo «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità» (Col 2,9) e «dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto». (Gv 1,16) «Il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre», (Gv 1,18) è «il Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione... Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, pacificando col sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli». (Col 1,13-14. 19-20.) È proprio questa singolarità unica di Cristo che a lui conferisce un significato assoluto e universale, per cui, mentre è nella storia, è il centro e il fine della stessa storia 7: «Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine». (Ap 22,13) Se, dunque, è lecito e utile considerare i vari aspetti del mistero di Cristo, non bisogna mai perdere di vista la sua unità. Mentre andiamo scoprendo e valorizzando i doni di ogni genere, soprattutto le ricchezze spirituali, che Dio ha elargito a ogni popolo, non possiamo disgiungerli da Gesù Cristo, il quale sta al centro del piano divino di salvezza. Come «con l'incarnazione il Figlio di Dio s'è unito in un certo modo a ogni uomo», così «dobbiamo ritenere che lo Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire in contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale 8. Il disegno divino è «di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra». (Ef 1,10) |
|
7. L'urgenza dell'attività missionaria emerge dalla radicale novità di vita, portata da Cristo e vissuta dai suoi discepoli. Questa nuova vita è dono di Dio, e all'uomo è richiesto di accoglierlo e di svilupparlo, se vuole realizzarsi secondo la sua vocazione integrale in conformità a Cristo. Tutto il Nuovo Testamento è un inno alla vita nuova per colui che crede in Cristo e vive nella sua chiesa. La salvezza in Cristo, testimoniata e annunziata dalla chiesa, è autocomunicazione di Dio: «È l'amore che non soltanto crea il bene, ma fa partecipare alla vita stessa di Dio: Padre, Figlio e Spirito santo. Infatti, colui che ama, desidera donare se stesso» 9. Dio offre all'uomo questa novità di vita. «Si può rifiutare Cristo e tutto ciò che egli ha portato nella storia dell'uomo? Certamente si può. L'uomo è libero. L'uomo può dire a Dio: no. L'uomo può dire a Cristo: no. Ma rimane la domanda fondamentale: È lecito farlo? e in nome di che cosa è lecito?» 10. 8. Nel mondo moderno c'è la tendenza a ridurre l'uomo alla sola dimensione orizzontale. Ma che cosa diventa l'uomo senza apertura verso l'Assoluto? La risposta sta nell'esperienza di ogni uomo, ma è anche inscritta nella storia dell'umanità col sangue versato in nome di ideologie e da regimi politici, che hanno voluto costruire un'«umanità nuova» senza Dio 11. Del resto, a quanti sono preoccupati di salvare la libertà di coscienza, risponde il Concilio Vaticano II: «La persona umana ha il diritto alla libertà religiosa...Tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la coscienza, né sia impedito, entro certi limiti, di agire in conformità a essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata» 12. L'annunzio e la testimonianza di Cristo, quando sono fatti in modo rispettoso delle coscienze, non violano la libertà. La fede esige la libera adesione dell'uomo, ma deve essere proposta, poiché «le moltitudini hanno il diritto di conoscere la ricchezza del mistero di Cristo, nel quale crediamo che tutta l'umanità può trovare, in una pienezza insospettabile, tutto ciò che essa cerca a tentoni su Dio, sull'uomo e sul suo destino, sulla vita e sulla morte, sulla verità... Per questo la chiesa mantiene il suo slancio missionario e vuole, altresì, intensificarlo nel nostro momento storico» 13. Bisogna dire anche, però, sempre col Concilio, che «a motivo della loro dignità tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotati cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. Essi sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e a ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze» 14. |
|
9. Prima beneficiaria della salvezza è la Chiesa: il Cristo se l'è acquistata col suo sangue (cf. At20,28) e l'ha fatta sua collaboratrice nell'opera della salvezza universale. Infatti, Cristo vive in essa; è il suo sposo; opera la sua crescita; compie la sua missione per mezzo di essa. Il Concilio ha ampiamente richiamato il ruolo della chiesa per la salvezza dell'umanità. Mentre riconosce che Dio ama tutti gli uomini e accorda loro la possibilità della salvezza, (cf. 1 Tm 2,4) 15 la Chiesa professa che Dio ha costituito Cristo come unico mediatore e che essa stessa è posta come sacramento universale di salvezza: 16 «Tutti gli uomini, quindi, sono chiamati a questa cattolica unità del popolo di Dio..., e a essa in vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri credenti in Cristo, sia tutti gli uomini universalmente, chiamati a salvezza dalla grazia di Dio». 17 È necessario tener congiunte queste due verità, cioè la reale possibilità della salvezza in Cristo per tutti gli uomini e la necessità della chiesa in ordine a tale salvezza. Ambedue favoriscono la comprensione dell'unico mistero salvifico, sì da potere sperimentare la misericordia di Dio e la nostra responsabilità. La salvezza, che è sempre dono dello Spirito, esige la collaborazione dell'uomo per salvare sia se stesso che gli altri. Così ha voluto Dio, e per questo ha stabilito e coinvolto la chiesa nel piano della salvezza: «Questo popolo messianico - dice il Concilio costituito da Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto quale strumento della redenzione di tutti e, come luce del mondo e sale della terra, è inviato a tutto il mondo». 18 |
|
10. L'universalità della salvezza non significa che essa è accordata solo a coloro che, in modo esplicito, credono in Cristo e sono entrati nella chiesa. Se è destinata a tutti, la salvezza deve essere messa in concreto a disposizione di tutti. Ma è evidente che, oggi come in passato, molti uomini non hanno la possibilità di conoscere o di accettare la rivelazione del Vangelo, di entrare nella chiesa. Essi vivono in condizioni socio-culturali che non lo permettono, e spesso sono stati educati in altre tradizioni religiose. Per essi la salvezza di Cristo è accessibile in virtù di una grazia che, pur avendo una misteriosa relazione con la chiesa, non li introduce formalmente in essa, ma li illumina in modo adeguato alla loro situazione interiore e ambientale. Questa grazia proviene da Cristo, è frutto del suo sacrificio ed è comunicata dallo Spirito santo: essa permette a ciascuno di giungere alla salvezza con la sua libera collaborazione. Per questo il Concilio, dopo aver affermato la centralità del mistero pasquale, afferma: «E ciò non vale solo per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore opera invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti, e la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò, dobbiamo ritenere che lo Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire in contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale». 19 |
|
11. Che dire allora delle obiezioni, già ricordate, in merito alla missione ad gentes? Nel rispetto di tutte le credenze e di tutte le sensibilità, dobbiamo anzitutto affermare con semplicità la nostra fede in Cristo, unico salvatore dell'uomo, fede che abbiamo ricevuto come dono dall'alto senza nostro merito. Noi diciamo con Paolo: «Io non mi vergogno del Vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede». (Rm 1,16) I martiri cristiani di tutti i tempi anche del nostro hanno dato e continuano a dare la vita per testimoniare agli uomini questa fede, convinti che ogni uomo ha bisogno di Gesù Cristo, il quale ha sconfitto il peccato e la morte e ha riconciliato gli uomini con Dio. Cristo si è proclamato Figlio di Dio, intimamente unito al Padre e, come tale, è stato riconosciuto dai discepoli, confermando le sue parole con i miracoli e la risurrezione da morte. La chiesa offre agli uomini il Vangelo, documento profetico, rispondente alle esigenze e aspirazioni del cuore umano: esso è sempre «buona novella». La chiesa non può fare a meno di proclamare che Gesù è venuto a rivelare il volto di Dio e a meritare con la croce e la risurrezione, la salvezza per tutti gli uomini. All'interrogativo: perché la missione? noi rispondiamo con la fede e con l'esperienza della chiesa che aprirsi all'amore di Cristo è la vera liberazione. In lui, soltanto in lui siamo liberati da ogni alienazione e smarrimento, dalla schiavitù al potere del peccato e della morte. Cristo è veramente «la nostra pace», (Ef 2,14) e «l'amore di Cristo ci spinge», (2 Cor 5,14) dando senso e gioia alla nostra vita. La missione è un problema di fede, è l'indice esatto della nostra fede in Cristo e nel suo amore per noi. La tentazione oggi è di ridurre il cristianesimo a una sapienza meramente umana, quasi scienza del buon vivere. In un mondo fortemente secolarizzato è avvenuta una «graduale secolarizzazione della salvezza», per cui ci si batte, sì, per l'uomo, ma per un uomo dimezzato, ridotto alla sola dimensione orizzontale. Noi invece, sappiamo che Gesù è venuto a portare la salvezza integrale, che investe tutto l'uomo e tutti gli uomini, aprendoli ai mirabili orizzonti della filiazione divina. Perché la missione? Perché a noi, come a san Paolo, «è stata concessa la grazia di annunziare ai pagani le imperscrutabili ricchezze di Cristo». (Ef 3,8) La novità di vita in lui è la «buona novella» per l'uomo di tutti i tempi: a essa tutti gli uomini sono chiamati e destinati. Tutti di fatto la cercano, anche se a volte in modo confuso, e hanno il diritto di conoscere il valore di tale dono e di accedervi. La chiesa e, in essa, ogni cristiano non può nascondere né conservare per sé questa novità e ricchezza, ricevuta dalla bontà divina per esser comunicata a tutti gli uomini. Ecco perché la missione, oltre che dal mandato formale del Signore, deriva dall'esigenza profonda della vita di Dio in noi. Coloro che sono incorporati nella chiesa cattolica devono sentirsi dei privilegiati, e per ciò stesso maggiormente impegnati a testimoniare la fede e la vita cristiana come servizio ai fratelli e doverosa risposta a Dio, memori che «la loro eccellente condizione non è da ascrivere ai loro meriti, ma a una speciale grazia di Cristo; per cui, se non vi corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, lungi dal salvarsi, saranno più severamente giudicati». 20 |
|
CAPITOLO II IL REGNO DI DIO 12. «Dio, ricco di misericordia, è colui che Gesù Cristo ci ha rivelato come Padre: proprio il suo Figlio, in se stesso, ce l'ha manifestato e fatto conoscere». 21 Questo scrivevo all'inizio dell'Enciclica Dives in misericordia, mostrando come il Cristo è la rivelazione e l'incarnazione della misericordia del Padre. La salvezza consiste nel credere e accogliere il mistero del Padre e del suo amore che si manifesta e si dona in Gesù mediante lo Spirito. Così si compie il regno di Dio, preparato già dall'antica alleanza, attuato da Cristo e in Cristo, annunciato a tutte le genti dalla chiesa, che opera e prega affinché si realizzi in modo perfetto e definitivo. L'Antico Testamento attesta che Dio si è scelto e formato un popolo, per rivelare e attuare il suo disegno d'amore. Ma, nello stesso tempo, Dio è creatore e padre di tutti gli uomini, di tutti si prende cura, a tutti estende la sua benedizione (Gen12,3) e con tutti ha stretto un'alleanza. (Gen 9,1) Israele fa l'esperienza di un Dio personale e salvatore, (Dt 4,37); (Dt 7,6); (Is 43,1) del quale diventa il testimone e il portavoce in mezzo alle nazioni. Nel corso della sua storia Israele prende coscienza che la sua elezione ha un significato universale.(Is 2,2); (Is 25,6); (Is 60,1); (Ger 3,17); (Ger 16,19) |
|
13. Gesù di Nazareth porta a compimento il disegno di Dio. Dopo aver ricevuto lo Spirito santo nel battesimo, egli manifesta la sua vocazione messianica: percorre la Galilea «predicando il Vangelo di Dio e dicendo: "Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo"». (Mc 1,14); (Mt 4,17); (Lc 4,43) La proclamazione e l'instaurazione del regno di Dio sono l'oggetto della sua missione: «È per questo che sono stato inviato». (Lc 4,43) Ma c'è di più: Gesù è lui stesso la «buona novella», come afferma già all'inizio della missione nella sinagoga del suo paese, applicando a sé le parole di Isaia sull'Unto, inviato dallo Spirito del Signore. (Lc 4,14) Essendo la «buona novella», in Cristo c'è identità tra messaggio e messaggero, tra il dire, l'agire e l'essere. La sua forza, il segreto dell'efficacia della sua azione sta nella totale identificazione col messaggio che annunzia: egli proclama la «buona novella» non solo con quello che dice o fa, ma con quello che è. Il ministero di Gesù è descritto nel contesto dei viaggi nella sua terra. L'orizzonte della missione prima della pasqua è centrato su Israele; tuttavia, Gesù offre un elemento nuovo di importanza capitale. La realtà escatologica non è rinviata a una fine remota del mondo, ma si fa vicina e comincia ad attuarsi. Il regno di Dio si avvicina, (Mc 1,15) si prega perché venga, (Mt 6,10) la fede lo scorge già operante nei segni, quali i miracoli, (Mt 11,4) gli esorcismi, (Mt 3,13) l'annunzio della «buona novella» ai poveri. (Lc 4,18) Negli incontri di Gesù con i pagani è chiaro che l'accesso al regno avviene mediante la fede e la conversione (Mc 1,15) e non per semplice appartenenza etnica. Il regno che Gesù inaugura è il regno di Dio: Gesù stesso rivela chi è questo Dio, che chiama col termine familiare di «abbà», Padre. (Mc 14,36) Il Dio, rivelato soprattutto nelle parabole, (Lc 15,3); (Mt 20,1) è sensibile alle necessità e alle sofferenze di ogni uomo: è un Padre amoroso e pieno di compassione, che perdona e dà gratuitamente le grazie richieste. San Giovanni ci dice che «Dio è amore». (1 Gv4,8) Ogni uomo, perciò, è invitato a «convertirsi» e a «credere» all'amore misericordioso di Dio per lui: il regno crescerà nella misura in cui ogni uomo imparerà a rivolgersi a Dio nell'intimità della preghiera come a un Padre (Lc 11,2); (Mt 23,9) e si sforzerà di compiere la sua volontà. (Mt 7,21) |
|
14. Gesù rivela progressivamente le caratteristiche ed esigenze del regno mediante le sue parole, le sue opere e la sua persona. Il regno di Dio è destinato a tutti gli uomini, essendo tutti chiamati a esserne membri. Per sottolineare questo aspetto, Gesù si è avvicinato soprattutto a quelli che erano ai margini della società, dando a essi la preferenza quando annunziava la «buona novella». All'inizio dei suo ministero egli proclama di essere stato mandato per annunziare ai poveri il lieto messaggio. (Lc4,18) A tutte le vittime del rifiuto e del disprezzo dichiara: «Beati voi poveri» (Lc 6,20); inoltre, a questi emarginati fa già vivere un'esperienza di liberazione stando con loro (Lc 5,30); (Lc 15,2) andando a mangiare con loro, trattandoli come uguali e amici (Lc 7,34), facendoli sentire amati da Dio e rivelando così la sua immensa tenerezza verso i bisognosi e i peccatori. (Lc 15,1) La liberazione e la salvezza, portate dal regno di Dio raggiungono la persona umana nelle sue dimensioni sia fisiche che spirituali. Due gesti caratterizzano la missione di Gesù: il guarire e il perdonare. Le molteplici guarigioni dimostrano la sua grande compassione di fronte alle miserie umane; ma significano pure che nel regno non vi saranno più né malattie né sofferenze e che la sua missione mira fin dall'inizio a liberare le persone da esse. Nella prospettiva di Gesù le guarigioni sono anche segno della salvezza spirituale, cioè della liberazione dal peccato. Compiendo gesti di guarigione, Gesù invita alla fede, alla conversione, al desiderio di perdono. (Lc 5,24) Ricevuta la fede, la guarigione spinge a proseguire più lontano: introduce nella salvezza. (Lc 18,42) I gesti di liberazione dalla possessione del demonio, male supremo e simbolo del peccato e della ribellione contro Dio, sono segni che «il regno di Dio è giunto fra voi». (Mt 12,28) 15. Il regno mira a trasformare i rapporti tra gli uomini e si attua progressivamente, man mano che essi imparano ad amarsi, a perdonarsi, a servirsi a vicenda. Gesù riprende tutta la legge, incentrandola sul comandamento dell'amore. (Mt 22,34); (Lc 10,25) Prima di lasciare i suoi, dà loro un «comandamento nuovo»: «Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato». (Gv 13,34); (Gv 15,12) L'amore, con cui Gesù ha amato il mondo, trova l'espressione più alta nel dono della sua vita per gli uomini, (Gv 15,13) che manifesta l'amore che il Padre ha per il mondo. (Gv 3,16) Perciò, la natura del regno è la comunione di tutti gli esseri umani tra di loro e con Dio. Il regno riguarda tutti: le persone, la società, il mondo intero. Lavorare per il regno vuol dire riconoscere e favorire il dinamismo divino, che è presente nella storia umana e la trasforma. Costruire il regno vuol dire lavorare per la liberazione dal male in tutte le sue forme. In sintesi, il regno di Dio è la manifestazione e l'attuazione del suo disegno di salvezza in tutta la sua pienezza. |
|
16. Risuscitando Gesù dai morti, Dio ha vinto la morte e in lui ha inaugurato definitivamente il suo regno. Durante la vita terrena Gesù è il profeta del regno e, dopo la sua passione, risurrezione e ascensione al cielo, partecipa della potenza di Dio e del suo dominio sul mondo. (Mt 28,18); (At2,36); (Ef 1,18) La risurrezione conferisce una portata universale al messaggio di Cristo, alla sua azione e a tutta la sua missione. I discepoli avvertono che il regno è già presente nella persona di Gesù e viene a poco a poco instaurato nell'uomo e nel mondo mediante un misterioso legame con lui. Dopo la risurrezione, infatti, essi predicavano il regno annunziando Gesù morto e risorto. Filippo in Samaria «recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo». (At 8,12) Paolo a Roma «annunziava il regno di Dio e insegnava le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo». (At 28,31) Anche i primi cristiani annunziavano «il regno di Cristo e di Dio», (Ef 5,5); (Ap 11,15); (Ap 12,10) oppure «il regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo». (2 Pt 1,11) È sull'annunzio di Gesù Cristo, con cui il regno si identifica, che è incentrata la predicazione della chiesa primitiva. Come allora, oggi bisogna unire l'annunzio del regno di Dio (il contenuto del «kérygma» di Gesù) e la proclamazione dell'evento Gesù Cristo (che è il «kérygma» degli apostoli). I due annunzi si completano e si illuminano a vicenda. |
|
17. Oggi si parla molto del regno, ma non sempre in consonanza col sentire ecclesiale. Ci sono, infatti, concezioni della salvezza e della missione che si possono chiamare «antropocentriche» nel senso riduttivo del termine, in quanto sono incentrate sui bisogni terreni dell'uomo. In questa visione il regno tende a diventare una realtà del tutto umana e secolarizzata, in cui ciò che conta sono i programmi e le lotte per la liberazione socio-economica, politica e anche culturale, ma in un orizzonte chiuso al trascendente. Senza negare che anche a questo livello ci siano valori da promuovere tuttavia tale concezione rimane nei confini di un regno dell'uomo decurtato delle sue autentiche e profonde dimensioni, e si traduce facilmente in una delle ideologie di progresso puramente terreno. Il regno di Dio, invece, «non è di questo mondo..., non è di quaggiù». (Gv 18,36) Ci sono, poi, concezioni che di proposito pongono l'accento sul regno e si qualificano come «regno-centriche», le quali danno risalto all'immagine di una chiesa che non pensa a se stessa, ma è tutta occupata a testimoniare e a servire il regno. È una «chiesa per gli altri, si dice, come Cristo è l'«uomo per gli altri». Si descrive il compito della chiesa come se debba procedere in una duplice direzione: da un lato, promuovere i cosiddetti «valori del regno», quali la pace, la giustizia, la libertà, la fraternità; dall'altro, favorire il dialogo fra i popoli, le culture, le religioni, affinché in un vicendevole arricchimento aiutino il mondo a rinnovarsi e a camminare sempre più verso il regno. Accanto ad aspetti positivi, queste concezioni ne rivelano spesso di negativi. Anzitutto, passano sotto silenzio Cristo: il regno, di cui parlano, si fonda su un «teocentrismo», perché - dicono - Cristo non può essere compreso da chi non ha la fede cristiana, mentre popoli, culture e religioni diverse si possono ritrovare nell'unica realtà divina, quale che sia il suo nome. Per lo stesso motivo esse privilegiano il mistero della creazione, che si riflette nella diversità delle culture e credenze ma tacciono sul mistero della redenzione. Inoltre, il regno, quale essi lo intendono, finisce con l'emarginare o sottovalutare la chiesa, per reazione a un supposto «ecclesiocentrismo» del passato e perché considerano la chiesa stessa solo un segno, non privo peraltro di ambiguità. 18. Ora, non è questo il regno di Dio, quale conosciamo dalla rivelazione: esso non può essere disgiunto né da Cristo né dalla chiesa. Come si è detto, Cristo non soltanto ha annunziato il regno, ma in lui il regno stesso si è fatto presente e si è compiuto. E non solo mediante le sue parole e le sue opere: «Innanzi tutto, il regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, il quale è venuto "a servire e a dare la sua vita in riscatto per molti" (Mc 10,45); 22» Il regno di Dio non è un concetto, una dottrina, un programma soggetto a libera elaborazione, ma è innanzi tutto una persona che ha il volto e il nome di Gesù di Nazareth, immagine del Dio invisibile. 23Se si distacca il regno da Gesù, non si ha più il regno di Dio da lui rivelato e si finisce per distorcere sia il senso del regno, che rischia di trasformarsi in un obiettivo puramente umano o ideologico, sia l'identità di Cristo, che non appare più il Signore, a cui tutto deve esser sottomesso. (1 Cor 15,27) Parimenti, non si può disgiungere il regno dalla chiesa. Certo, questa non e fine a se stessa, essendo ordinata al regno di Dio, di cui è germe, segno e strumento. Ma, mentre si distingue dal Cristo e dal regno, la chiesa è indissolubilmente unita a entrambi. Cristo ha dotato la chiesa, suo corpo, della pienezza dei beni e dei mezzi di salvezza; lo Spirito santo dimora in essa, la vivifica con i suoi doni e carismi, la santifica guida e rinnova continuamente. 24 Ne deriva una relazione singolare e unica, ché pur non escludendo l'opera di Cristo e dello Spirito fuori dei confini visibili della chiesa, conferisce a essa un ruolo specifico e necessario. Di qui anche lo speciale legame della chiesa col regno di Dio e di Cristo, che essa ha «la missione di annunziare e di instaurare in tutte le genti». 25 19. È in questa visione d'insieme che si comprende la realtà del regno. Certo, esso esige la promozione dei beni umani e dei valori che si possono ben dire «evangelici», perché sono intimamente legati alla «buona novella». Ma questa promozione che pure sta a cuore alla chiesa, non deve essere distaccata né contrapposta agli altri suoi compiti fondamentali, come l'annunzio del Cristo e del suo Vangelo la fondazione e lo sviluppo di comunità che attuano tra gli uomini l'immagine viva del regno. Non si tema di cadere con ciò in una forma di «ecclesiocentrismo». Paolo VI. che ha affermato l'esistenza di «un legame profondo tra il Cristo la chiesa e l'evangelizzazione» 26 ha pure detto che la chiesa «non è fine a se stessa, ma fervidamente sollecita di essere tutta di Cristo, in Cristo e per Cristo. e tutta degli uomini, fra gli uomini e per gli uomini». 27 |
|
20. La Chiesa è effettivamente e concretamente a servizio del regno. Lo è, anzitutto. con l'annunzio che chiama alla conversione: è, questo, il primo e fondamentale servizio alla venuta del regno nelle singole persone e nella società umana. La salvezza escatologica inizia già ora nella novità di vita in Cristo: «A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome». (Gv 1,12) La chiesa, poi, serve il regno fondando comunità e istituendo chiese particolari e portandole alla maturazione della fede e della carità nell'apertura verso gli altri, nel servizio alla persona e alla società, nella comprensione e stima delle istituzioni umane.» La chiesa, inoltre, serve il regno diffondendo nel mondo i «valori evangelici», che del regno sono espressione e aiutano gli uomini ad accogliere il disegno di Dio. È vero, dunque, che la realtà incipiente del regno può trovarsi anche al di là dei confini della chiesa nell'umanità intera, in quanto questa viva i «valori evangelici» e si apra all'azione dello Spirito che spira dove e come vuole; (Gv 3,8) ma bisogna subito aggiungere che tale dimensione temporale del regno è incompleta, se non è coordinata col regno di Cristo, presente nella chiesa e proteso alla pienezza escatologica. 28 Le molteplici prospettive del regno di Dio 29 non indeboliscono i fondamenti e le finalità dell'attività missionaria, ma piuttosto li fortificano e allargano. La chiesa è sacramento di salvezza per tutta l'umanità, e la sua azione non si restringe a coloro che ne accettano il messaggio. Essa è forza dinamica nel cammino dell'umanità verso il regno escatologico, è segno e promotrice dei valori evangelici tra gli uomini. 30 A questo itinerario di conversione al progetto di Dio la chiesa contribuisce con la sua testimonianza e con le sue attività, quali il dialogo, la promozione umana, l'impegno per la giustizia e la pace, l'educazione e la cura degli infermi, l'assistenza ai poveri e ai piccoli tenendo sempre ferma la priorità delle realtà trascendenti e spirituali, premesse della salvezza escatologica. La chiesa, infine, serve il regno anche con la sua intercessione, essendo esso per la sua natura dono e opera di Dio come ricordano le parabole evangeliche e la preghiera stessa insegnataci da Gesù. Noi dobbiamo chiederlo, accoglierlo, farlo crescere in noi; ma dobbiamo anche cooperare perché sia accolto e cresca tra gli uomini, fino a quando Cristo «consegnerà il regno a Dio Padre» e «Dio sarà tutto in tutti». (1 Cor 15,24) |
|
CAPITOLO III LO SPIRITO SANTO 21. «Al culmine della missione messianica di Gesù, lo Spirito santo diventa presente nel mistero pasquale in tutta la sua soggettività divina, come colui che deve ora continuare l'opera salvifica, radicata nel sacrificio della croce. Senza dubbio questa opera viene affidata da Gesù a uomini: agli apostoli, alla chiesa. Tuttavia, in questi uomini e per mezzo di essi, lo Spirito santo rimane il trascendente soggetto protagonista della realizzazione di tale opera nello spirito dell'uomo e nella storia del mondo». 31 Lo Spirito santo invero è il protagonista di tutta la missione ecclesiale: la sua opera rifulge eminentemente nella missione ad gentes, come appare nella chiesa primitiva per la conversione di Cornelio, (At 10,1) per le decisioni circa i problemi emergenti, (At 15,1) per la scelta dei territori e dei popoli. (At 16,6) Lo Spirito opera per mezzo degli apostoli, ma nello stesso tempo opera anche negli uditori: «Mediante la sua azione, la buona novella prende corpo nelle coscienze e nei cuori umani e si espande nella storia. In tutto ciò è lo Spirito santo che dà la vita». 32 |
|
22. Tutti gli evangelisti, quando narrano l'incontro del Risorto con gli apostoli, concludono col mandato missionario: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni... (At 1,8) Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28,18); (Mc 16,15); (Lc 24,46); (Gv 20,21) Questo invio è invio nello Spirito come appare chiaramente nel testo di san Giovanni: Cristo manda i suoi nel mondo. come il Padre ha mandato lui? e per questo dona loro lo Spirito. A sua volta, Luca collega strettamente la testimonianza che gli apostoli dovranno rendere a Cristo con l'azione dello Spirito, che li metterà in grado di attuare il mandato ricevuto. 23. Le varie forme del «mandato missionario» contengono punti in comune e accenti caratteristici; due elementi però, si ritrovano in tutte le versioni. Anzitutto, la dimensione universale del compito affidato agli apostoli: «Tutte le nazioni»; (Mt 28,19) «in tutto il mondo a ogni creatura»; (Mc 16,15) «tutte le genti»; (Lc 24,47) «fino agli estremi confini della terra». (At 1,8) In secondo luogo, l'assicurazione data loro dal Signore che in questo compito non rimarranno soli, ma riceveranno la forza e i mezzi per svolgere la loro missione. È in ciò la presenza e la potenza dello Spirito e l'assistenza di Gesù: «Essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro». (Mc 16,20) Quanto alle differenze di accento nel mandato, Marco presenta la missione come proclamazione, o kérygma: «Proclamate il Vangelo». (Mc 16,15) Scopo dell'evangelista è di condurre i lettori a ripetere la confessione di Pietro: «Tu sei il Cristo» (Mc 8,29) e a dire, come il centurione romano dinanzi a Gesù morto in croce: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio». (Mc15,39) In Matteo l'accento missionario è posto sulla fondazione della chiesa e sul suo insegnamento; (Mt 28,19); (Mt 16,18) in lui, dunque, il mandato evidenzia che la proclamazione del Vangelo dev'essere completata da una specifica catechesi di ordine ecclesiale e sacramentale. In Luca la missione è presentata come testimonianza, (Lc 24,48); (At 1,8) che verte soprattutto sulla risurrezione. (At 1,22) Il missionario è invitato a credere alla potenza trasformatrice del Vangelo e ad annunziare ciò che Luca illustra bene, cioè la conversione all'amore e alla misericordia di Dio, l'esperienza di una liberazione integrale fino alla radice di ogni male, il peccato. Giovanni è il solo a parlare esplicitamente di «mandato» parola che equivale a «missione» collegando direttamente la missione che Gesù affida ai suoi discepoli con quella che egli stesso ha ricevuto dal Padre: «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». (Gv 20,21) Gesù dice rivolto al Padre: «Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo». (Gv 17,18) Tutto il senso missionario del Vangelo di Giovanni si trova espresso nella «preghiera sacerdotale»: la vita eterna è che «conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo». (Gv 17,3) Scopo ultimo della missione è di far partecipare della comunione che esiste tra il Padre e il Figlio: i discepoli devono vivere l'unità tra loro, rimanendo nel Padre e nel Figlio, perché il mondo conosca e creda. (Gv 17,21) È, questo, un significativo testo missionario, il quale fa capire che si è missionari prima di tutto per ciò che si è come chiesa che vive profondamente l'unità nell'amore, prima di esserlo per ciò che si dice o si fa. I quattro Vangeli, dunque, nell'unità fondamentale della stessa missione, attestano un certo pluralismo che riflette esperienze e situazioni diverse nelle prime comunità cristiane. Esso è anche frutto della spinta dinamica dello stesso Spirito; invita a essere attenti ai diversi carismi missionari e alle diverse condizioni ambientali e umane. Tutti gli evangelisti, però, sottolineano che la missione dei discepoli è collaborazione con quella di Cristo: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. (Mt28,20) La missione, pertanto, non si fonda sulle capacità umane, ma sulla potenza del Risorto. |
|
24. La missione della chiesa, come quella di Gesù, è opera di Dio o - come spesso dice Luca - opera dello Spirito. Dopo la risurrezione e l'ascensione di Gesù gli apostoli vivono un'esperienza forte che li trasforma: la Pentecoste. La venuta dello Spirito santo fa di essi dei testimoni e dei profeti, (At1,8); (At 2,17) infondendo in loro una tranquilla audacia che li spinge a trasmettere agli altri la loro esperienza di Gesù e la speranza che li anima. Lo Spirito dà loro la capacità di testimoniare Gesù con «franchezza». 33 Quando gli evangelizzatori escono da Gerusalemme, lo Spirito assume ancor di più la funzione di «guida» nella scelta sia delle persone, sia delle vie della missione. La sua azione si manifesta specialmente nell'impulso dato alla missione che di fatto secondo le parole di Cristo, si allarga da Gerusalemme a tutta la Giudea e Samaria e fino agli estremi confini della terra. Gli Atti riportano sei sintesi dei «discorsi missionari» che sono rivolti ai giudei agli inizi della chiesa. (At 2,22); (At 3,12); (At 4,9); (At 5,29); (At 10,34); (At 13,16) Questi discorsi-modello, pronunciati da Pietro e da Paolo, annunziano Gesù, invitano a «convertirsi», cioè ad accogliere Gesù nella fede e a lasciarsi trasformare in lui dallo Spirito. Paolo e Barnaba sono spinti dallo Spirito verso i pagani, (At 13,46) il che non avviene senza tensioni e problemi. Come devono vivere la loro fede in Gesù i pagani convertiti? Sono essi vincolati alla tradizione del giudaismo e alla legge della circoncisione? Nel primo Concilio, che riunisce a Gerusalemme intorno agli apostoli i membri di diverse chiese, viene presa una decisione riconosciuta come derivante dallo Spirito: non è necessario che il gentile si sottometta alla legge giudaica per diventare cristiano. (At 15,5); (At 11,28) Da quel momento la chiesa apre le sue porte e diventa la casa in cui tutti possono entrare e sentirsi a proprio agio, conservando la propria cultura e le proprie tradizioni, purché non siano in contrasto col Vangelo. 25. I missionari hanno proceduto lungo questa linea, tenendo ben presenti le attese e speranze, le angosce e sofferenze, la cultura della gente per annunziarle la salvezza in Cristo. I discorsi di Listra e di Atene (At 14,15); (At 17,22) sono riconosciuti come modelli per l'evangelizzazione dei pagani: in essi Paolo «entra in dialogo» con i valori culturali e religiosi dei diversi popoli. Agli abitanti della Licaonia, che praticavano una religione cosmica, egli ricorda esperienze religiose che si riferiscono al cosmo; con i greci discute di filosofia e cita i loro poeti. (At 17,18) Il Dio che vuol rivelare è già presente nella loro vita: è lui, infatti, che li ha creati e dirige misteriosamente i popoli e la storia; tuttavia, per riconoscere il vero Dio, bisogna che abbandonino i falsi dèi che essi stessi hanno fabbricato e si aprano a colui che Dio ha inviato per colmare la loro ignoranza e soddisfare l'attesa del loro cuore. Sono discorsi che offrono un esempio di inculturazione del Vangelo. Sotto la spinta dello Spirito, la fede cristiana si apre decisamente alle «genti», e la testimonianza del Cristo si allarga ai centri più importanti del Mediterraneo orientale per arrivare poi a Roma e all'estremo occidente. E lo Spirito che spinge ad andare sempre oltre, non solo in senso geografico, ma anche al di là delle barriere etniche e religiose, per una missione veramente universale. |
|
26. Lo Spirito spinge il gruppo dei credenti a «fare comunità», a essere chiesa. Dopo il primo annunzio di Pietro il giorno di Pentecoste e le conversioni che ne seguirono, si forma la prima comunità. (At 2,42); (At 4,32) Uno degli scopi centrali della missione, infatti, è di riunire il popolo nell'ascolto del Vangelo, nella comunione fraterna, nella preghiera e nell'eucaristia. Vivere la «comunione fraterna» (koinonìa) significa avere «un cuor solo e un'anima sola», (At 4,32) instaurando una comunione sotto tutti gli aspetti: umano, spirituale e materiale. Difatti, la vera comunità cristiana è impegnata a distribuire i beni terreni, affinché non ci siano indigenti e tutti possano avere accesso a quei beni «secondo le necessità». (At 2,45); (At 4,35) Le prime comunità, in cui regnavano «la letizia e la semplicità di cuore», (At 2,46) erano dinamicamente aperte e missionarie: «Godevano la stima di tutto il popolo». (At 2,47) Prima ancora di essere azione, la missione è testimonianza e irradiazione.34 27. Gli Atti indicano che la missione, indirizzata prima a Israele e poi alle genti, si sviluppa a molteplici livelli. C'è, innanzi tutto, il gruppo dei Dodici che, come un unico corpo guidato da Pietro, proclama la buona novella. C'è, poi, la comunità dei credenti, che. col suo modo di vivere e di operare, rende testimonianza al Signore e converte i pagani. (At 2,46) Ci sono, ancora, gli inviati speciali, destinati ad annunziare il Vangelo. Così la comunità cristiana di Antiochia invia i suoi membri in missione: dopo aver digiunato, pregato e celebrato l'eucaristia, essa avverte che lo Spirito ha scelto Paolo e Barnaba per essere inviati. (At 13,1) Alle sue origini, dunque, la missione è vista come un impegno comunitario e una responsabilità della chiesa locale, che ha bisogno appunto di «missionari» per spingersi verso nuove frontiere. Accanto a quelli inviati ce ne erano altri, che testimoniavano spontaneamente la novità che aveva trasformato la loro vita e collegavano poi le comunità in formazione alla chiesa apostolica. La lettura degli Atti ci fa capire che all'inizio della chiesa la missione gentes pur avendo anche missionari «a vita» che vi si dedicavano per una speciale vocazione, era di fatto considerata come il frutto normale della vita cristiana, l'impegno per ogni credente mediante la testimonianza personale e l'annunzio esplicito, quando possibile. |
|
28. Lo Spirito si manifesta in maniera particolare nella chiesa e nei suoi membri; tuttavia, la sua presenza e azione sono universali, senza limiti né di spazio né di tempo. 35 Il Concilio Vaticano II ricorda l'opera dello Spirito nel cuore di ogni uomo mediante i «semi del Verbo», nelle iniziative anche religiose, negli sforzi dell'attività umana tesi alla verità, al bene, a Dio. 36 Lo Spirito offre all'uomo «luce e forza per rispondere alla suprema sua vocazione»; mediante lo Spirito «l'uomo può arrivare nella fede a contemplare e gustare il mistero del piano divino»; anzi, «dobbiamo ritenere che lo Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire in contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale».37 In ogni caso la chiesa sa che l'uomo, «sollecitato incessantemente dallo Spirito di Dio, non potrà mai essere del tutto indifferente al problema della religione», e «avrà sempre desiderio di sapere. almeno confusamente, quale sia il significato della sua vita, della sua attività e della sua morte». 38 Lo Spirito, dunque. è all'origine stessa della domanda esistenziale e religiosa dell'uomo. la quale nasce non soltanto da situazioni contingenti. ma dalla struttura stessa del suo essere. 39 La presenza e l'attività dello Spirito non toccano solo gli individui. ma la società e la storia, i popoli, le culture. le religioni. Lo Spirito. infatti, sta all'origine dei nobili ideali e delle iniziative di bene dell'umanità in cammino: «Con mirabile provvidenza egli dirige il corso dei tempi e rinnova la faccia della terra». 40 Il Cristo risorto «opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito. non solo suscitando il desiderio del mondo futuro. ma per ciò stesso anche ispirando, purificando e fortificando quei generosi propositi, con i quali la famiglia de li uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di sottomettere a questo fine tutta la terra». 41 È ancora lo Spirito che sparge i «semi del Verbo», presenti nei riti e nelle culture, e li prepara a maturare in Cristo. 42 29. Così lo Spirito, che «soffia dove vuole» (Gv 3,8) e «operava nel mondo prima ancora che Cristo fosse glorificato», 43 che «riempie l'universo abbracciando ogni cosa e conosce ogni voce», (Sap1,7) ci induce ad allargare lo sguardo per considerare la sua azione presente in ogni tempo e in ogni luogo. 44 È un richiamo che io stesso ho fatto ripetutamente e che mi ha guidato negli incontri con i popoli più diversi. Il rapporto della chiesa con le altre religioni è dettato da un duplice rispetto: «Rispetto per l'uomo nella sua ricerca di risposte alle domande più profonde della vita e rispetto per l'azione dello Spirito nell'uomo». 45 L'incontro inter-religioso di Assisi, esclusa ogni equivoca interpretazione, ha voluto ribadire la mia convinzione che «ogni autentica preghiera è suscitata dallo Spirito santo, il quale è misteriosamente presente nel cuore di ogni uomo». 46 Questo Spirito è lo stesso che ha operato nell'incarnazione, nella vita, morte e risurrezione di Gesù e opera nella chiesa. Non è, dunque, alternativo a Cristo, né riempie una specie di vuoto, come talvolta si ipotizza esserci tra Cristo e il Lógos. Quanto lo Spirito opera nel cuore degli uomini e nella storia dei popoli, nelle culture e religioni, assume un ruolo di preparazione evangelica 47 e non può non avere riferimento a Cristo, Verbo fatto carne per l'azione dello Spirito, «per operare lui, l'Uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale». 48 L'azione universale dello Spirito non va poi separata dall'azione peculiare, che egli svolge nel corpo di Cristo ch'è la chiesa. Infatti, è sempre lo Spirito che agisce sia quando vivifica la chiesa e la spinge ad annunziare il Cristo, sia quando semina e sviluppa i suoi doni in tutti gli uomini e i popoli, guidando la chiesa a scoprirli, promuoverli e recepirli mediante il dialogo. Qualsiasi presenza dello Spirito va accolta con stima e gratitudine, ma il discernerla spetta alla chiesa, alla quale Cristo ha dato il suo Spirito per guidarla alla verità tutta intera. (Gv 16,13) |
|
30. Il nostro tempo, con l'umanità in movimento e in ricerca, esige un rinnovato impulso nell'attività missionaria della chiesa. Gli orizzonti e le possibilità della missione si allargano, e noi cristiani siamo sollecitati al coraggio apostolico, fondato sulla fiducia nello Spirito. E lui il protagonista della missione! Sono numerose nella storia dell'umanità le svolte epocali che stimolano il dinamismo missionario, e la chiesa, guidata dallo Spirito, vi ha sempre risposto con generosità e lungimiranza. Né i frutti sono mancati. Da poco è stato celebrato il millennio dell'evangelizzazione della Rus' e dei popoli slavi, mentre si sta per celebrare il cinquecentesimo anniversario dell'evangelizzazione delle Americhe. Parimenti, sono stati di recente commemorati i centenari delle prime missioni in diversi paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'Oceania. Oggi la chiesa deve affrontare altre sfide, proiettandosi verso nuove frontiere sia nella prima missione ad gentes sia nella nuova evangelizzazione di popoli che hanno già ricevuto l'annuncio di Cristo. Oggi a tutti i cristiani, alle chiese particolari e alla chiesa universale sono richiesti lo stesso coraggio che mosse i missionari del passato e la stessa disponibilità ad ascoltare la voce dello Spirito. |
|
CAPITOLO IV GLI IMMENSI ORIZZONTO 31. Il Signore Gesù inviò i suoi apostoli a tutte le persone, a tutti i popoli e a tutti i luoghi della terra. Negli apostoli la chiesa ricevette una missione universale, che non ha confini e riguarda la salvezza nella sua integrità, secondo quella pienezza di vita che Cristo è venuto a portare (Gv 10,10) essa fu «inviata a rivelare e comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e a tutti i popoli della terra». 49 Tale missione è unica, avendo la stessa origine e finalità; ma all'interno di essa si danno compiti e attività diverse. Anzitutto, c'è l'attività missionaria che chiamiamo missione ad gentes in riferimento al Decreto conciliare: si tratta di un'attività primaria della chiesa, essenziale e mai conclusa. Infatti, la chiesa «non può sottrarsi alla missione permanente di portare il Vangelo a quanti sono milioni e milioni di uomini e donne ancora non conoscono Cristo, redentore dell'uomo. È questo il compito più specificamente missionario che Gesù ha affidato e quotidianamente affida alla sua chiesa». 50 |
|
32. Oggi ci si trova di fronte a una situazione religiosa assai diversificata e cangiante: i popoli sono in movimento; realtà sociali e religiose che un tempo erano chiare e definite oggi evolvono in situazioni complesse. Basti pensare ad alcuni fenomeni come l'urbanesimo, le migrazioni di massa, il movimento dei profughi, la scristianizzazione di paesi di antica cristianità, L'influsso emergente del Vangelo e dei suoi valori in paesi a grandissima maggioranza non cristiana, il pullulare di messianismi e di sette religiose. È un rivolgimento di situazioni religiose e sociali, che rende difficile applicare in concreto certe distinzioni e categorie ecclesiali, a cui si era abituati. Già prima del Concilio si diceva di alcune metropoli o terre cristiane che erano diventate «paesi di missione», né la situazione è certo migliorata negli anni successivi. D'altra parte, l'opera missionaria ha prodotto abbondanti frutti in tutte le parti del mondo, per cui esistono chiese impiantate, a volte tanto solide e mature da ben provvedere ai bisogni delle proprie comunità e inviare anche personale per l'evangelizzazione in altre chiese e territori. Di qui il contrasto con aree di antica cristianità, che è necessario rievangelizzare. Alcuni, pertanto, si chiedono se sia ancora il caso di parlare di attività missionaria specifica o di ambiti precisi di essa, o se non si debba ammettere che esiste un'unica situazione missionaria, per cui non c'è che un'unica missione, dappertutto eguale. La difficoltà di interpretare questa realtà complessa e mutevole in ordine al mandato di evangelizzazione si manifesta già nel «vocabolario missionario»: a esempio, c'è una certa esitazione a usare i termini «missioni» e «missionari», giudicati superati e carichi di risonanze storiche negative; si preferisce usare il sostantivo «missione» al singolare e l'aggettivo «missionario» per qualificare ogni attività della chiesa. Questo travaglio denota un cambiamento reale, che ha aspetti positivi. Il cosiddetto rientro o «rimpatrio» delle missioni nella missione della chiesa, il confluire della missiologia nell'ecclesiologia e l'inserimento di entrambe nel disegno trinitario di salvezza, hanno dato un respiro nuovo alla stessa attività missionaria, concepita non già come un compito ai margini della chiesa, ma inserito nel cuore della sua vita, quale impegno fondamentale di tutto il popolo di Dio. Occorre, però, guardarsi dal rischio di livellare situazioni molto diverse e di ridurre, se non far scomparire, la missione e i missionari ad gentes. Dire che tutta la chiesa è missionaria non esclude che esista una specifica missione ad gentes, come dire che tutti i cattolici debbono essere missionari non esclude, anzi richiede che ci siano i «missionari ad gentes e a vita» per vocazione specifica. |
|
33. Le differenze nell'attività all'interno dell'unica missione della chiesa nascono non da ragioni intrinseche alla missione stessa, ma dalle diverse circostanze in cui essa si svolge. 51 Guardando al mondo d'oggi dal punto di vista dell'evangelizzazione, si possono distinguere tre situazioni. Anzitutto, quella a cui si rivolge l'attività missionaria della chiesa: popoli, gruppi umani, contesti socio-culturali in cui Cristo e il suo Vangelo non sono conosciuti, o in cui mancano comunità cristiane abbastanza mature da poter incarnare la fede nel proprio ambiente e annunziarla ad altri gruppi. È, questa, propriamente la missione ad gentes. 52 Ci sono, poi, comunità cristiane che hanno adeguate e solide strutture ecclesiali, sono ferventi di fede e di vita irradiano la testimonianza del Vangelo nel loro ambiente e sentono l'impegno della missione universale. In esse si svolge l'attività, o cura pastorale della chiesa. Esiste, infine, una situazione intermedia, specie nei paesi di antica cristianità, ma a volte anche nelle chiese più giovani, dove interi gruppi di battezzati hanno perduto il senso vivo della fede, o addirittura non si riconoscono più come membri della chiesa, conducendo un'esistenza lontana da Cristo e dal suo Vangelo. In questo caso c'è bisogno di una «nuova evangelizzazione», o «rievangelizzazione». 34. L'attività missionaria specifica, o missione ad gentes, ha come destinatari «i popoli e i gruppi che ancora non credono in Cristo», «coloro che sono lontani da Cristo», tra i quali la chiesa «non ha ancora messo radici» 53 e la cui cultura non è stata ancora influenzata dal Vangelo. 54 Essa si distingue dalle altre attività ecclesiali, perché si rivolge a gruppi e ambienti non cristiani per l'assenza o insufficienza dell'annunzio evangelico e della presenza ecclesiale. Pertanto, si caratterizza come opera di annunzio del Cristo e del suo Vangelo, di edificazione della chiesa locale. di promozione dei valori del regno. La peculiarità di questa missione ad gentes deriva dal fatto che si rivolge ai non cristiani. Occorre, perciò, evitare che tale «compito più specificamente missionario, che Gesù ha affidato e quotidianamente riaffida alla sua chiesa» 55, subisca un appiattimento nella missione globale di tutto il popolo di Dio e, quindi, sia trascurato o dimenticato. D'altronde, i confini fra cura pastorale dei fedeli, nuova evangelizzazione e attività missionaria specifica non sono nettamente definibili, e non è pensabile creare tra di esse barriere o compartimenti-stagno. Bisogna, tuttavia, non perdere la tensione per l'annunzio e per la fondazione di nuove chiese presso popoli o gruppi umani, in cui ancora non esistono poiché questo è il compito primo della chiesa che è inviata a tutti i popoli, fino agli ultimi confini della terra. Senza la missione ad gentes la stessa dimensione missionaria della chiesa sarebbe priva del suo significato fondamentale e della sua attuazione esemplare. È da notare, altresì, una reale e crescente interdipendenza tra le varie attività salvifiche della chiesa: ciascuna influisce sull'altra, la stimola e la aiuta. Il dinamismo missionario crea scambio tra le chiese e orienta verso il mondo esterno, con influssi positivi in tutti i sensi. Le chiese di antica cristianità. a esempio, alle prese col drammatico compito della nuova evangelizzazione, comprendono meglio che non possono essere missionarie verso i non cristiani di altri paesi e continenti, se non si preoccupano seriamente dei non cristiani in casa propria: la missionarietà ad intra è segno credibile e stimolo per quella ad extra, e viceversa. |
|
35. La missione ad gentes ha davanti a sé un compito immane che non è per nulla in via di estinzione. Essa anzi, sia dal punto di vista numerico per l'aumento demografico, sia dal punto di vista socio-culturale per il sorgere di nuove relazioni, contatti e il variare delle situazioni, sembra destinata ad avere orizzonti ancora più vasti. Il compito di annunziare Gesù Cristo presso tutti i popoli appare immenso e sproporzionato rispetto alle forze umane della chiesa. Le diffìcoltà sembrano insormontabili e potrebbero scoraggiare, se si trattasse di un'opera soltanto umana. In alcuni paesi è proibito l'ingresso dei missionari, in altri è vietata non solo l'evangelizzazione, ma anche la conversione e persino il culto cristiano. Altrove gli ostacoli sono di natura culturale: la trasmissione del messaggio evangelico appare irrilevante o incomprensibile, e la conversione è vista come l'abbandono del proprio popolo e della propria cultura. 36. Né mancano le difficoltà interne al popolo di Dio, le quali anzi sono le più dolorose. Già il mio predecessore Paolo VI indicava in primo luogo «la mancanza di fervore, tanto più grave perché nasce dal di dentro; essa si manifesta nella stanchezza, nella delusione, nell'accomodamento, nel disinteresse e, soprattutto, nella mancanza di gioia e di speranza». 56 Grandi ostacoli alla missionarietà della chiesa sono anche le divisioni passate e presenti tra i cristiani, 57 la scristianizzazione in paesi cristiani, la diminuzione delle vocazioni all'apostolato, le contro-testimonianze di fedeli e di comunità cristiane che non seguono nella loro vita il modello di Cristo. Ma una delle ragioni più gravi dello scarso interesse per l'impegno missionario è la mentalità indifferentista, largamente diffusa, purtroppo, anche tra cristiani, spesso radicata in visioni teologiche non corrette e improntata a un relativismo religioso che porta a ritenere che «una religione vale l'altra». Possiamo aggiungere come diceva lo stesso pontefice - che ci sono anche «alibi che possono sviare dall'evangelizzazione. I più insidiosi sono certamente quelli, per i quali si pretende di trovare appoggio nel tale o tal altro insegnamento del Concilio». 58 Al riguardo, raccomando vivamente ai teologi e ai professionisti della stampa cristiana di intensificare il proprio servizio alla missione, per trovare il senso profondo del loro importante lavoro lungo la retta via del sentire cum ecclesia. Le difficoltà interne ed esterne non debbono renderci pessimisti o inattivi. Ciò che conta - qui come in ogni settore della vita cristiana è la fiducia che viene dalla fede, cioè dalla certezza che non siamo noi i protagonisti della missione, ma Gesù Cristo e il suo Spirito. Noi siamo soltanto collaboratori e, quando abbiamo fatto tutto quello che ci è possibile, dobbiamo dire: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare». (Lc 17,10) |
|
37. La missione ad gentes, in forza del mandato universale di Cristo, non ha confini. Si possono, tuttavia, delineare vari ambiti in cui essa si attua, in modo da avere il quadro reale della situazione. |
|
L'attività missionaria è stata normalmente definita in rapporto a territori precisi. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto la dimensione territoriale della missione ad gentes, 59 anche oggi importante al fine di determinare responsabilità, competenze e limiti geografici d'azione. È vero che a una missione universale deve corrispondere una prospettiva universale: la chiesa, infatti, non può accettare che confini geografici e impedimenti politici ostacolino la sua presenza missionaria. Ma è anche vero che l'attività missionaria ad gentes, essendo diversa dalla cura pastorale dei fedeli e dalla nuova evangelizzazione dei non praticanti, si esercita in territori e presso gruppi umani ben delimitati. Il moltiplicarsi delle giovani chiese nei tempi recenti non deve illudere. Nei territori affidati a queste chiese, specie in Asia, ma anche in Africa e in America Latina e Oceania, ci sono vaste zone non evangelizzate: interi popoli e aree culturali di grande importanza in non poche nazioni non sono ancora raggiunte dall'annunzio evangelico e dalla presenza della chiesa locale. 60 Anche in paesi tradizionalmente cristiani ci sono regioni affidate al regime speciale della missione ad gentes con gruppi e aree non evangelizzate. Si impone, quindi, anche in questi paesi non solo una nuova evangelizzazione, ma in certi casi una prima evangelizzazione. 61 Le situazioni, però, non sono omogenee. Pur riconoscendo che le affermazioni circa la responsabilità missionaria della chiesa non sono credibili se non sono autenticate da un serio impegno di nuova evangelizzazione nei paesi di antica cristianità, non pare giusto equiparare la situazione di un popolo che non ha mai conosciuto Gesù Cristo con quella di un altro che l'ha conosciuto, accettato e poi rifiutato, pur continuando a vivere in una cultura che ha assorbito in gran parte i principi e valori evangelici. Sono due condizioni, in rapporto alla fede, sostanzialmente diverse. Pertanto, il criterio geografico, anche se non molto preciso e sempre provvisorio, vale ancora per indicare le frontiere verso cui deve rivolgersi l'attività missionaria. Ci sono paesi e aree geografiche e culturali in cui mancano comunità cristiane autoctone; altrove queste sono talmente piccole, da non essere un segno chiaro di presenza cristiana; oppure queste comunità mancano di dinamismo per evangelizzare le loro società o appartengono a popolazioni minoritarie, non inserite nella cultura nazionale dominante. Nel continente asiatico, in particolare, verso cui dovrebbe orientarsi principalmente la missione ad gentes, i cristiani sono una piccola minoranza, anche se a volte vi si verificano significativi movimenti di conversione ed esemplari modi di presenza cristiana. |
|
Le rapide e profonde trasformazioni che caratterizzano oggi il mondo, in particolare il Sud, influiscono fortemente sul quadro missionario: dove prima c'erano situazioni umane e sociali stabili, oggi tutto è in movimento. Si pensi, a esempio, all'urbanizzazione e al massiccio incremento delle città, soprattutto dove più forte è la pressione demografica. Già ora in non pochi paesi più della metà della popolazione vive in alcune megalopoli, dove i problemi dell'uomo spesso peggiorano anche per l'anonimato in cui si sentono immerse le moltitudini. Nei tempi moderni l'attività missionaria si è svolta soprattutto in regioni isolate, lontane dai centri civilizzati e impervie per difficoltà di comunicazione, di lingua, di clima. Oggi l'immagine della missione ad gentes sta forse cambiando: luoghi privilegiati dovrebbero essere le grandi città, dove sorgono nuovi costumi e modelli di vita, nuove forme di cultura e comunicazione, che poi influiscono sulla popolazione. È vero che la «scelta degli ultimi» deve portare a non trascurare i gruppi umani più marginali e isolati, ma è anche vero che non si possono evangelizzare le persone o i piccoli gruppi, trascurando i centri dove nasce, si può dire. un'umanità nuova con nuovi modelli di sviluppo. Il futuro delle giovani nazioni si sta formando nelle città. Parlando del futuro, non si possono dimenticare i giovani, i quali in numerosi paesi costituiscono già più della metà della popolazione. Come far giungere il messaggio di Cristo ai giovani non cristiani, che sono il futuro di interi continenti? Evidentemente i mezzi ordinari della pastorale non bastano più: occorrono associazioni e istituzioni, gruppi e centri speciali, iniziative culturali e sociali per i giovani. Ecco un campo, dove i moderni movimenti ecclesiali hanno ampio spazio per impegnarsi. Fra le grandi mutazioni del mondo contemporaneo, le migrazioni hanno prodotto un fenomeno nuovo: i non cristiani giungono assai numerosi nei paesi di antica cristianità, creando occasioni nuove di contatti e scambi culturali, sollecitando la chiesa all'accoglienza, al dialogo, all'aiuto e, in una parola, alla fraternità. Fra i migranti occupano un posto del tutto particolare i rifugiati e meritano la massima attenzione. Essi sono ormai molti milioni nel mondo e non cessano di aumentare: sono fuggiti da condizioni di oppressione politica e di miseria disumana, da carestie e siccità di dimensioni catastrofiche. La chiesa deve assumerli nell'ambito della sua sollecitudine apostolica. Infine, si possono ricordare le condizioni di povertà, spesso intollerabile, che vengono a crearsi in non pochi paesi e sono spesso all'origine delle migrazioni di massa. La comunità dei credenti in Cristo è provocata da queste situazioni disumane: l'annunzio di Cristo e del regno di Dio deve diventare strumento di riscatto umano per queste popolazioni. |
|
Paolo, dopo aver predicato in numerosi luoghi, giunto ad Atene, si reca all'areopago, dove annunzia il Vangelo, usando un linguaggio adatto e comprensibile in quell'ambiente. (At 17,22) L'areopago rappresentava allora il centro della cultura del dotto popolo ateniese, e oggi può essere assunto a simbolo dei nuovi ambienti in cui si deve proclamare il Vangelo. Il primo areopago del tempo moderno è il mondo delle comunicazioni, che sta unificando l'umanità rendendola - come si suol dire - «un villaggio globale». I mezzi di comunicazione sociale hanno raggiunto una tale importanza da essere per molti il principale strumento informativo e formativo, di guida e di ispirazione per i comportamenti individuali, familiari, sociali. Le nuove generazioni soprattutto crescono in modo condizionato da essi. Forse è stato un po' trascurato questo areopago: si privilegiano generalmente altri strumenti per l'annunzio evangelico e per la formazione, mentre i mass media sono lasciati all'iniziativa di singoli o di piccoli gruppi ed entrano nella programmazione pastorale in linea secondaria. L'impegno nei mass media, tuttavia, non ha solo lo scopo di moltiplicare l'annunzio: si tratta di un fatto più profondo, perché l'evangelizzazione stessa della cultura moderna dipende in gran parte dal loro influsso. Non basta, quindi, usarli per diffondere il messaggio cristiano e Magistero della chiesa, ma occorre integrare il messaggio stesso in questa «nuova cultura» creata dalla comunicazione moderna. È un problema complesso, poiché questa cultura nasce, prima ancora che dai contenuti, dal fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con nuovi linguaggi, nuove tecniche e nuovi atteggiamenti psicologici. Il mio predecessore Paolo VI diceva che «la rottura fra il Vangelo e la cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca», 62 e il campo dell'odierna comunicazione conferma in pieno questo giudizio. Molti altri sono gli areopaghi del mondo moderno verso cui si deve orientare l'attività missionaria della chiesa. A esempio, l'impegno per la pace, lo sviluppo e la liberazione dei popoli; i diritti dell'uomo e dei popoli, soprattutto quelli delle minoranze. la promozione della donna e del bambino. la salvaguardia del creato sono altrettanti settori da illuminare con la luce del Vangelo. È da ricordare, inoltre, il vastissimo areopago della cultura, della ricerca scientifica, dei rapporti internazionali che favoriscono il dialogo e portano a nuovi progetti di vita. Conviene essere attenti e impegnati in queste istanze moderne. Gli uomini avvertono di essere come naviganti nel mare della vita, chiamati a sempre maggiore unità e solidarietà: le soluzioni ai problemi esistenziali vanno studiate, discusse, sperimentate col concorso di tutti. Ecco perché organismi e convegni internazionali si dimostrano sempre più importanti in molti settori della vita umana, dalla cultura alla politica, dall'economia alla ricerca. I cristiani, che vivono e lavorano in questa dimensione internazionale, debbono sempre ricordare il loro dovere di testimoniare il Vangelo. 38. Il nostro tempo è drammatico e insieme affascinante. Mentre da un lato gli uomini sembrano rincorrere la prosperità materiale e immergersi sempre più nel materialismo consumistico, dall'altro si manifestano l angosciosa ricerca di significato, il bisogno di interiorità, il desiderio di apprendere nuove forme e modi di concentrazione e di preghiera. Non solo nelle culture impregnate di religiosità. ma anche nelle società secolarizzate è ricercata la dimensione spirituale della vita come antidoto alla disumanizzazione. Questo cosiddetto fenomeno del «ritorno religioso» non è privo di ambiguità. ma contiene anche un invito. La chiesa ha un immenso patrimonio spirituale da offrire all'umanità in Cristo che si proclama «la via, la verità e la vita». (Gv 14,6) È il cammino cristiano all'incontro con Dio, alla preghiera, all'ascesi, alla scoperta del senso della vita. Anche questo è un areopago da evangelizzare. |
|
39. Tutte le forme dell'attività missionaria sono contrassegnate dalla consapevolezza di promuovere la libertà dell'uomo annunciando a lui Gesù Cristo. La chiesa deve essere fedele a Cristo, di cui è il corpo e continua la missione. È necessario che essa «segua la stessa strada seguita da Cristo, la strada della povertà, dell'obbedienza, del servizio e del sacrificio di sé fino alla morte, da cui poi risorgendo uscì vincitore». 63 La chiesa, quindi, ha il dovere di fare di tutto per svolgere la sua missione nel mondo e raggiungere tutti i popoli; e ne ha anche il diritto, che le e stato dato da Dio per l'attuazione del suo piano. La libertà religiosa, talvolta ancora limitata o coartata, è la premessa e la garanzia di tutte le libertà che assicurano il bene comune delle persone e dei popoli. È da auspicare che l'autentica libertà religiosa sia concessa a tutti in ogni luogo, e a questo scopo la chiesa si adopera nei vari paesi, specie in quelli a maggioranza cattolica, dove essa ha un maggiore influsso. Ma non si tratta di un problema della religione di maggioranza o di minoranza, bensì di un diritto inalienabile di ogni persona umana. D'altra parte, la chiesa si rivolge all'uomo nel pieno rispetto della sua libertà: 64la missione non coarta la libertà, ma piuttosto la favorisce. La chiesa propone, non impone nulla: rispetta le persone e le culture, e si ferma davanti al sacrario della coscienza. A coloro che si oppongono con i più vari pretesti all'attività missionaria la chiesa ripete: Aprite le porte a Cristo! Mi rivolgo a tutte le chiese particolari, giovani e antiche. Il mondo va sempre più unificandosi, lo spirito evangelico deve portare al superamento di barriere culturali e nazionalistiche, evitando ogni chiusura. Benedetto XV ammoniva già i missionari del suo tempo se mai, «dimentichi della propria dignità, pensassero più alla loro patria terrestre che a quella del cielo». 65 La stessa raccomandazione vale oggi per le chiese particolari: Aprite le porte ai missionari, poiché «ogni chiesa particolare. che si separasse volontariamente dalla chiesa universale, perderebbe il suo riferimento al disegno di Dio e si impoverirebbe nella sua dimensione ecclesiale». 66 |
|
40. L'attività missionaria rappresenta ancor oggi la massima sfida per la chiesa . Mentre si avvicina la fine del secondo millennio della redenzione, si fa sempre più evidente che le genti che non hanno ancora ricevuto il primo annunzio di Cristo sono la maggioranza dell'umanità. Il bilancio dell'attività missionaria nei tempi moderni è certo positivo: la chiesa è stata fondata in tutti i continenti, anzi oggi la maggioranza dei fedeli e delle chiese particolari non è più nella vecchia Europa, ma nei continenti che i missionari hanno aperto alla fede. Rimane, però, il fatto che gli «ultimi confini della terra», a cui si deve portare il Vangelo, si allontanano sempre più, e la sentenza di Tertulliano, secondo cui il Vangelo è stato annunziato in tutta la terra e a tutti i popoli, 67 è ben lontana dalla sua concreta attuazione: la missione ad gentes è ancora agli inizi. Nuovi popoli compaiono sulla scena mondiale e hanno anch'essi il diritto di ricevere l'annunzio della salvezza. La crescita demografica del Sud e dell'Oriente, in paesi non cristiani, fa aumentare di continuo il numero delle persone che ignorano la redenzione di Cristo. Bisogna, dunque, rivolgere l'attenzione missionaria verso quelle aree geografiche e quegli ambienti culturali che sono rimasti al di fuori dell'influsso evangelico. Tutti i credenti in Cristo debbono sentire, come parte integrante della loro fede, la sollecitudine apostolica di trasmetterne ad altri la gioia e la luce. Tale sollecitudine deve diventare, per così dire, fame e sete di far conoscere il Signore quando si allarga lo sguardo agli immensi orizzonti del mondo non cristiano. |
|
CAPITOLO V LE VIE DELLA MISSIONE 41. «L'attività missionaria non è né più né meno che la manifestazione, o epifania, e la realizzazione del disegno di Dio nel mondo e nella storia, nella quale Dio, proprio mediante la missione. attua all'evidenza la storia della salvezza». 68 Quali vie segue la chiesa per giungere a questo risultato? La missione è una realtà unitaria, ma complessa. e si esplica in vari modi, tra cui alcuni sono di particolare importanza nella presente condizione della chiesa e del mondo . |
|
42. L'uomo contemporaneo crede più ai testimoni che ai maestri, 69 più all'esperienza che alla dottrina, più alla vita e ai fatti che alle teorie. La testimonianza della vita cristiana è la prima e insostituibile forma della missione: Cristo, di cui noi continuiamo la missione, è il «testimone» per eccellenza (Ap 1,5); (Ap 3,14) e il modello della testimonianza cristiana. Lo Spirito santo accompagna il cammino della chiesa e la associa alla testimonianza che egli rende a Cristo. (Gv15,26) La prima forma di testimonianza è la vita stessa del missionario della famiglia cristiana e della comunità ecclesiale, che rende visibile un modo nuovo di comportarsi. Il missionario che, pur con tutti i limiti e difetti umani, vive con semplicità secondo il modello di Cristo, è un segno di Dio e delle realtà trascendenti. Ma tutti nella chiesa, sforzandosi di imitare il divino Maestro, possono e debbono dare tale testimonianza, 70 che in molti casi è l'unico modo possibile di essere missionari. La testimonianza evangelica, a cui il mondo è più sensibile, è quella dell'attenzione per le persone e della carità verso i poveri e i piccoli, verso chi soffre. La gratuità di questo atteggiamento e di queste azioni, che contrastano profondamente con l'egoismo presente nell'uomo, fa nascere precise domande che orientano a Dio e al Vangelo. Anche l'impegno per la pace, la giustizia, i diritti dell'uomo, la promozione umana è una testimonianza del Vangelo, se e segno di attenzione per le persone ed è ordinato allo sviluppo integrale dell'uomo. 71 43. Il cristiano e le comunità cristiane vivono profondamente inseriti nella vita dei rispettivi popoli e sono segno del Vangelo anche nella fedeltà alla loro patria, al loro popolo, alla cultura nazionale, sempre però nella libertà che Cristo ha portato. Il cristianesimo è aperto alla fratellanza universale. perché tutti gli uomini sono figli dello stesso Padre e fratelli in Cristo. La chiesa è chiamata a dare la sua testimonianza a Cristo assumendo posizioni coraggiose e profetiche di fronte alla corruzione del potere politico o economico; non cercando essa stessa gloria e beni materiali; usando dei suoi beni per il servizio dei più poveri e imitando la semplicità di vita del Cristo. La chiesa e i missionari debbono dare anche la testimonianza dell'umiltà, rivolta anzitutto verso se stessi, che si traduce nella capacità di un esame di coscienza a livello personale e comunitario, per correggere nei propri comportamenti quanto è anti-evangelico e sfigura il volto di Cristo. |
|
44. L'annunzio ha la priorità permanente nella missione: la chiesa non può sottrarsi al mandato esplicito di Cristo, non può privare gli uomini della «buona novella» che sono amati e salvati da Dio. «L'evangelizzazione conterrà sempre - come base, centro e insieme vertice del suo dinamismo - anche una chiara proclamazione che, in Gesù Cristo... La salvezza è offerta a ogni uomo, come dono di grazia e di misericordia di Dio stesso». 72 Tutte le forme dell'attività missionaria tendono verso questa proclamazione che rivela e introduce nel mistero nascosto nei secoli e svelato in Cristo (Ef3,3); (Col 1,25) il quale è nel cuore della missione e della vita della chiesa, come cardine di tutta l'evangelizzazione. Nella realtà complessa della missione il primo annunzio ha un ruolo centrale e insostituibile, perché introduce «nel mistero dell'amore di Dio, che chiama a stringere in Cristo una personale relazione con lui» 73 e apre la via alla conversione. La fede nasce dall'annunzio, e ogni comunità ecclesiale trae origine e vita dalla risposta personale di ciascun fedele a tale annunzio. 74Come l'economia salvifica è incentrata in Cristo, così l'attività missionaria tende alla proclamazione del suo mistero. L'annunzio ha per oggetto il Cristo crocifisso, morto e risorto: in lui si compie la piena e autentica liberazione dal male, dal peccato e dalla morte; in lui Dio dona la «vita nuova», divina ed eterna. È questa la «buona novella», che cambia l'uomo e la storia dell'umanità e che tutti i popoli hanno il diritto di conoscere. Tale annunzio va fatto nel contesto della vita dell'uomo e dei popoli che lo ricevono. Esso, inoltre, deve essere fatto in atteggiamento di amore e di stima verso chi ascolta, con un linguaggio concreto e adattato alle circostanze. In esso lo Spirito è all'opera e instaura una comunione tra il missionario e gli ascoltatori, possibile in quanto l'uno e gli altri entrano in comunione, per Cristo, col Padre. 75 45. Essendo fatto in unione con l'intera comunità ecclesiale, l'annunzio non è mai un fatto personale. Il missionario è presente e opera in virtù di un mandato ricevuto e, anche se si trova solo, è collegato mediante vincoli invisibili, ma profondi all'attività evangelizzatrice di tutta la chiesa. 76 Gli ascoltatori, prima o poi, intravedono dietro a lui la comunità che lo ha mandato e lo sostiene. L'annunzio è animato dalla fede, che suscita entusiasmo e fervore nel missionario. Come si è detto, gli Atti definiscono tale atteggiamento con la parola parresìa, che significa parlare con franchezza e coraggio, e questo termine ricorre anche in san Paolo: «Nel nostro Dio abbiamo avuto il coraggio di annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte». (1 Ts 2,2) «Pregate. . . anche per me, perché quando apro la bocca, mi sia data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come è mio dovere». (Ef 6,18) Nell'annunziare Cristo ai non cristiani il missionario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l'azione dello Spirito, un'attesa anche se inconscia di conoscere la verità su Dio, sull'uomo, sulla via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. L'entusiasmo nell'annunziare il Cristo deriva dalla convinzione di rispondere a tale attesa, sicché il missionario non si scoraggia né desiste dalla sua testimonianza, anche quando è chiamato a manifestare la sua fede in un ambiente ostile o indifferente. Egli sa che lo Spirito del Padre parla in lui (Mt 10,17); (Lc 12,11) e può ripetere con gli apostoli: «Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito santo». (At 5,32) Egli sa che non annunzia una verità umana, ma la «Parola di Dio», la quale ha una sua intrinseca e misteriosa potenza. (Rm 1,16) La prova suprema è il dono della vita, fino ad accettare la morte per testimoniare la fede in Gesù Cristo. Come sempre nella storia cristiana, i «martiri», cioè i testimoni, sono numerosi e indispensabili al cammino del Vangelo. Anche nella nostra epoca ce ne sono tanti: vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici, a volte eroi sconosciuti che danno la vita per testimoniare la fede. Sono essi gli annunziatori ed i testimoni per eccellenza. |
|
46. L'annunzio della parola di Dio mira alla conversione cristiana, cioè all'adesione piena e sincera a Cristo e al suo Vangelo mediante la fede. La conversione è dono di Dio, opera della Trinità: è lo Spirito che apre le porte dei cuori, affinché gli uomini possano credere al Signore e «confessarlo». (1Cor 12,3) Di chi si accosta a lui mediante la fede Gesù dice: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato». (Gv 6,44) La conversione si esprime fin dall'inizio con una fede totale e radicale, che non pone né limiti né remore al dono di Dio. Al tempo stesso, però, essa determina un processo dinamico e permanente che dura per tutta l'esistenza, esigendo un passaggio continuo dalla «vita secondo la carne» alla «vita secondo lo Spirito». (Rm 8,3) Essa significa accettare, con decisione personale, la sovranità salvifica di Cristo e diventare suoi discepoli. A questa conversione la chiesa chiama tutti, sull'esempio di Giovanni Battista, che preparava la via a Cristo, «predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati» (Mc 1,4) e di Cristo stesso, il quale, «dopo che Giovanni fu arrestato. ... si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo"». (Mc 1,14) Oggi l'appello alla conversione, che i missionari rivolgono ai non cristiani, e messo in discussione o passato sotto silenzio. Si vede in esso un atto di «proselitismo»; si dice che basta aiutare gli uomini a essere più uomini o più fedeli alla propria religione, che basta costruire comunità capaci di operare per la giustizia, la libertà, la pace, la solidarietà. Ma si dimentica che ogni persona ha il diritto di udire la «buona novella» di Dio che si rivela e si dona in Cristo, per attuare in pienezza la sua propria vocazione. La grandezza di questo evento risuona nelle parole di Gesù alla Samaritana: «Se tu conoscessi il dono di Dio», e nel desiderio inconsapevole, ma ardente della donna: «Signore, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete». (Gv 4,10) 47. Gli apostoli, mossi dallo Spirito santo, invitavano tutti a cambiare vita, a convertirsi e a ricevere il battesimo. Subito dopo l'evento della Pentecoste, Pietro parla alla folla in modo convincente: «All'udir tutto questo si sentirono come trafiggere il cuore e chiesero a Pietro e agli altri apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?". E Pietro disse: Convertitevi, e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito santo"». (At2,37) E battezzò in quel giorno circa tremila persone. Pietro ancora, dopo la guarigione dello storpio. parla alla folla e ripete: «Convertitevi dunque, e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati!». (At 3,19) La conversione a Cristo è connessa col battesimo: lo è non solo per la prassi della chiesa, ma per volere di Cristo, che ha inviato a far discepole tutte le genti e a battezzarle (Mt28,19) lo è anche per l'intrinseca esigenza di ricevere la pienezza della vita in lui: «In verità, in verità ti dico Gesù dice a Nicodemo - se uno non nasce da acqua e da Spirito. non può entrare nel regno di Dio». (Gv 3,5) Il battesimo, infatti, ci rigenera alla vita dei fili di Dio, ci unisce a Gesù Cristo, ci unge nello Spirito santo: esso non è un semplice suggello della conversione, quasi un segno esteriore che la dimostri e la attesti, bensì è sacramento che significa e opera questa nuova nascita dallo Spirito, instaura vincoli reali e inscindibili con la Trinità, rende membri del corpo di Cristo, ch'è la chiesa. Tutto questo va ricordato, perché non pochi, proprio dove si svolge la missione ad gentes tendono a scindere la conversione a Cristo dal battesimo, giudicandolo come non necessario. È vero che in certi ambienti si notano aspetti sociologici relativi al battesimo, che ne oscurano il genuino significato di fede. Ciò è dovuto a diversi fattori storici e culturali, che bisogna rimuovere dove ancora sussistono, affinché il sacramento della rigenerazione spirituale appaia in tutto il suo valore: a questo compito devono dedicarsi le comunità ecclesiali locali. È vero anche che non poche persone affermano di essere interiormente impegnate con Cristo e col suo messaggio, ma non lo vogliono essere sacramentalmente, perché, a causa dei loro pregiudizi o delle colpe dei cristiani, non riescono a percepire la vera natura della chiesa, mistero di fede e di amore. 77 Desidero incoraggiare queste persone ad aprirsi pienamente a Cristo ricordando a esse che, se sentono il fascino di Cristo, egli stesso ha voluto la chiesa come «luogo» in cui possono di fatto incontrarlo. Al tempo stesso, invito i fedeli e le comunità cristiane a testimoniare autenticamente Cristo con la loro vita nuova. Certo, ogni convertito è un dono fatto alla chiesa e comporta per essa una grave responsabilità non solo perché va preparato al battesimo col catecumenato e poi seguito con l'istruzione religiosa, ma perché, specialmente se è adulto, porta come un'energia nuova l'entusiasmo della fede, il desiderio di trovare nella chiesa stessa il Vangelo vissuto. Sarebbe per lui una delusione se, entrato nella comunità ecclesiale, vi trovasse una vita priva di fervore e senza segni di rinnovamento. Non possiamo predicare la conversione, se non ci convertiamo noi stessi ogni giorno. |
|
48. La conversione e il battesimo immettono nella chiesa, dove già esiste, o richiedono la costituzione di nuove comunità che confessano Gesù Salvatore e Signore. Ciò fa parte del disegno di Dio, a cui è piaciuto «di chiamare gli uomini a partecipare della sua stessa vita non tanto a uno a uno, ma di riunirli in un popolo, nel quale i suoi figli dispersi si raccogliessero in unità». 78 La missione ad gentes ha questo obiettivo: fondare comunità cristiane, sviluppare chiese fino alla loro completa maturazione. È, questa, una mèta centrale e qualificante dell'attività missionaria, al punto che questa non si può dire esplicata finché non riesce a edificare una nuova chiesa particolare, normalmente funzionante nell'ambiente locale. Di ciò parla ampiamente il Decreto Ad gentes, 79 e dopo il Concilio si è sviluppata una linea teologica per sottolineare che tutto il mistero della chiesa è contenuto in ciascuna chiesa particolare, purché questa non si isoli, ma rimanga in comunione con la chiesa universale e si faccia, a sua volta, missionaria. Si tratta di un grande e lungo lavoro, del quale è difficile indicare le tappe precise, in cui cessa l'azione propriamente missionaria e si passa all'attività pastorale. Ma alcuni punti debbono restare chiari. 49. È necessario. anzitutto, cercare di stabilire in ogni luogo comunità cristiane, che siano «segno della presenza divina nel mondo» 80 e crescano fino a divenire chiese. Nonostante l'alto numero delle diocesi, esistono tuttora vaste aree in cui le chiese locali sono del tutto assenti o insufficienti rispetto alla vastità del territorio e alla densità della popolazione: rimane da compiere un rande lavoro di impianto e di sviluppo della chiesa. Questa fase della storia ecclesiale, detta plantatio ecclesiae non è terminata, anzi in molti raggruppamenti umani deve ancora iniziare. La responsabilità di tale compito ricade sulla chiesa universale e sulle chiese particolari, su tutto il popolo di Dio e su tutte le forze missionarie. Ogni chiesa, anche quella formata da neoconvertiti, è per sua natura missionaria, è evangelizzata ed evangelizzante, e la fede va sempre presentata come dono di Dio da vivere in comunità (famiglie, parrocchie, associazioni) e da irradiare all'esterno sia con la testimonianza di vita che con la parola. L'azione evangelizzatrice della comunità cristiana, prima sul proprio territorio e poi altrove come partecipazione alla missione universale, è il segno più chiaro della maturità della fede. Occorre un radicale cambiamento di mentalità per diventare missionari, e questo vale sia per le persone sia per le comunità. Il Signore chiama sempre a uscire da se stessi, a condividere con gli altri i beni che abbiamo, cominciando da quello più prezioso che è la fede. Alla luce di questo imperativo missionario si dovrà misurare la validità degli organismi, movimenti, parrocchie e opere di apostolato della chiesa. Solo diventando missionaria la comunità cristiana potrà superare divisioni e tensioni interne e ritrovare la sua unità e il suo vigore di fede. Le forze missionarie, provenienti da altre chiese e paesi, devono operare in comunione con quelle locali per lo sviluppo della comunità cristiana. In particolare. tocca a esse - sempre secondo le direttive dei Vescovi e in collaborazione con i responsabili del posto - promuovere la diffusione della fede e l'espansione della chiesa negli ambienti e gruppi non cristiani, animare in senso missionario le chiese locali, cosicché la preoccupazione pastorale sia sempre abbinata a quella per la missione ad gentes. Ogni chiesa farà allora veramente sua la sollecitudine di Cristo, buon Pastore, che si prodiga per il suo gregge, ma al tempo stesso pensa alle «altre pecore che non sono di quest'ovile». (Gv 10,16) 50. Tale sollecitudine costituirà un motivo e uno stimolo per un rinnovato impegno ecumenico. I legami esistenti tra attività ecumenica e attività missionaria rendono necessario considerare due fattori concomitanti. Da una parte, si deve riconoscere che «la divisione dei cristiani è di grave pregiudizio alla santa causa della predicazione del Vangelo a tutti gli uomini e chiude a molti l'accesso alla fede».81 Il fatto che la buona novella della riconciliazione sia predicata dai cristiani tra loro divisi, ne indebolisce la testimonianza, ed è perciò urgente operare per l'unità dei cristiani, affinché l'attività missionaria possa riuscire più incisiva. Al tempo stesso, non dobbiamo dimenticare che gli stessi sforzi verso l'unità costituiscono di per sé un segno dell'opera di riconciliazione che Dio conduce in mezzo a noi. D'altra parte, è vero che tutti quelli che hanno ricevuto il battesimo in Cristo sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, tra loro. È su questa base che si fonda l'orientamento dato dal Concilio: «I cattolici, esclusa ogni forma sia di indifferentismo e di sincretismo, sia di sconsiderata concorrenza, mediante una comune per quanto possibile professione di fede in Dio e in Gesù Cristo di fronte alle genti, mediante la cooperazione nel campo tecnico e sociale come in quello religioso e culturale, collaborino fraternamente con i fratelli separati secondo le norme del Decreto sull'ecumenismo». 82 L'attività ecumenica e la testimonianza concorde a Gesù Cristo dei cristiani appartenenti a differenti chiese e comunità ecclesiali, hanno già recato abbondanti frutti. Ma è sempre più urgente che essi collaborino e testimonino insieme in questo tempo nel quale sètte cristiane e paracristiane seminano la confusione con la loro azione. L'espansione di queste sètte costituisce una minaccia per la chiesa cattolica e per tutte le comunità ecclesiali con le quali essa intrattiene un dialogo. Ovunque possibile e secondo le circostanze locali, la risposta dei cristiani potrà essere anch'essa ecumenica. |
|
51. Un fenomeno in rapida crescita nelle giovani chiese, promosso dai Vescovi e dalle loro Conferenze a volte come scelta prioritaria della pastorale, sono le comunità ecclesiali di base (conosciute anche con altri nomi), le quali stanno dando buona prova come centri di formazione cristiana e di irradiazione missionaria. Si tratta di gruppi di cristiani a livello familiare o di ambiente ristretto, i quali s'incontrano per la preghiera? la lettura della Scrittura. la catechesi, per la condivisione dei problemi umani ed ecclesiali in vista di un impegno comune. Esse sono un segno di vitalità della chiesa, strumento di formazione e di evangelizzazione, valido punto di partenza per una nuova società fondata sulla «civiltà dell'amore». Tali comunità decentrano e articolano la comunità parrocchiale, a cui rimangono sempre unite; si radicano in ambienti popolari e contadini, diventando fermento di vita cristiana, di attenzione per gli ultimi, di impegno per la trasformazione della società. In esse il singolo cristiano fa un'esperienza comunitaria, per cui anch'egli si sente un elemento attivo, stimolato a dare la sua collaborazione all'impegno di tutti. In tal modo esse sono strumento di evangelizzazione e di primo annunzio e fonte di nuovi ministeri, mentre, animate dalla carità di Cristo, offrono anche un'indicazione circa il modo di superare divisioni, tribalismi, razzismi. Ogni comunità, infatti, per essere cristiana, deve fondarsi e vivere in Cristo, nell'ascolto della parola di Dio, nella preghiera incentrata sull'eucaristia, nella comunione espressa in unità di cuore e di anima e nella condivisione secondo i bisogni dei suoi membri. (At 2,42) Ogni comunità - ricordava Paolo VI - deve vivere in unità con la chiesa particolare e universale, nella sincera comunione con i pastori e il Magistero, impegnandosi nell'irradiazione missionaria ed evitando ogni chiusura e strumentalizzazione ideologica. 83 E il sinodo dei Vescovi ha affermato: «Poiché la chiesa è comunione, le nuove comunità di base, se veramente vivono in unità con la chiesa, sono una vera espressione di comunione e mezzo per costruire una comunione più profonda. Perciò, sono motivo di grande speranza per la vita della chiesa». 84 |
|
52. Svolgendo l'attività missionaria tra le genti, la chiesa incontra varie culture e viene coinvolta nel processo d'inculturazione. È, questa, un'esigenza che ne ha segnato tutto il cammino storico, ma oggi è particolarmente acuta e urgente. Il processo di inserimento della chiesa nelle culture dei popoli richiede tempi lunghi: non si tratta di un puro adattamento esteriore, poiché l'inculturazione «significa l'intima trasformazione degli autentici valori culturali mediante l'integrazione nel cristianesimo e il radicamento del cristianesimo nelle varie culture». 85 È, dunque, un processo profondo e globale che investe sia il messaggio cristiano, sia la riflessione e la prassi della chiesa. Ma è pure un processo difficile, perché non deve in alcun modo compromettere la specificità e l'integrità della fede cristiana. Per l'inculturazione la chiesa incarna il Vangelo nelle diverse culture e, nello stesso tempo, introduce i popoli con le loro culture nella sua stessa comunità; 86 trasmette a esse i propri valori, assumendo ciò che di buono c'è in esse e rinnovandole dall'interno. 87 Da parte sua, con l'inculturazione la chiesa diventa segno più comprensibile di ciò che è e strumento più atto della missione. Grazie a questa azione nelle chiese locali, la stessa chiesa universale si arricchisce di espressioni e valori nei vari settori della vita cristiana, quali l'evangelizzazione, il culto, la teologia, la carità; conosce ed esprime ancor meglio il mistero di Cristo, mentre viene stimolata a un continuo rinnovamento. Questi temi, presenti nel Concilio e nel Magistero successivo, ho ripetutamente affrontato nelle mie visite pastorali alle giovani chiese. 88 L'inculturazione è un cammino lento, che accompagna tutta la vita missionaria e chiama in causa i vari operatori della missione ad gentes, le comunità cristiane man mano che si sviluppano, i pastori che hanno la responsabilità di discernere e stimolare la sua attuazione. 89 53. I missionari, provenienti da altre chiese e paesi, devono inserirsi nel mondo socio-culturale di coloro ai quali sono mandati, superando i condizionamenti del proprio ambiente d'origine. Così devono imparare la lingua della regione in cui lavorano. conoscere le espressioni più significative di quella cultura, scoprendone i valori per diretta esperienza. Soltanto con questa conoscenza essi potranno portare ai popoli in maniera credibile e fruttuosa la conoscenza del mistero nascosto. (Rm16,25); (Ef 3,5) Per loro non si tratta certo di rinnegare la propria identità culturale, ma di comprendere, apprezzare, promuovere ed evangelizzare quella dell'ambiente in cui operano e, quindi, mettersi in grado di comunicare realmente con esso, assumendo uno stile di vita che sia segno di testimonianza evangelica e di solidarietà con la gente. Le comunità ecclesiali in formazione, ispirate dal Vangelo, potranno esprimere progressivamente la propria esperienza cristiana in modi e forme originali, consone alle proprie tradizioni culturali, purché sempre in sintonia con le esigenze oggettive della stessa fede. A questo scopo, specie in ordine ai settori di inculturazione più delicati, le chiese particolari del medesimo territorio dovranno operare in comunione fra di loro 90 e con tutta la chiesa, convinte che solo l'attenzione sia alla chiesa universale che alle chiese particolari le renderà capaci di tradurre il tesoro della fede nella legittima varietà delle sue espressioni. 91 Perciò, i gruppi evangelizzati offriranno gli elementi per una «traduzione» del messaggio evangelico, 92 tenendo presenti gli apporti positivi che si sono avuti nei secoli grazie al contatto del cristianesimo con le varie culture, ma senza dimenticare i pericoli di alterazioni che si sono a volte verificati. 93 54. In proposito, restano fondamentali alcune indicazioni. L'inculturazione nel suo retto processo dev'essere guidata da due principi: «La compatibilità col Vangelo e la comunione con la chiesa universale». 94 Custodi del «deposito della fede», i Vescovi cureranno la fedeltà e, soprattutto, il discernimento, 95 per il quale occorre un profondo equilibrio: c'è, infatti, il rischio di passare acriticamente da una specie di alienazione dalla cultura a una supervalutazione di essa, che è un prodotto dell'uomo, quindi è segnata dal peccato. Anch'essa dev'essere «purificata, elevata e perfezionata». 96 Un tale processo ha bisogno di gradualità, in modo che sia veramente espressione dell'esperienza cristiana della comunità: «Occorrerà un'incubazione del mistero cristiano nel genio del vostro popolo - diceva Paolo VI a Kampala-, perché la sua voce nativa, più limpida e più franca, si innalzi armoniosa nel coro delle voci della chiesa universale». 97 Infine l'inculturazione deve coinvolgere tutto il popolo di Dio, non solo alcuni esperti, poiché è noto che il popolo riflette quel genuino senso della fede che non bisogna mai perdere di vista. Essa va sì guidata e stimolata, ma non forzata, per non suscitare reazioni negative nei cristiani: dev'essere espressione di vita comunitaria, cioè maturare in seno alla comunità, e non frutto esclusivo di ricerche erudite. La salvaguardia dei valori tradizionali è effetto di una fede matura. |
|
55. Il dialogo inter-religioso fa parte della missione evangelizzatrice della chiesa . Inteso come metodo e mezzo per una conoscenza e un arricchimento reciproco, esso non è in contrapposizione con la missione ad gentes anzi ha speciali legami con essa e ne è un'espressione. Tale missione, infatti, ha per destinatari gli uomini che non conoscono Cristo e il suo Vangelo, e in gran maggioranza appartengono ad altre religioni. Dio chiama a sé tutte le genti in Cristo, volendo loro comunicare la pienezza della sua rivelazione e del suo amore; né manca di rendersi presente in tanti modi non solo ai singoli individui, ma anche ai popoli mediante le loro ricchezze spirituali, di cui le religioni sono precipua ed essenziale espressione, pur contenendo «lacune, insufficienze ed errori». 98 Tutto ciò il Concilio e il successivo Magistero hanno ampiamente sottolineato, mantenendo sempre fermo che la salvezza viene da Cristo e il dialogo non dispensa dell'evangelizzazione. 99 Alla luce dell'economia di salvezza, la chiesa non vede un contrasto fra l'annuncio del Cristo e il dialogo interreligioso; sente, però, la necessità di comporli nell'ambito della sua missione ad gentes. Occorre, infatti, che questi due elementi mantengano il loro legame intimo e, al tempo stesso, la loro distinzione, per cui non vanno né confusi, né strumentalizzati, né giudicati equivalenti come se fossero intercambiabili. Ho scritto recentemente ai Vescovi dell'Asia: «Anche se la chiesa riconosce volentieri quanto c'è di vero e di santo nelle tradizioni religiose del buddismo, dell'induismo e dell'islam riflessi di quella verità che illumina tutti gli uomini, ciò non diminuisce il suo dovere e la sua determinazione a proclamare senza esitazioni Gesù Cristo, che è "la via, la verità e la vita"... il fatto che i seguaci di altre religioni possano ricevere la grazia di Dio ed essere salvati da Cristo indipendentemente dai mezzi ordinari che egli ha stabilito, non cancella affatto l'appello alla fede e al battesimo che Dio vuole per tutti i popoli». 100Cristo stesso, infatti, «inculcando espressamente la necessità della fede e del battesimo, ha confermato simultaneamente la necessità della chiesa, nella quale gli uomini entrano mediante il battesimo come per una porta». 101 Il dialogo deve esser condotto e attuato con la convinzione che la chiesa è la via ordinaria do salvezza e che solo essa possiede la pienezza dei mezzi di salvezza. 102 56. Il dialogo non nasce da tattica o da interesse, ma è un'attività che ha proprie motivazioni. esigenze, dignità: è richiesto dal profondo rispetto per tutto ciò che nell'uomo ha operato lo Spirito, che soffia dove vuole. 103 Con esso la chiesa intende scoprire i «germi del Verbo», 104 «raggi della verità che illumina tutti gli uomini» 105 germi e raggi che si trovano nelle persone e nelle tradizioni religiose dell'umanità. Il dialogo si fonda sulla speranza e la carità e porterà frutti nello Spirito. Le altre religioni costituiscono una sfida positiva per la chiesa: la stimolano, infatti, sia a scoprire e a riconoscere i segni della presenza del Cristo e dell'azione dello Spirito, sia ad approfondire la propria identità e a testimoniare l'integrità della rivelazione, di cui è depositaria per il bene di tutti. Deriva da qui lo spirito che deve animare tale dialogo nel contesto della missione. L'interlocutore dev'essere coerente con le proprie tradizioni e convinzioni religiose e aperto a comprendere quelle dell'altro, senza dissimulazioni o chiusure, ma con verità, umiltà, lealtà, sapendo che il dialogo può arricchire ognuno. Non ci deve essere nessuna abdicazione né irenismo, ma la testimonianza reciproca per un comune progresso nel cammino di ricerca e di esperienza religiosa e, al tempo stesso, per il superamento di pregiudizi, intolleranze e malintesi. Il dialogo tende alla purificazione e conversione interiore che, se perseguìta con docilità allo Spirito, sarà spiritualmente fruttuosa. 57. Al dialogo si apre un vasto campo, potendo esso assumere molteplici forme ed espressioni: dagli scambi tra esperti delle tradizioni religiose o rappresentanti ufficiali di esse alla collaborazione per lo sviluppo integrale e la salvaguardia dei valori religiosi; dalla comunicazione delle rispettive esperienze spirituali al cosiddetto «dialogo di vita», per cui i credenti delle diverse religioni testimoniano gli uni agli altri nell'esistenza quotidiana i propri valori umani e spirituali e si aiutano a viverli per edificare una società più giusta e fraterna. Tutti i fedeli e le comunità cristiane sono chiamati a praticare il dialogo, anche se non nello stesso grado e forma. Per esso è indispensabile l'apporto dei laici. che «con l'esempio della loro vita e con la propria azione possono favorire il miglioramento dei rapporti tra seguaci delle diverse religioni» 106, mentre alcuni di loro potranno pure dare un contributo di ricerca e di studio. 107 Sapendo che non pochi missionari e comunità cristiane trovano nella via difficile e spesso incompresa del dialogo l'unica maniera di rendere sincera testimonianza a Cristo e generoso servizio all'uomo, desidero incoraggiarli a perseverare con fede e carità, anche là dove i loro sforzi non trovano accoglienza e risposta. Il dialogo è una via verso il regno e darà sicuramente i suoi frutti, anche se tempi e momenti sono riservati al Padre. (At 1,7) |
|
58. La missione ad gentes si svolge ancor oggi, per gran parte, in quelle regioni del Sud del mondo, dove è più urgente l'azione per lo sviluppo integrale e la liberazione da ogni oppressione. La chiesa ha sempre saputo suscitare, nelle popolazioni che ha evangelizzato, la spinta verso il progresso, e oggi i missionari più che in passato sono riconosciuti anche come promotori di sviluppo da governi e esperti internazionali, i quali restano ammirati del fatto che si ottengano notevoli risultati con scarsi mezzi. Nell'Enciclica Sollicitudo rei sociali ho affermato che «la chiesa non ha soluzioni tecniche da offrire al sottosviluppo in quanto tale», ma «dà il primo contributo alla soluzione dell'urgente problema dello sviluppo, quando proclama la verità su Cristo, su se stessa e sull'uomo, applicandola a una situazione concreta». 108 La Conferenza dei Vescovi latino-americani a Puebla ha affermato che «il miglior servizio al fratello è l'evangelizzazione, che lo dispone a realizzarsi come figlio di Dio, lo libera dalle ingiustizie e lo promuove integralmente». 109 La missione della chiesa non è di operare direttamente sul piano economico o tecnico o politico o di dare un contributo materiale allo sviluppo, ma consiste essenzialmente nell'offrire ai popoli non un «avere di più», ma un «essere di più», risvegliando le coscienze col Vangelo. «L'autentico sviluppo umano deve affondare le sue radici in un'evangelizzazione sempre più profonda» 110 La chiesa e i missionari sono promotori di sviluppo anche con le loro scuole, ospedali, tipografie, università, fattorie agricole sperimentali. Ma lo sviluppo di un popolo non deriva primariamente né dal denaro, né dagli aiuti materiali, né dalle strutture tecniche, bensì dalla formazione delle coscienze, dalla maturazione delle mentalità e dei costumi. È l'uomo il protagonista dello sviluppo non il denaro o la tecnica. La chiesa educa le coscienze rivelando ai popoli quel Dio che cercano, ma non conoscono. La grandezza dell'uomo creato a immagine di Dio e da lui amato, l'eguaglianza di tutti gli uomini come figli di Dio, il dominio sulla natura creata e posta a servizio dell'uomo, il dovere di impegnarsi per lo sviluppo di tutto l'uomo e di tutti gli uomini . 59. Col messaggio evangelico la chiesa offre una forza liberante e fautrice di sviluppo proprio perché porta alla conversione del cuore e della mentalità, fa riconoscere la dignità di ciascuna persona, dispone alla solidarietà, all'impegno al servizio dei fratelli, inserisce l'uomo nel progetto di Dio, che è la costruzione del regno di pace, di giustizia a partire già da questa vita. È la prospettiva biblica dei «cieli nuovi e terra nuova», (Is 65,17); (2 Pt 3,13); (Ap 21,1) la quale ha inserito nella storia lo stimolo e la metà per l'avanzamento dell'umanità. Lo sviluppo dell'uomo viene da Dio, dal modello di Gesù uomo-Dio, e deve portare a Dio. 111 Ecco perché tra annunzio evangelico e promozione dell'uomo c'è una stretta connessione. Il contributo della chiesa e della sua opera evangelizzatrice per lo sviluppo dei popoli riguarda non soltanto il Sud del mondo, per combattervi la miseria materiale e il sottosviluppo, 112 ma anche il Nord, che è esposto alla miseria morale e spirituale causata dal «supersviluppo». Certa modernità a-religiosa, dominante in alcune parti del mondo, si basa sull'idea che, per rendere l'uomo più uomo, basti arricchire e perseguire la crescita tecnico-economica. Ma uno sviluppo senza anima non può bastare all'uomo, e l'eccesso di opulenza gli è nocivo come l'eccesso di povertà. Il Nord del mondo ha costruito un tale «modello di sviluppo» e lo diffonde nel Sud, dove il senso di religiosità e i valori umani che vi sono presenti rischiano di esser travolti dall'ondata del consumismo. «Contro la fame cambia la vita» è il motto nato in ambienti ecclesiali, che indica ai popoli ricchi la via per diventare fratelli dei poveri: bisogna ritornare a una vita più austera che favorisca un nuovo modello di sviluppo, attento ai valori etici e religiosi. L'attività missionaria apporta ai poveri la luce e lo stimolo per il vero sviluppo, mentre la nuova evangelizzazione deve, tra l'altro, creare nei ricchi la coscienza che è venuto il momento di farsi realmente fratelli dei poveri nella comune conversione allo sviluppo integrale, aperto all'Assoluto. 113 |
|
60. «La chiesa nel mondo intero - dissi durante la mia visita in Brasile - vuol essere la chiesa dei poveri. Essa vuol estrarre tutta la verità contenuta nelle beatitudini e soprattutto nella prima: "Beati i poveri in spirito"... Essa vuole insegnare questa verità e vuol metterla in pratica come Gesù, che venne a fare e a insegnare». 114 Le giovani chiese, che per lo più vivono fra popoli afflitti da una povertà assai diffusa, esprimono spesso questa preoccupazione come parte integrante della loro missione. La Conferenza generale dell'episcopato latino-americano a Puebla, dopo aver ricordato l'esempio di Gesù? scrive che «i poveri meritano un'attenzione preferenziale, qualunque sia la condizione morale o personale in cui si trovano. Fatti a immagine e somiglianza di Dio per essere suoi figli, questa immagine è offuscata e persino oltraggiata. Perciò, Dio prende le loro difese e li ama. Ne consegue che i primi destinatari della missione sono i poveri, e la loro evangelizzazione è per eccellenza segno e prova della missione di Gesù». 115 Fedele allo spirito delle beatitudini, la chiesa è chiamata alla condivisione con i poveri e gli oppressi di ogni genere. Esorto, perciò, tutti i discepoli di Cristo e le comunità cristiane, dalle famiglie alle diocesi, dalle parrocchie agli istituti religiosi, a fare una sincera revisione della propria vita nel senso della solidarietà con i poveri. Nello stesso tempo, ringrazio i missionari che con la loro presenza amorosa e il loro umile servizio operano per lo sviluppo integrale della persona e della società mediante scuole, centri sanitari, lebbrosari, case di assistenza per handicappati e anziani, iniziative per la promozione della donna e simili. Ringrazio i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i laici per la loro dedizione, mentre incoraggio i volontari di organizzazioni non governative, oggi sempre più numerosi, che si dedicano a queste opere di carità e di promozione umana. Sono, infatti, queste opere che testimoniano l'anima di tutta l'attività missionaria: L'amore, che è e resta il movente della missione, ed è anche «l'unico criterio secondo cui tutto deve essere fatto o non fatto, cambiato o non cambiato. È il principio che deve dirigere ogni azione e il fine a cui essa deve tendere. Quando si agisce con riguardo alla carità o ispirati dalla carità, nulla è disdicevole e tutto è buono». 116 |
|
CAPITOLO VI I RESPONSABILI E GLI OPERATORI 61. Non c'è testimonianza senza testimoni, come non c'è missione senza missionari. Perché collaborino alla sua missione e continuino la sua opera salvifica, Gesù sceglie e invia delle persone come suoi testimoni e apostoli: «Sarete miei testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra». (At 1,8) I Dodici sono i primi operatori della missione universale: essi costituiscono un «soggetto collegiale» della missione, essendo stati scelti da Gesù per restare con lui ed essere inviati «alle pecore perdute della casa d'Israele». (Mt 10,6) Questa collegialità non impedisce che nel gruppo si distinguano singole figure, come Giacomo, Giovanni e, più di tutti, Pietro, la cui persona ha tanto rilievo da giustificare l'espressione: «Pietro e gli altri apostoli». (At 2,14) Grazie a lui si aprono gli orizzonti della missione universale, in cui successivamente eccellerà Paolo, che per volontà divina fu chiamato e inviato tra le genti. (Gal 1,15) Nell'espansione missionaria delle origini, accanto agli apostoli troviamo altri umili operatori che non si debbono dimenticare: sono persone, gruppi, comunità. Un tipico esempio di chiesa locale è la comunità di Antiochia, che da evangelizzata si fa evangelizzatrice e invia i suoi missionari alle genti. (At13,2) La chiesa primitiva vive la missione come compito comunitario, pur riconoscendo nel suo seno degli «inviati speciali», o «missionari consacrati alle genti», come Paolo e Barnaba. 62. Quanto fu fatto all'inizio del cristianesimo per la missione universale conserva la sua validità e urgenza anche oggi. La chiesa è missionaria per sua natura, poiché il mandato di Cristo non è qualcosa di contingente e di esteriore ma raggiunge il cuore stesso della chiesa. Ne deriva che tutta la chiesa e ciascuna chiesa è inviata alle genti. Le stesse chiese più giovani, proprio «perché questo zelo missionario fiorisca nei membri della loro patria» debbono «partecipare quanto prima e di fatto alla missione universale della chiesa, inviando anch'esse dei missionari a predicare dappertutto nel mondo il Vangelo anche se soffrono di scarsezza di clero». 117 Molte già fanno così. e io le incoraggio vivamente a continuare. In questo vincolo essenziale di comunione tra la chiesa universale e le chiese particolari si esercita l'autentica e piena missionarietà: «In un mondo che col crollare delle distanze si fa sempre più piccolo, le comunità ecclesiali devono collegarsi fra di loro, scambiarsi energie e mezzi, impegnarsi insieme nell'unica e comune missione di annunziare e vivere il Vangelo... Le chiese cosiddette giovani... hanno bisogno della forza di quelle antiche, mentre queste hanno bisogno della testimonianza e della spinta delle più giovani, in modo che le singole chiese attingano dalla ricchezza delle altre chiese». 118 |
|
63. Come il Signore risorto conferì al collegio apostolico con a capo Pietro il mandato della missione universale, così questa responsabilità incombe innanzitutto sul collegio dei Vescovi con a capo il successore di Pietro. 119 Consapevole di questa responsabilità, negli incontri con i Vescovi sento il dovere di condividerla in ordine sia alla nuova evangelizzazione che alla missione universale. Mi sono messo in cammino sulle vie del mondo «per annunciare il Vangelo. per "confermare i fratelli" nella fede, per consolare la chiesa. per incontrare l'uomo. Sono viaggi di fede... Sono altrettante occasioni di catechesi itinerante, di annuncio evangelico nel prolungamento, a tutte le latitudini. del Vangelo e del Magistero apostolico, dilatato alle odierne sfere planetarie». 120 I fratelli Vescovi sono con me direttamente responsabili dell'evangelizzazione del mondo, sia come membri del collegio episcopale, sia come pastori delle chiese particolari. In proposito, il Concilio dichiara: «La cura di annunziare in ogni parte della terra il Vangelo appartiene al corpo dei pastori, ai quali in comune Cristo diede il mandato». 121 Esso afferma anche che i Vescovi «sono stati consacrati non soltanto per una diocesi, ma per la salvezza di tutto il mondo». 122 Questa responsabilità collegiale ha conseguenze pratiche. Parimenti, «il Sinodo dei Vescovi... tra gli affari d'importanza generale deve seguire con particolare sollecitudine l'attività missionaria, che è il dovere più alto e più sacro della chiesa». 123 La stessa responsabilità si riflette, in varia misura, nelle Conferenze episcopali e nei loro organismi a livello continentale, che perciò debbono offrire un proprio contributo all'impegno missionario.124 Ampio è pure il dovere missionario di ciascun vescovo, come pastore di una chiesa particolare. Spetta a lui «come capo e centro unitario dell'apostolato diocesano, promuovere, dirigere e coordinare l'attività missionaria... Provveda anche a che l'attività apostolica non resti limitata ai soli convertiti, ma che una giusta parte di missionari e di sussidi sia destinata all'evangelizzazione dei non cristiani». 125 64. Ogni Chiesa particolare deve aprirsi generosamente alle necessità delle altre. La collaborazione fra le chiese, in una reale reciprocità che le rende pronte a dare ed a ricevere, è anche fonte di arricchimento per tutte ed interessa i vari settori della vita ecclesiale. A questo riguardo, resta esemplare la dichiarazione dei Vescovi a Puebla: «Finalmente è giunta l'ora per l'America Latina... di proiettarsi oltre le sue frontiere, ad gentes. È certo che noi stessi abbiamo ancora bisogno di missionari, ma dobbiamo dare della nostra povertà». 126 Con questo spirito invito i Vescovi e le Conferenze episcopali ad attuare generosamente quanto è previsto nella Nota direttiva, che la Congregazione per il clero ha emanato per la collaborazione tra le chiese particolari e, specialmente, per la migliore distribuzione del clero nel mondo. 127 La missione della chiesa è più vasta della «comunione fra le chiese»: questa deve essere orientata, oltre che all'aiuto per la rievangelizzazione, anche e soprattutto nel senso della missionarietà specifica. Mi appello a tutte le chiese, giovani e antiche, perché condividano con me questa preoccupazione, curando l'incremento delle vocazioni missionarie e superando le varie difficoltà. |
|
65. Fra gli operatori della pastorale missionaria occupano tuttora, come in passato, un posto di fondamentale importanza quelle persone e istituzioni, a cui il Decreto Ad gentes dedica lo speciale capitolo dal titolo: «I missionari». 128 Al riguardo, s'impone un'approfondita riflessione, anzitutto, per i missionari stessi, che dai cambiamenti della missione possono essere indotti a non capir più il senso della loro vocazione, a non saper più che cosa precisamente la chiesa si attenda oggi da loro. Punto di riferimento sono queste parole del Concilio: «Benché l'impegno di diffondere la fede ricada su qualsiasi discepolo di Cristo in proporzione delle sue possibilità, Cristo Signore chiama sempre dalla moltitudine dei suoi discepoli quelli che egli vuole, per averli con sé e per inviarli a predicare alle genti. Perciò, egli? per mezzo dello Spirito santo, che distribuisce come vuole i suoi carismi per il bene delle anime, accende nel cuore dei singoli la vocazione missionaria e insieme suscita in seno alla chiesa quelle istituzioni che si assumono come dovere specifico il compito dell'evangelizzazione, che riguarda tutta la chiesa». 129 Si tratta, dunque, di una «vocazione speciale», modellata su quella degli apostoli. Essa si manifesta nella totalità dell'impegno per il servizio dell'evangelizzazione: è impegno che coinvolge tutta la persona e la vita del missionario, esigendo da lui una donazione senza limiti di forze e di tempo. Coloro che sono dotati di tale vocazione, «inviati dalla legittima autorità, si portano per spirito di fede e di obbedienza verso coloro che sono lontani da Cristo, riservandosi esclusivamente per quell'opera per la quale, come ministri del Vangelo, sono stati assunti». 130 I missionari devono sempre meditare sulla corrispondenza che il dono da loro ricevuto richiede e aggiornare la loro formazione dottrinale e apostoli. 66. Gli istituti missionari, poi, devono impiegare tutte le risorse necessarie, mettendo a frutto la loro esperienza e creatività nella fedeltà al carisma originario, per preparare adeguatamente i candidati e assicurare il ricambio delle energie spirituali, morali e fisiche dei loro membri. 131 Si sentano essi parte viva della comunità ecclesiale e operino in comunione con essa. Difatti «ogni istituto è nato per la chiesa ed è tenuto ad arricchirla con le proprie caratteristiche secondo un particolare spirito e una missione speciale». e di una tale fedeltà al carisma originario gli stessi Vescovi sono custodi. 132 Gli istituti missionari sono nati in genere dalle chiese di antica cristianità e storicamente sono stati strumenti della congregazione di Propaganda Fide per la diffusione della fede e la fondazione di nuove chiese. Essi accolgono oggi in misura crescente candidati provenienti dalle giovani chiese che hanno fondato, mentre nuovi istituti sono sorti proprio nei paesi che prima ricevevano solo missionari e che oggi li mandano. È da lodare questa duplice tendenza, che dimostra la validità e l'attualità della specifica vocazione missionaria di questi istituti, tuttora «assolutamente necessari», 133 non solo per l'attività missionaria ad gentes, com'è nella loro tradizione, ma anche per l'animazione missionaria sia nelle chiese di antica cristianità, sia in quelle più giovani. La vocazione speciale dei missionari ad vitam conserva tutta la sua validità: essa rappresenta il paradigma dell'impegno missionario della chiesa, che ha sempre bisogno di donazioni radicali e totali, di impulsi nuovi e arditi. I missionari e le missionarie, che hanno consacrato tutta la vita per testimoniare fra le genti il Risorto, non si lascino, dunque, intimorire da dubbi, incomprensioni, rifiuti, persecuzioni. Risveglino la grazia del loro carisma specifico e riprendano con coraggio il loro cammino, preferendo - in spirito di fede, obbedienza e comunione con i propri pastori - i posti più umili e ardui. |
|
67. Collaboratori del vescovo, i presbiteri in forza del sacramento dell'ordine sono chiamati a condividere la sollecitudine per la missione: «Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza, "fino agli estremi confini della terra", dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli apostoli». 134 Per questo motivo, la stessa formazione dei candidati al sacerdozio deve mirare a dar loro «quello spirito veramente cattolico che li abitui a guardare oltre i confini della propria diocesi, nazione o rito, per andare incontro alle necessità della missione universale, pronti a predicare dappertutto il Vangelo».135 Tutti i sacerdoti debbono avere cuore e mentalità missionaria, essere aperti ai bisogni della chiesa e del mondo, attenti ai più lontani e, soprattutto, ai gruppi non cristiani del proprio ambiente. Nella preghiera e, in particolare, nel sacrificio eucaristico sentano la sollecitudine di tutta la chiesa per tutta l'umanità. Specialmente i sacerdoti che si trovano in aree a minoranza cristiana debbono essere mossi da singolare zelo e impegno missionario: il Signore affida loro non solo la cura pastorale della comunità cristiana, ma anche e soprattutto l'evangelizzazione dei loro compatrioti che non fanno parte del suo gregge. Essi «non mancheranno di rendersi concretamente disponibili allo Spirito santo e al vescovo, per essere mandati a predicare il Vangelo oltre i confini del loro paese. Ciò richiederà in essi non solo maturità nella vocazione, ma pure una capacità non comune di distacco dalla propria patria, etnia e famiglia, e una particolare idoneità a inserirsi nelle altre culture con intelligenza e rispetto». 136 68. Nell'Enciclica Fidei donum Pio XII con intuito profetico incoraggiò i Vescovi a offrire alcuni dei loro sacerdoti per un servizio temporaneo alle chiese d'Africa, approvando le iniziative già esistenti in proposito. A venticinque anni di distanza volli sottolineare la grande novità di quel documento, «che ha fatto superare la dimensione territoriale del servizio presbiterale, per destinarlo a tutta la chiesa».137 Oggi risultano confermate la validità e la fruttuosità di questa esperienza: infatti, i presbiteri detti Fidei donum evidenziano in modo singolare il vincolo di comunione tra le chiese, danno un prezioso apporto alla crescita di comunità ecclesiali bisognose, mentre attingono da esse freschezza e vitalità di fede. Occorre certo che il servizio missionario del sacerdote diocesano risponda ad alcuni criteri e condizioni. Si devono inviare sacerdoti scelti tra i migliori, idonei e debitamente preparati al peculiare lavoro che li attende. 138 Essi dovranno inserirsi nel nuovo ambiente della chiesa che li accoglie con animo aperto e fraterno e costituiranno un unico presbiterio con i sacerdoti locali, sotto l'autorità del vescovo. 139 Auspico che lo spirito di servizio aumenti in seno al presbiterio delle chiese antiche e sia promosso in quello delle chiese più recenti. |
|
69. Nell'inesauribile e multiforme ricchezza dello Spirito si collocano le vocazioni degli istituti di vita consacrata, i cui membri, «dal momento che si dedicano al servizio della chiesa in forza della loro stessa consacrazione, sono tenuti all'obbligo di prestare l'opera loro in modo speciale nell'azione missionaria, con lo stile proprio dell'istituto». 140 La storia attesta le grandi benemerenze delle famiglie religiose nella propagazione della fede e nella formazione di nuove chiese: dalle antiche istituzioni monastiche agli ordini medioevali, fino alle moderne congregazioni. a) Seguendo il Concilio, invito gli istituti di vita contemplativa a stabilire comunità presso le giovani chiese, per rendere «tra i non cristiani una magnifica testimonianza della maestà e della carità di Dio, come anche dell'unione che si stabilisce nel Cristo». 141 Questa presenza è dappertutto benefica nel mondo non cristiano, specialmente in quelle regioni, dove le religioni hanno in grande stima la vita contemplativa per l'ascesi e la ricerca dell'Assoluto. b) Agli istituti di vita attiva addito gli immensi spazi della carità, dell'annunzio evangelico, dell'educazione cristiana, della cultura e della solidarietà verso i poveri, i discriminati, gli emarginati e oppressi. Tali istituti, tendano o meno a un fine strettamente missionario, si devono interrogare circa la loro possibilità e disponibilità a estendere la propria azione per espandere il regno di Dio. Questa richiesta è stata accolta nei tempi più recenti da non pochi istituti, ma vorrei che fosse meglio considerata e attuata per un autentico servizio. La chiesa deve far conoscere i grandi valori evangelici di cui è portatrice, e nessuno li testimonia più efficacemente di chi fa professione di vita consacrata nella castità, povertà e obbedienza, in totale donazione a Dio e in piena disponibilità a servire l'uomo e la società sull'esempio di Cristo. 142 70. Una speciale parola di apprezzamento rivolgo alle religiose missionarie, nelle quali la verginità per il regno si traduce in molteplici frutti di maternità secondo lo spirito: proprio la missione ad gentes offre loro un campo vastissimo per «donarsi con amore in modo totale e indiviso». 143 L'esempio e l'operosità della donna vergine, consacrata alla carità verso Dio e verso il prossimo, specie il più povero, sono indispensabili come segno evangelico presso quei popoli e culture in cui la donna deve ancora compiere un lungo cammino in ordine alla sua promozione umana e liberazione. Auguro che molte giovani donne cristiane sentano l'attrattiva di donarsi a Cristo con generosità, attingendo dalla loro consacrazione la forza e la gioia per testimoniarlo tra i popoli che lo ignorano. |
|
71. I pontefici dell'età più recente hanno molto insistito sull'importanza del ruolo dei laici nell'attività missionaria. 144 Nell'Esortazione Christifideles laici anch'io ho trattato esplicitamente della «missione permanente di portare il Vangelo a quanti e sono milioni e milioni di uomini e di donne - ancora non conoscono Cristo redentore dell'uomo» 145 e del corrispondente impegno dei fedeli laici. La missione è di tutto il popolo di Dio: anche se la fondazione di una nuova chiesa richiede l'eucaristia e, quindi, il ministero sacerdotale, tuttavia la missione, che si esplica in svariate forme, è compito di tutti i fedeli. La partecipazione dei laici all'espansione della fede risulta chiara, fin dai primi tempi del cristianesimo, a opera sia di singoli fedeli e famiglie, sia dell'intera comunità. Ciò ricordava già Pio XII, richiamando nella prima Enciclica missionaria le vicende delle missioni laicali. 146 Nei tempi moderni non è mancata la partecipazione attiva dei missionari laici e delle missionarie laiche. Come non ricordare l'importante ruolo svolto da queste, il loro lavoro nelle famiglie, nelle scuole, nella vita politica. sociale e culturale e, in particolare, il loro insegnamento della dottrina cristiana? Bisogna anzi riconoscere - ed è un titolo di onore che alcune chiese hanno avuto inizio grazie all'attività dei laici e delle laiche missionarie. Il Vaticano II ha confermato questa tradizione, illustrando il carattere missionario di tutto il popolo di Dio in particolare l'apostolato dei laici 147 e sottolineando il contributo specifico che essi son chiamati a dare nell'attività missionaria. 148 La necessità che tutti i fedeli condividano tale responsabilità non e solo questione di efficacia apostolica, ma è un dovere-diritto fondato sulla dignità battesimale per cui «i fedeli partecipano, per la loro parte, al triplice ufficio - sacerdotale profetico e regale di Gesù Cristo». 149 Essi, perciò, «sono tenuti all'obbligo generale e hanno diritto di impegnarsi, sia come singoli, sia riuniti in associazioni, perché l'annunzio della salvezza sia conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancor di più in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro». 150 Inoltre, per l'indole secolare. che è loro propria, hanno la particolare vocazione a «cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio». 151 72. I settori di presenza e di azione missionaria dei laici sono molto ampi. «Il primo campo... è il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale dell'economia...» 152 sul piano locale, nazionale e internazionale. All'interno della chiesa si presentano vari tipi di servizi, funzioni, ministeri e forme di animazione della vita cristiana. Ricordo, quale novità emersa in non poche chiese nei tempi recenti, il grande sviluppo dei «movimenti ecclesiali», dotati di dinamismo missionario. Quando si inseriscono con umiltà nella vita delle chiese locali e sono accolti cordialmente da Vescovi e sacerdoti nelle strutture diocesane e parrocchiali, i movimenti rappresentano un vero dono di Dio per la nuova evangelizzazione e per l'attività missionaria propriamente detta. Raccomando, quindi, di diffonderli e di avvalersene per ridare vigore, soprattutto tra i giovani, alla vita cristiana e all'evangelizzazione, in una visione pluralistica dei modi di associarsi e di esprimersi. Nell'attività missionaria sono da valorizzare le varie espressioni del laicato, rispettando la loro indole e finalità: associazioni del laicato missionario, organismi cristiani di volontariato internazionale, movimenti ecclesiali, gruppi e sodalizi di vario genere siano impegnati nella missione ad gentes e nella collaborazione con le chiese locali. In questo modo sarà favorita la crescita di un laicato maturo e responsabile, la cui «formazione... si pone nelle giovani chiese come elemento essenziale e irrinunciabile della plantatio ecclesiale». 153 |
|
73. Tra i laici che diventano evangelizzatori si trovano in prima fila i catechisti. Il Decreto missionario li definisce «quella schiera degna di lode, tanto benemerita dell'opera missionaria tra le genti... Essi, animati da spirito apostolico e facendo grandi sacrifici, danno un contributo singolare e insostituibile alla propagazione della fede e della chiesa». 154 Non è senza ragione che le chiese di antica data, impegnandosi nella nuova evangelizzazione, abbiano moltiplicato i catechisti e intensificato la catechesi. «Sono i catechisti in terra di missione coloro che meritano, in modo tutto speciale, questo titolo di "catechisti"... chiese ora fiorenti non sarebbero state edificate senza di loro». 155 Anche col moltiplicarsi dei servizi ecclesiali ed extraecclesiali il ministero dei catechisti rimane sempre necessario e ha peculiari caratteristiche: i catechisti sono operatori specializzati. testimoni diretti. evangelizzatori insostituibili, che rappresentano la forza basilare delle comunità cristiane, specie nelle giovani chiese, come ho più volte affermato e constatato nei miei viaggi missionari. Il nuovo codice di Diritto canonico ne riconosce i compiti, le qualità, i requisiti. 156 Ma non si può dimenticare che il lavoro dei catechisti si va facendo sempre più difficile e impegnativo per i cambiamenti ecclesiali e culturali in corso. Vale ancor oggi quanto già suggeriva il Concilio: una più accurata preparazione dottrinale e pedagogica, il costante rinnovamento spirituale e apostolico, la necessità di «garantire un decoroso tenore di vita e di sicurezza sociale» ai catechisti. 157 È importante, altresì, favorire la creazione e il potenziamento delle scuole per catechisti, che, approvate dalle Conferenze episcopali, rilascino titoli ufficialmente riconosciuti da queste ultime. 158 74. Accanto ai catechisti bisogna ricordare le altre forme di servizio alla vita della chiesa e alla missione, e gli altri operatori: animatori della preghiera, del canto e della liturgia; capi di comunità ecclesiali di base e di gruppi biblici; incaricati delle opere caritative; amministratori dei beni della chiesa; dirigenti dei vari sodalizi apostolici; insegnanti di religione nelle scuole. Tutti i fedeli laici debbono dedicare alla chiesa parte del loro tempo, vivendo con coerenza la propria fede. |
|
75. I responsabili e gli operatori della pastorale missionaria devono sentirsi uniti nella comunione che caratterizza il corpo mistico. Per questo Cristo ha pregato nell'ultima cena: «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato». (Gv17,21) È in questa comunione il fondamento della fecondità della missione. Ma la chiesa è anche una comunione visibile e organica, e perciò la missione richiede pure una unione esterna e ordinata tra le diverse responsabilità e funzioni, in modo che tutte le membra «indirizzino in piena unanimità le loro forze all'edificazione della chiesa». 159 Spetta al dicastero missionario «dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le chiese orientali». 160 Per questo «è suo compito suscitare e distribuire, secondo i bisogni più urgenti delle regioni, i missionari..., elaborare un piano organico di azione, emanare norme direttive e principi adeguati in ordine all'evangelizzazione, dare l'impulso iniziale». 161 Non posso che confermare queste sagge disposizioni: per rilanciare la missione ad gentes occorre un centro di propulsione, di direzione e di coordinamento che è la Congregazione per l'evangelizzazione. Invito le Conferenze episcopali e i loro organismi, superiori maggiori degli ordini, congregazioni e istituti gli organismi laicali impegnati nell'attività missionaria a collaborare fedelmente con detta Congregazione, che ha l'autorità necessaria per programmare e dirigere l'attività e la cooperazione missionaria a livello universale. La medesima Congregazione, avendo alle spalle una lunga e gloriosa esperienza, è chiamata a svolgere un ruolo di primaria importanza sul piano della riflessione e dei programmi operativi, di cui la chiesa ha bisogno per orientarsi più decisamente verso la missione nelle sue varie forme. A questo fine, la Congregazione deve mantenere strette relazioni con gli altri dicasteri della Santa Sede, con le chiese particolari e con le forze missionarie. In un'ecclesiologia di comunione, in cui la chiesa è tutta missionaria, ma al tempo stesso si confermano sempre indispensabili vocazioni e istituzioni specifiche per il lavoro ad gentes rimane molto importante il ruolo di guida e di coordinamento del dicastero missionario per affrontare insieme le grandi questioni di comune interesse, salve le competenze proprie di ciascuna autorità e struttura. 76. Per l'indirizzo e il coordinamento dell'attività missionaria a livello nazionale e regionale rivestono grande importanza le Conferenze episcopali e i loro diversi raggruppamenti. A loro il Concilio chiede di «trattare in pieno accordo le questioni più gravi e i problemi più urgenti, senza trascurare però le differenze tra luogo e luogo», 162 nonché il problema dell'inculturazione. Di fatto, c'è già un'ampia e regolare azione in questo campo e i frutti sono visibili. È un'azione che deve essere intensificata e meglio raccordata con quella di altri organismi delle stesse Conferenze affinché la sollecitudine missionaria non sia demandata alla cura di un dato settore od organismo, ma sia condivisa da tutti. Gli stessi organismi e Istituzioni, che attendono all'attività missionaria, colleghino opportunamente sforzi e iniziative. Le Conferenze dei superiori maggiori, poi, abbiano questo stesso impegno nel loro ambito, in contatto con le Conferenze episcopali, secondo le indicazioni e norme stabilite, 163 ricorrendo anche a commissioni miste. 164 Sono, infine, auspicabili incontri e forme di collaborazione tra le varie istituzioni missionarie per quanto riguarda sia la formazione e lo studio, 165 sia l'azione apostolica da svolgere. |
|
LA COOPERAZIONE ALL'ATTIVITÀ MISSIONARIA 77. Membri della chiesa, in forza del battesimo tutti i cristiani sono corresponsabili dell'attività missionaria. La partecipazione delle comunità e dei singoli fedeli a questo diritto-dovere è chiamata «cooperazione missionaria». Tale cooperazione si radica e si vive innanzitutto nell'essere personalmente uniti a Cristo: solo se si è uniti a lui come il tralcio alle vite, (Gv 15,5) si possono produrre buoni frutti. La santità di vita permette a ogni cristiano di essere fecondo nella missione della chiesa: «Il sacro Concilio invita tutti a un profondo rinnovamento interiore, affinché, avendo una viva coscienza della propria responsabilità in ordine alla diffusione del Vangelo, prendano la loro parte nell'attività missionaria presso le genti». 166 La partecipazione alla missione universale, quindi, non si riduce ad alcune particolari attività, ma è il segno della maturità di fede e di una vita cristiana che porta frutti. Così il credente allarga i confini della sua carità, manifestando la sollecitudine per coloro che sono lontani, come per quelli che sono vicini: prega per le missioni e per le vocazioni missionarie, aiuta i missionari, ne segue l'attività con interesse e, quando ritornano, li accoglie con quella gioia con cui le prime comunità cristiane ascoltavano dagli apostoli le meraviglie che Dio aveva operato mediante la loro predicazione. (At 14,27) |
|
Preghiera e sacrifici per i missionari 78. Tra le forme di partecipazione il primo posto spetta alla cooperazione spirituale: preghiera, sacrificio testimonianza di vita cristiana. La preghiera deve accompagnare il cammino dei missionari, perché l' annunzio della Parola sia reso efficace dalla grazia divina. San Paolo nelle sue Lettere chiede spesso ai fedeli di pregare per lui, perché gli sia concesso di annunziare il Vangelo con fiducia e franchezza. Alla preghiera è necessario unire il sacrificio: il valore salvifico di ogni sofferenza, accettata e offerta a Dio con amore, scaturisce dal sacrificio di Cristo, che chiama le membra del suo mistico corpo ad associarsi ai suoi patimenti, a completarli nella propria carne. (Col 1,24) Il sacrificio del missionario deve essere condiviso e sostenuto da quello dei fedeli. Perciò, a coloro che svolgono il loro ministero pastorale fra i malati raccomando di istruirli circa il valore della sofferenza, incoraggiandoli a offrirla a Dio per i missionari. Con tale offerta i malati diventano anch'essi missionari, come sottolineano alcuni movimenti sorti tra loro e per loro. Anche la solennità di Pentecoste - inizio della missione della chiesa - è celebrata in alcune comunità come «giornata della sofferenza per le missioni». |
|
79. La cooperazione si esprime, altresì, nel promuovere le vocazioni missionarie. A questo riguardo, va riconosciuta la validità delle diverse forme d'impegno missionario, ma bisogna al tempo stesso riaffermare la priorità della donazione totale e perpetua all'opera delle missioni, specialmente negli istituti e congregazioni missionari, maschili e femminili. La promozione di tali vocazioni è il cuore della cooperazione: l'annunzio del Vangelo richiede annunziatori, la messe ha bisogno di operai, la missione si fa soprattutto con uomini e donne consacrati a vita all'opera del Vangelo, disposti ad andare in tutto il mondo per portare la salvezza. Desidero, pertanto, richiamare e raccomandare questa sollecitudine per le vocazioni missionarie. Coscienti della responsabilità universale dei cristiani nel contribuire all'opera missionaria e allo sviluppo dei popoli poveri, dobbiamo tutti domandarci perché in varie nazioni, mentre crescono le offerte, minacciano di scomparire le vocazioni missionarie, che danno la vera misura della donazione ai fratelli. Le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata sono un segno sicuro della vitalità di una chiesa. 80. Pensando a questo grave problema, rivolgo il mio appello con particolare fiducia e affetto alle famiglie e ai giovani. Le famiglie e, soprattutto, i genitori siano consapevoli di dover portare «un particolare contributo alla causa missionaria della chiesa, coltivando le vocazioni missionarie fra i loro figli e figlie». 167 Una vita di intensa preghiera, un senso reale del servizio del prossimo e una generosa partecipazione alle attività ecclesiali offrono alle famiglie le condizioni favorevoli per la vocazione dei giovani. Quando i genitori sono pronti a consentire che uno dei figli parta per la missione, quando essi hanno chiesto al Signore tale grazia, egli li ricompenserà, nella gioia, il giorno in cui un loro figlio o figlia ascolterà la sua chiamata. Ai giovani stessi io chiedo di ascoltare la parola di Cristo che dice loro, come già a Simon Pietro e ad Andrea sulla riva del lago: «Venite dietro a me, e vi farò diventare pescatori di uomini». (Mt 4,19) Abbiano essi il coraggio di rispondere, come Isaia: «Eccomi, Signore, sono pronto, manda me». (Is 4,8) Essi avranno dinanzi a sé una vita affascinante e conosceranno la vera soddisfazione di annunciare la «buona novella» ai fratelli e sorelle che condurranno sulla via della salvezza |
|
81. Sono molte le necessità materiali ed economiche delle missioni: non solo per fondare la chiesa con strutture minime (cappelle, scuole per catechisti e seminaristi, case di abitazione), ma anche per sostenere le opere di carità, di educazione e di promozione umana, campo vastissimo di azione specialmente nei paesi poveri. La chiesa missionaria dà quello che riceve, distribuisce ai poveri quello che i suoi figli più dotati di beni materiali le mettono generosamente a disposizione. Desidero a questo punto ringraziare tutti coloro che donano con sacrificio per l'opera missionaria: le loro rinunzie e la loro partecipazione sono indispensabili per costruire la chiesa e testimoniare la carità. Circa gli aiuti materiali è importante riguardare allo spirito col quale si dona. Per questo occorre rivedere il proprio stile di vita: le missioni non chiedono solo un aiuto, ma una condivisione con l'annunzio e la carità verso i poveri. Tutto quello che abbiamo ricevuto da Dio la vita come i beni materiali - non è nostro. ma ci è dato in uso. La generosità nel dare va sempre illuminata e ispirata dalla fede: allora, davvero c'è più gioia nel dare che nel ricevere. La Giornata missionaria mondiale, diretta alla sensibilizzazione sul problema missionario, ma anche alla raccolta di aiuti, è un appuntamento importante nella vita della chiesa, perché insegna come donare: nella celebrazione eucaristica, cioè come offerta a Dio, e per tutte le missioni del mondo. |
|
82. La cooperazione si allarga oggi a forme nuove includendo non solo l'aiuto economico, ma anche la partecipazione diretta. Situa ioni nuove, connesse al fenomeno della mobilità, richiedono ai cristiani un autentico spirito missionario. Il turismo a carattere internazionale è ormai un fatto di massa e positivo, se si pratica con atteggiamento rispettoso per un mutuo arricchimento culturale, evitando ostentazione e sperperi e cercando il contatto umano. Ma ai cristiani è richiesta soprattutto la coscienza di dover essere sempre testimoni della fede e della carità di Cristo. Anche la conoscenza diretta della vita missionaria e delle nuove comunità cristiane può arricchire e rinvigorire la fede. Sono lodevoli le visite alle missioni soprattutto da parte dei giovani che vanno per servire e fare un'esperienza forte di vita cristiana. Le esigenze di lavoro portano oggi numerosi cristiani di giovani comunità in aree dove il cristianesimo è sconosciuto e, talvolta, bandito o perseguitato. Ciò avviene anche per i fedeli dei paesi di antica tradizione cristiana, che lavorano temporaneamente in paesi non cristiani. Queste circostanze sono certo un'opportunità per vivere e testimoniare la fede. Nei primi secoli il cristianesimo si diffuse soprattutto perché i cristiani, viaggiando o stabilendosi in regioni in cui Cristo non era stato annunziato. testimoniavano con coraggio la loro fede e vi fondavano le prime comunità. Più numerosi sono i cittadini dei paesi di missione e gli appartenenti a religioni non cristiane, che vanno a stabilirsi in altre nazioni per motivi di studio e di lavoro, o costretti dalle condizioni politiche o economiche dei luoghi di origine. La presenza di questi fratelli nei paesi di antica cristianità è una sfida per le comunità ecclesiali, stimolandole all'accoglienza, al dialogo, al servizio, alla condivisione, alla testimonianza e all'annunzio diretto. In pratica, anche in paesi cristiani si formano gruppi umani e culturali che richiamano la missione ad gentes, e le chiese locali, anche con l'aiuto di persone provenienti dai paesi degli immigrati e di missionari reduci, devono occuparsi generosamente di queste situazioni. La cooperazione può anche impegnare i responsabili della politica, dell'economia, della cultura, del giornalismo, oltre che gli esperti dei vari organismi internazionali. Nel mondo moderno è sempre più difficile tracciare linee di demarcazione geografica o culturale: c'è una crescente interdipendenza fra i popoli, il che stimola alla testimonianza cristiana e all'evangelizzazione. |
|
83. La formazione missionaria è opera della chiesa locale con l'aiuto dei missionari e dei loro istituti, nonché del personale delle giovani chiese. Questo lavoro deve essere inteso non come marginale, ma come centrale nella vita cristiana. Per la stessa nuova evangelizzazione dei popoli cristiani il tema missionario può essere di grande aiuto: la testimonianza dei missionari, infatti, conserva il suo fascino anche presso i lontani e i non credenti e trasmette valori cristiani. Le chiese locali, quindi, inseriscano l'animazione missionaria come elemento-cardine della loro pastorale ordinaria nelle parrocchie, nelle associazioni e nei gruppi, specie giovanili. A questo fine vale, anzitutto, l'informazione mediante la stampa missionaria e i vari sussidi audiovisivi. Il loro ruolo è di grande importanza, in quanto fanno conoscere la vita della chiesa universale, le voci e le esperienze dei missionari e delle chiese locali, presso cui essi lavorano. Occorre che nelle chiese più giovani, che non sono ancora in grado di dotarsi di una stampa e altri sussidi, gli istituti missionari dedichino personale e mezzi a queste iniziative. A tale formazione sono chiamati i sacerdoti e i loro collaboratori, gli educatori e insegnanti, i teologi, specie i docenti dei seminari e dei centri per i laici. L'insegnamento teologico non può né deve prescindere dalla missione universale della chiesa, dall'ecumenismo, dallo studio delle grandi religioni e della missiologia. Raccomando che soprattutto nei seminari e nelle case di formazione per religiosi e religiose si faccia un tale studio, curando anche che alcuni sacerdoti, o alunni e alunne si specializzino nei diversi campi delle scienze missiologiche. Le attività di animazione vanno sempre orientate ai loro specifici fini: informare e formare il popolo di Dio alla missione universale della chiesa, far nascere vocazioni ad gentes, suscitare cooperazione all'evangelizzazione. Non si può, infatti, dare un'immagine riduttiva dell'attività missionaria, come se fosse principalmente aiuto ai poveri, contributo alla liberazione degli oppressi, promozione dello sviluppo, difesa dei diritti umani. La chiesa missionaria è impegnata anche su questi fronti, ma il suo compito primario è un altro: i poveri hanno fame di Dio, e non solo di pane e di libertà, e l'attività missionaria prima di tutto deve testimoniare e annunziare la salvezza in Cristo, fondando le chiese locali che sono poi strumenti di liberazione in tutti i sensi. |
|
84. In questa opera di animazione il compito primario spetta alle Pontificie Opere Missionarie, come più volte ho affermato nei messaggi per la Giornata missionaria mondiale. Le quattro opere - Propagazione della fede, San Pietro apostolo, Infanzia missionaria e Unione missionaria - hanno in comune lo scopo di promuovere lo spirito missionario universale in seno al popolo di Dio. L'Unione missionaria ha come fine immediato e specifico la sensibilizzazione e formazione missionaria dei sacerdoti, religiosi e religiose, che devono, a loro volta, curarla nelle comunità cristiane; essa, inoltre, mira a promuovere le altre opere, di cui è l'anima. 168 «La parola d'ordine deve essere questa: Tutte le chiese per la conversione di tutto il mondo». 169 Essendo del papa e del collegio episcopale, anche nell'ambito delle chiese particolari queste opere occupano «giustamente il primo posto, perché sono mezzi sia per infondere nei cattolici, fin dall'infanzia, uno spirito veramente universale e missionario, sia per favorire un'adeguata raccolta di sussidi a vantaggio di tutte le missioni, secondo le necessità di ciascuna». 170 Un altro scopo delle opere missionarie è quello di suscitare vocazioni ad gentes ed a vita, sia nelle chiese antiche come in quelle più giovani. Raccomando vivamente di orientare sempre più a questo fine il loro servizio di animazione. Nell'esercizio della loro attività, queste Opere dipendono, a livello universale, dalla Congregazione per l'evangelizzazione e, a livello locale, dalle Conferenze episcopali e dai Vescovi delle singole chiese, collaborando con i centri di animazione esistenti: esse portano nel mondo cattolico quello spirito di universalità e di servizio alla missione, senza il quale non esiste autentica cooperazione. |
|
85. Cooperare alla missione vuol dire non solo dare, ma anche saper ricevere: tutte le chiese particolari, giovani e antiche, sono chiamate a dare e a ricevere per la missione universale e nessuna deve chiudersi in se stessa. 171 In forza della... cattolicità - dice il Concilio le singole parti portano i propri doni alle altre parti e a tutta la chiesa, di modo che il tutto e le singole parti si accrescano da tutte le altre in reciproca comunione ed aspiranti alla pienezza nell'unità... Ne derivano... tra le diverse parti della chiesa vincoli di intima comunione circa i tesori spirituali, gli operai apostolici ed i sussidi materiali». Esorto tutte le chiese e i pastori, i sacerdoti, i religiosi, i fedeli, ad aprirsi all'universalità della chiesa, evitando ogni forma di particolarismo, esclusivismo o sentimento di autosufficienza. Le chiese locali, pur radicate nel loro popolo e nella loro cultura, debbono tuttavia mantenere in concreto questo senso universalistico della fede, dando cioè e ricevendo dalle altre chiese doni spirituali esperienze pastorali, di primo annunzio e di evangelizzazione, personale apostolico e mezzi materiali. Infatti, la tendenza a chiudersi può esser forte: le chiese antiche, impegnate per la nuova evangelizzazione, pensano che ormai la missione debbono svolgerla in casa e rischiano di frenare lo slancio verso il mondo non cristiano, concedendo a malincuore le vocazioni agli istituti missionari, alle congregazioni religiose, alle altre chiese. Ma è dando generosamente del nostro che riceveremo, e già oggi le giovani chiese, non poche delle quali conoscono una prodigiosa fioritura di vocazioni, sono in grado di inviare sacerdoti, religiosi e religiose a quelle antiche. D'altra parte, esse sentono il problema della propria identità, dell'inculturazione, della libertà di crescere senza influssi esterni, con la possibile conseguenza di chiudere le porte al missionari. A queste chiese dico: Lungi dall'isolarvi, accogliete volentieri i missionari e i mezzi dalle altre chiese, e mandatene voi stesse nel mondo! Proprio per i problemi che vi angustiano avete bisogno di mantenervi in continua relazione con i fratelli e sorelle nella fede. Con ogni mezzo legittimo fate valere le libertà, a cui avete diritto, ricordandovi che i discepoli di Cristo hanno il dovere di «obbedire a Dio piuttosto che agli uomini». (At 5,29) |
|
86. Se si guarda in superficie il mondo odierno, si è colpiti da non pochi fatti negativi, che possono indurre al pessimismo. Ma è, questo, un sentimento ingiustificato: noi abbiamo fede in Dio Padre e Signore, nella sua bontà e misericordia. In prossimità del terzo millennio della redenzione, Dio sta preparando una grande primavera cristiana, di cui già si intravede l'inizio. Difatti, sia nel mondo non cristiano come in quello di antica cristianità, c'è un progressivo avvicinamento dei popoli agli ideali e ai valori evangelici, che la chiesa si sforza di favorire. Oggi, infatti, si manifesta una nuova convergenza da parte dei popoli per questi valori: il rifiuto della violenza e della guerra; il rispetto della persona umana e dei suoi diritti; il desiderio di libertà, di giustizia e di fraternità; la tendenza al superamento dei razzismi e dei nazionalismi; l'affermazione della dignità e la valorizzazione della donna. La speranza cristiana ci sostiene nell'impegnarci a fondo per la nuova evangelizzazione e per la missione universale, facendoci pregare come Gesù ci ha insegnato: «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra». (Mt 6,10) Gli uomini che attendono Cristo sono ancora in numero immenso: gli spazi umani e culturali, non ancora raggiunti dall'annunzio evangelico o nei quali la chiesa è scarsamente presente. sono tanto ampi, da richiedere l'unità di tutte le sue forze. Preparandosi a celebrare il giubileo del Duemila, tutta la chiesa è ancor più impegnata per un nuovo avvento missionario. Dobbiamo nutrire in noi l'ansia apostolica di trasmettere ad altri la luce e la gioia della fede, e a questo ideale dobbiamo educare tutto il popolo di Dio. Non possiamo restarcene tranquilli, pensando ai milioni di nostri fratelli e sorelle, anch'essi redenti dal sangue di Cristo, che vivono ignari dell'amore di Dio. Per il singolo credente, come per l'intera chiesa, la causa missionaria deve essere la prima, perché riguarda il destino eterno degli uomini e risponde al disegno misterioso e misericordioso di Dio. |
|
CAPITOLO VIII LA SPIRITUALITÀ MISSIONARIA Lasciarsi condurre dallo Spirito 87. L'attività missionaria esige una specifica spiritualità che riguarda, in particolare, quanti Dio ha chiamato a essere missionari. Tale spiritualità si esprime, innanzittutto, nel vivere in piena docilità allo Spirito: essa impegna a lasciarsi plasmare interiormente da lui? per divenire sempre più conformi a Cristo. Non si può testimoniare Cristo senza riflettere la sua immagine, la quale è resa viva in noi dalla grazia e dall'opera dello Spirito. La docilità allo Spirito impegna poi ad accogliere i doni della fortezza e del discernimento, che sono tratti essenziali della stessa spiritualità. Emblematico è il caso degli apostoli, che durante la vita pubblica del Maestro, nonostante il loro amore per lui e la generosità della risposta alla sua chiamata, si dimostrano incapaci di comprendere le sue parole e restii a seguirlo sulla via della sofferenza e dell'umiliazione. Lo Spirito li trasformerà in testimoni coraggiosi del Cristo e annunziatori illuminati della sua Parola: sarà lo Spirito a condurli per le vie ardue e nuove della missione. Anche oggi la missione rimane difficile e complessa come in passato e richiede ugualmente il coraggio e la luce dello Spirito: viviamo spesso il dramma della prima comunità cristiana, che vedeva forze incredule e ostili «radunarsi insieme contro il Signore e contro il suo Cristo». (At 4,26) Come allora, oggi occorre pregare, perché Dio ci doni la franchezza di proclamare il Vangelo; occorre scrutare le vie misteriose dello Spirito e lasciarsi da lui condurre in tutta la verità. (Gv 16,13) |
|
88. Nota essenziale della spiritualità missionaria è la comunione intima con Cristo: non si può comprendere e vivere la missione, se non riferendosi a Cristo come l'inviato a evangelizzare. Paolo ne descrive gli atteggiamenti: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce». (Fil 2,5) È qui descritto il mistero dell'incarnazione e della redenzione, come spoliazione totale di sé, che porta Cristo a vivere in pieno la condizione umana e ad aderire fino in fondo al disegno del Padre. Si tratta di un annientamento, che però è permeato di amore ed esprime l'amore. La missione percorre questa stessa via e ha il suo punto di arrivo ai piedi della croce. Al missionario è chiesto «di rinunziare a se stesso e a tutto quello che in precedenza possedeva in proprio e a farsi tutto a tutti»: 172 nella povertà che lo rende libero per il Vangelo, nel distacco da persone e beni del proprio ambiente per farsi fratello di coloro ai quali è mandato, onde portare a essi il Cristo salvatore. È a questo che è finalizzata la spiritualità del missionario: «Mi sono fatto debole con i deboli...; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Tutto io faccio per il Vangelo...». (1 Cor 9,22) Proprio perché «inviato», il missionario sperimenta la presenza confortatrice di Cristo, che lo accompagna in ogni momento della sua vita «Non aver paura.... perché io sono con te» (At 18,9) e lo aspetta nel cuore di ogni uomo. |
|
89. La spiritualità missionaria si caratterizza, altresì, per la carità apostolica, quella del Cristo che venne «per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi» (Gv 11,52) buon Pastore che conosce le sue pecore, le ricerca e offre la sua vita per loro. (Gv 10,1) Chi ha spirito missionario sente l'ardore di Cristo per le anime e ama la chiesa, come Cristo. Il missionario è spinto dallo «zelo per le anime», che si ispira alla carità stessa di Cristo, fatta di attenzione, tenerezza, compassione, accoglienza, disponibilità, interessamento ai problemi della gente. L'amore di Gesù è molto profondo: egli, che «sapeva quello che c'è in ogni uomo» (Gv 2,25) amava tutti offrendo loro la redenzione e soffriva quando questa veniva rifiutata. Il missionario è l'uomo della carità: per poter annunziare a ogni fratello che è amato da Dio e che può lui stesso amare, egli deve testimoniare la carità verso tutti, spendendo la vita per il prossimo. Il missionario è il «fratello universale», porta in sé lo spirito della chiesa, la sua apertura e interesse per tutti i popoli e per tutti gli uomini, specie i più piccoli e poveri. Come tale, supera le frontiere e le divisioni di razza, casta o ideologia: è segno dell'amore di Dio nel mondo, che è amore senza nessuna esclusione né preferenza. Infine, come Cristo egli deve amare la chiesa: «Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei». (Ef 5,25) Questo amore, spinto fino a dare la vita, è per lui un punto di riferimento. Solo un amore profondo per la chiesa può sostenere lo zelo del missionario; il suo assillo quotidiano - come dice san Paolo - è «la preoccupazione per tutte le chiese». (2 Cor 11,28) Per ogni missionario «la fedeltà a Cristo non può essere separata dalla fedeltà alla sua chiesa». 173 |
|
90. La chiamata alla missione deriva di per sé dalla chiamata alla santità. Ogni missionario è autenticamente tale solo se si impegna nella via della santità: «La santità deve dirsi un presupposto fondamentale e una condizione del tutto insostituibile perché si compia la missione di salvezza della chiesa». 174 L'universale vocazione alla santità è strettamente collegata all'universale vocazione alla missione. ogni fedele è chiamato alla santità e alla missione. Tale è stato il voto ardente del Concilio nell'auspicare «con la luce di Cristo, riflessa sul volto della chiesa, di illuminare tutti gli uomini, annunziando il Vangelo a ogni creatura». 175 La spiritualità missionaria della chiesa è un cammino verso la santità. La rinnovata spinta verso la missione ad gentes esige missionari santi. Non basta rinnovare i metodi pastorali, né organizzare e coordinare meglio le forze ecclesiali, né esplorare con maggior acutezza le basi bibliche e teologiche della fede: occorre suscitare un nuovo «ardore di santità» fra i missionari e in tutta la comunità cristiana, in particolare fra coloro che sono i più stretti collaboratori dei missionari. 176 Ripensiamo, cari fratelli e sorelle, allo slancio missionario delle prime comunità cristiane. Nonostante la scarsezza dei mezzi di trasporto e comunicazione di allora, l'annunzio evangelico raggiunse in breve tempo i confini del mondo. E si trattava della religione del figlio dell'uomo morto in croce, «scandalo per gli ebrei e stoltezza per i gentili»! (1 Cor 1,23) Alla base di un tale dinamismo missionario c'era la santità dei primi cristiani e delle prime comunità. 91. Mi rivolgo, perciò, ai battezzati delle giovani comunità e delle giovani chiese. Siete voi, oggi, la speranza di questa nostra chiesa, che ha duemila anni: essendo giovani nella fede, dovete essere come i primi cristiani, e irradiare entusiasmo e coraggio, in generosa dedizione a Dio e al prossimo; in una parola, dovete mettervi sulla via della santità. Solo così potete essere segno di Dio nel mondo e rivivere nei vostri paesi l'epopea missionaria della chiesa primitiva. E sarete anche fermento di spirito missionario per le chiese più antiche. Da parte loro, i missionari riflettano sul dovere della santità, che il dono della vocazione richiede da essi, rinnovandosi di giorno in giorno nel loro spirito e aggiornando anche la loro formazione dottrinale e pastorale. Il missionario deve essere «un contemplativo in azione». Egli trova risposta ai problemi nella luce della parola di Dio e nella preghiera personale e comunitaria. Il contatto con i rappresentanti delle tradizioni spirituali non cristiane, in particolare di quelle dell'Asia, mi ha dato conferma che il futuro della missione dipende in gran parte dalla contemplazione. Il missionario, se non è un contemplativo, non può annunziare il Cristo in modo credibile. Egli è un testimone dell'esperienza di Dio e deve poter dire come gli apostoli: «Ciò che noi abbiamo contemplato, ossia il Verbo della vita. . ., noi lo annunziamo a voi». (1 Gv 1,1) Il missionario è l'uomo delle beatitudini. Gesù istruisce i Dodici prima di mandarli a evangelizzare, indicando loro le vie della missione: povertà, mitezza, accettazione delle sofferenze e persecuzioni, desiderio di giustizia e di pace, carità, cioè proprio le beatitudini, attuate nella vita apostolica. (Mt5,1) Vivendo le beatitudini, il missionario sperimenta e dimostra concretamente che il regno di Dio è già venuto e egli lo ha accolto. La caratteristica di ogni vita missionaria autentica è la gioia interiore che viene dalla fede. In un mondo angosciato e oppresso da tanti problemi, che tende al pessimismo, l'annunziatore della «buona novella» deve essere un uomo che ha trovato in Cristo la vera speranza. |
|
CONCLUSIONE 92. Mai come oggi la chiesa ha l'opportunità di far giungere il Vangelo, con la testimonianza e la parola, a tutti gli uomini e a tutti i popoli. Vedo albeggiare una nuova epoca missionaria, che diventerà giorno radioso e ricco di frutti, se tutti i cristiani e, in particolare, i missionari e le giovani chiese risponderanno con generosità e santità agli appelli e sfide del nostro tempo. Come gli apostoli dopo l'ascensione di Cristo, la chiesa deve radunarsi nel Cenacolo «con Maria, la Madre di Gesù», (At 1,14) per implorare lo Spirito e ottenere forza e coraggio per adempiere il mandato missionario. Anche noi, ben più degli apostoli, abbiamo bisogno di essere trasformati e guidati dallo Spirito. Alla vigilia del terzo millennio tuttora la chiesa è invitata a vivere più profondamente il mistero di Cristo, collaborando con gratitudine all'opera della salvezza. Ciò essa fa con Maria e come Maria, sua madre e modello: è lei, Maria, il modello di quell'amore materno dal quale devono essere animati tutti quelli che, nella missione apostolica della chiesa, cooperano alla rigenerazione degli uomini. Perciò, «confortata dalla presenza di Cristo, la chiesa cammina nel tempo verso la consumazione dei secoli e si muove incontro al Signore che viene; ma in questo cammino... procede ricalcando l'itinerario compiuto dalla Vergine Maria». 177 Alla «mediazione di Maria, tutta orientata verso il Cristo e protesa alla rivelazione della sua potenza salvifica», 178 affido la chiesa e, in particolare, coloro che si impegnano per l'attuazione del mandato missionario nel mondo di oggi. Come Cristo inviò i suoi apostoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo, così, rinnovando lo stesso mandato, io estendo a tutti voi la benedizione apostolica nel nome della stessa Trinità santissima. Amen. Dato a Roma, presso San Pietro, il 7 dicembre - nel XXV anniversario del Decreto conciliare "Ad gentes" - dell'anno 1990, decimoterzo del pontificato. |
PER SCARICARE LA LETTERA ENCICLICA "REDEMPTORIS MISSIO " SUL TUO PC, CLICCA QUI'